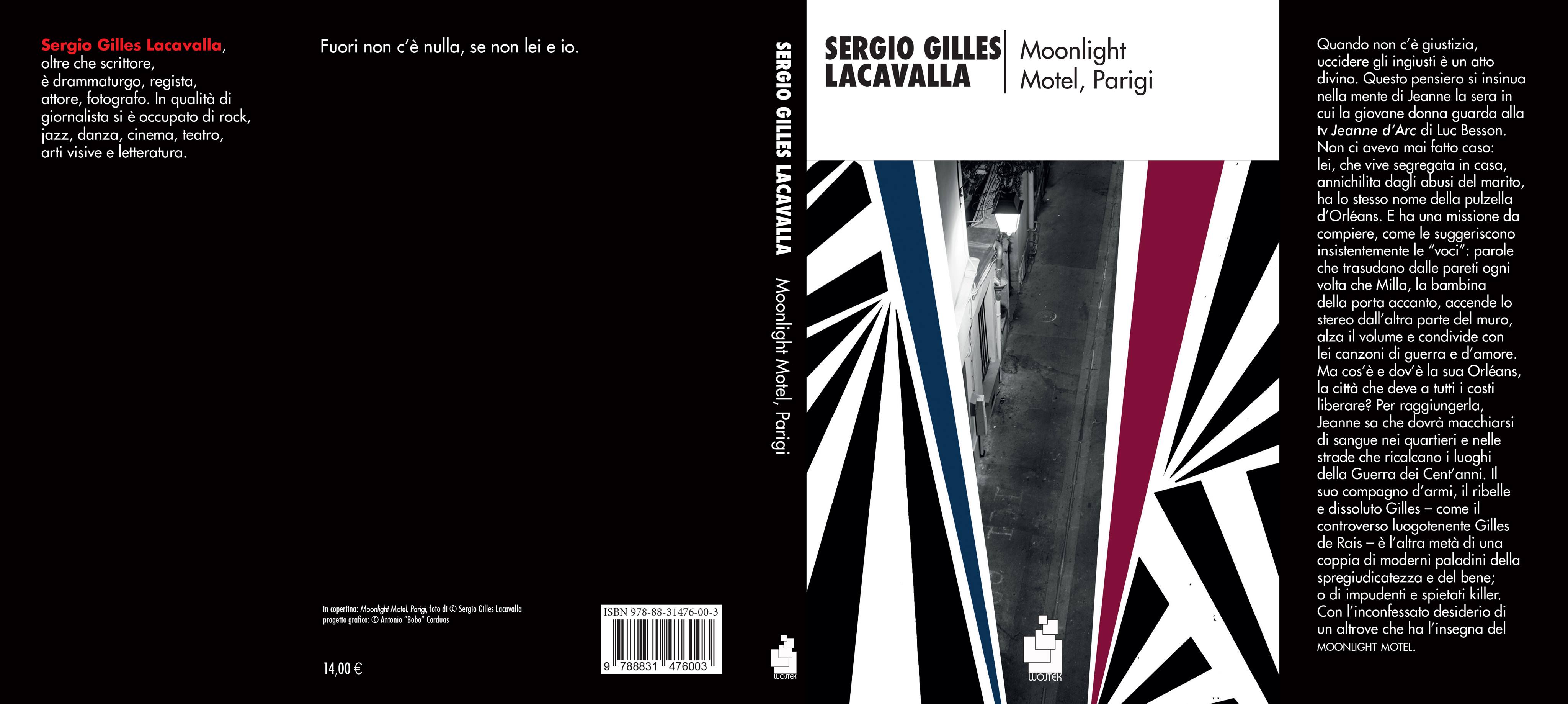
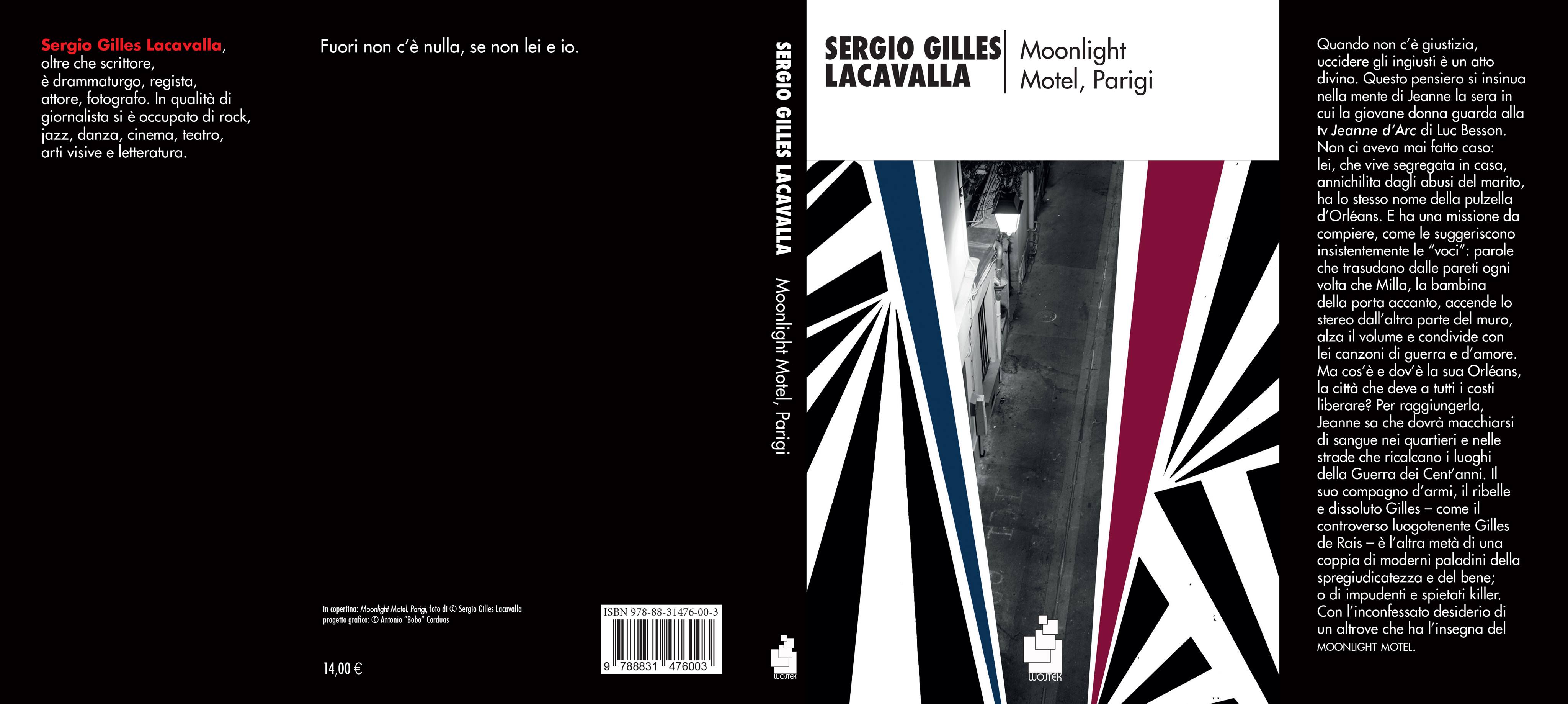

16/03/2020

Elle qui danse. Foto di Sergio Gilles Lacavalla.
La ragazza del negozio di vestiti

La ragazza del negozio di vestiti. Foto di Sergio Gilles Lacavalla.
Weimar

Weimar. Foto di Sergio Gilles Lacavalla.
Weimar

Weimar. Foto di Sergio Gilles Lacavalla.
Gambe, tatuaggi e polvere

Gambe, tatuaggi e polvere. Foto di Sergio Gilles Lacavalla.
Neon girl

Neon girl. Foto di Sergio Gilles Lacavalla.

Tutto sfocato, tranne lei. Foto di Sergio Gilles Lacavalla.

Baciami, stupida. Foto di Sergio Gilles Lacavalla.

L’ Hotel degli Amori Perduti (suicide blonde version n. 1)[1]
Nota dell’autore. Questa è una variante di “Jeanne e Gilles”. Rispetto alla precedente versione, la storia letta nel libro trovato nell’hotel riguarda Paula Yates e Michael Hutchence. Inoltre, gran parte dell’atto è interpretato da Jeanne in un lungo monologo. Gilles è lì, “così lontano così vicino”, ma parlerà solo alla fine. Come nell’altra versione, alcune scene sono sessualmente esplicite. Il corpo nudo è necessario sia per il realismo della scena, perché la scena lo prevede, sia perché il corpo nudo è di per sé un elemento di drammaturgia, non solo di regia: il corpo nudo è linguaggio, una frase, un discorso. Tutto ciò che avviene qui, è già avvenuto. Ora la scrittura si intitola “L’Hotel degli Amori Perduti (suicide blonde version n. 1)”.
Le Soldat Perdu Théâtre presenta “L’Hotel degli Amori Perduti (suicide blonde version n. 1)” di Sergio Gilles Lacavalla con Barbara Caridi e Sergio Gilles Lacavalla drammaturgia regia teatrale e video spazio scenico e fotografia Sergio Gilles Lacavalla aiuto regia Barbara Caridi editing e postproduzione video foto e grafica Ilaria Turini produzione suono Lorenzo Macinanti musiche Macelleria Mobile di Mezzanotte e Detour Doom Project.
(riservato a un pubblico adulto)
Personaggi
JEANNE PLEIADE
GILLES DUTRONC
“Stai scrivendo?”
“No, ti stavo solo pensando.”
(“Betty Blue”, Jean-Jacques Beineix / Philippe Djian)
JEANNE (Indossa una camicia e una gonna, ha le scarpe in mano. Una mano è fasciata sul palmo. Sembra sia rientrata da poco a casa e si stia spogliando. Anche Gilles è nel suo appartamento. Lui è vestito e guarda fuori dalla finestra, si muove nel suo appartamento).
“Dal momento che la vita scorre nel corso del tempo senza bisogno di creare storie, le storie esistono solo nelle storie”. Non è così? E nelle storie, tutto è al posto giusto, tutto è necessario. Ogni parola. Ogni gesto. Solo nelle storie.
L’hotel di Wenders.
Qual è il tuo stato delle cose, Dutronc?
«Scrittore e drammaturgo senza un libro pubblicato da cinque anni, forse è passato di più da un dramma rappresentato, a parte qualche reading, col sogno di fare il concorrente a Fort Boyard» era questo il tuo stato delle cose.
Lo fanno ancora? ti chiesi.
«Fort Boyard? Sì, penso di sì… o forse no… non lo so, non l’ho più visto. Non so perché… mi piaceva… insomma…»
Un intellettuale che guarda Fort Boyard. Mmm, non c’avevo mai pensato a Fort Boyard. Arrampicarsi sui muri della fortezza e gettarsi nel vuoto sopra il mare legati alle funi, risolvere gli indovinelli, restare imprigionati in una cella… sempre fradici… audaci e ridicoli. Perché no? E Les enfants du rock?
«No, quello non lo fanno più, sicuro. Era roba di quando eravamo bambini. Io un po’ meno, ma tu eri proprio una bambina».
Peccato. Ci saremmo stati bene noi due a Les enfants du rock. Intervistati da Thierry Ardisson e con la sigla di Iggy Pop, Nightclubbing. (Accenna la canzone). “Nightclubbing, we’re nightclubbing. We’re what’s happening. Nightclubbing, we’re nightclubbing. We’re an ice machine…”
Mi interrompesti. «No, quello era Lunettes noires pour nuits blanches, il programma con Ardisson. Mi sembra, non ricordo bene neanch’io».
Ah è vero! Oh che memoria!
«Eri troppo piccola. Comunque non fanno più neanche quello; sì peccato, ci saremmo stati bene a Les enfants du rock e a Lunettes noires pour nuits blanches. L’intervista verità. E il tuo, Pleiade? Il tuo stato delle cose».
Non risposi.
«Chi è? Cosa fa?» Poi mi chiedesti. Abbassai lo sguardo protetto dagli occhiali da sole. Scherzavamo, prima, ora eravamo diventati seri. D’un tratto, troppo seri. Forse lo eravamo anche prima. Fingevamo soltanto.
Entriamo, Dutronc.
Eravamo nella hall impolverata come tutto il resto. Come noi. Il tempo l’aveva impolverata. Aveva fatto lo stesso con le nostre vite. La storia qui fu interrotta, parlava di una storia interrotta, dall’esterno, il film di Wenders.
«Come la nostra», che uscita infelice.
No, senti Gilles, la nostra, se proprio la vogliamo chiamare storia, che poi non lo è mai stata davvero, la nostra, Gilles, l’abbiamo interrotta noi, soltanto noi, o forse solo tu, non lo so, ma nessuno ha colpa se non noi, con chi vuoi prendertela?
Dai, lasciamo stare.
(Sembra che Jeanne passi le dita di una mano su una poltrona della hall, se le guarda e le mostra a Gilles, che si è avvicinato, anche se lei sembra non vederlo. Eppure gliele mostra, sporche di polvere e sabbia).
È rossa.
«È polvere mista a sabbia. Viene dal deserto», mi spiegasti.
(Lui le pulisce le dita con le sue. Le tiene la mano. Lei non lo sente. Jeanne si guarda anche la pianta di un piede, polvere e sabbia rosse anche lì. Le scarpe le ha poggiate a terra).
«È dietro di noi, il deserto, lo senti il vento?»
(Jeanne fa no scuotendo la testa).
Ma io non sentivo niente. O forse viene da un altro pianeta, come questa luce, la luce di un altro pianeta, o dopo un’esplosione nucleare.
(Mi tolsi gli occhiali scuri. Li buttai su una poltrona).
“Guarda: senza gli occhiali da sole, senza i guanti di plastica, siamo noi i veri sopravvissuti”.
Sopravvissuti a cosa?
Non lo so… forse a noi… forse agli altri.
«Hai gli occhi verdi».
Sono le lenti: i miei sono sempre azzurri.
Vedi? Gli occhi di bosco.
«Gli occhi di storie» li chiamavi così, i miei occhi: gli occhi di bosco, gli occhi di storie.
(Gilles le accarezza la mano sopra la fasciatura, fa una lieve pressione, Jeanne ha una leggera smorfia di dolore e gli toglie la mano dalla sua).
«Sempre la mano… sempre nel sonno, oppure quando…»
(Scrollai le spalle, non risposi a quella domanda, e che importava, ormai era più che altro un’abitudine, avevo poggiato le scarpe a terra, le ripresi e le misi su un tavolinetto davanti a una finestra che dava sulla spiaggia e il mare di uno strano grigio come il cielo. Portai un piede sul tavolo dove mi ero messa seduta).
«Come te la sei fatta questa?»
(Gilles prende la caviglia della gamba di Jeanne sollevata sul tavolino e le tocca delicatamente una piccola cicatrice).
Mi carezzavi la cicatrice sulla caviglia. La conosci da sempre e me lo chiedi solo adesso.
(Gilles le tiene il piede).
Nuotando, tanto tempo fa, ormai. Avevo poco più di vent’anni, stavo uscendo dall’acqua della piscina, dopo aver fatto alcune vasche, poche per la verità, e avevo il fiato spezzato come non mi era mai successo prima, ma era da tanto che non mi allenavo. Sulla scaletta di ferro, mi sentivo senza più nessuna forza, davvero niente, niente e… sono scivolata come una stupida, ferendomi qui. (Si tocca sulla cicatrice spostando appena le dita di Gilles, che ora le accarezza il piede. A volte glielo bacia).
L’acqua era tutta rossa, sembrava chissà che, e io stavo lì fissa a guardare il mio sangue che si apriva lento e quasi morbido e mi veniva da piangere. Poi, infatti, ho pianto. Il dottore mi medicava e io piangevo, non è niente, mi diceva, stai calma che non è niente, non piangere, mi ripeteva, ma lui non capiva, io non piangevo per il dolore e il taglio, no, piangevo per quel gesto scomposto sulla scaletta, per il fiato corto. Piangevo perché all’improvviso mi ero accorta che stavo cambiando e io non volevo cambiare. Il fiato corto mi diceva che se alle cose non stai dietro, se le lasci andare così, cambiano, e tu con loro, tutto qui. No, io non volevo cambiare… ma, come si fa… e non volevo che le cose finissero, non l’ho mai voluto. Non lo accetto. Anche se una cosa non mi piace, non voglio che finisca.
(Guarda fisso Gilles, anche se continua a non vederlo, pare avvertirlo però, e gli toglie piano la mano dalla sua caviglia, che lui ha ripreso ad accarezzare. Poi dirige lo sguardo verso la sala bar poco più in là. La indica. In realtà indica il tavolinetto degli alcolici nel suo appartamento).
Lì c’è il bar.
(Si toglie la gonna. Va a versarsi da bere. È come se fosse dietro il bancone del bar. In realtà ci sono solo alcune bottiglie su un tavolinetto. Passa in rassegna le bottiglie di alcolici). C’è ancora del liquore.
(Ne prende una, la posa. Un’altra. La mostra a Gilles).
Martini bianco?
«Va bene».
Ricordavo che ti piace la vaniglia. E poi, va bene, poco alcolico.
(Guarda i bicchieri allineati, coperti di polvere e sabbia).
I bicchieri… sono pieni di polvere anche loro. Aprii il rubinetto per lavarne due, ma non c’era acqua.
Non c’è l’acqua, ti dissi. Mannaggia. Va be’, dai.
(Apre la bottiglia e si mette seduta su una sedia davanti al tavolino. Gilles si è seduto davanti a lei. Jeanne assaggia il liquore).
È ancora buono. “Martini girl. Oh yeah”. (Accenna la canzone di Macelleria Mobile di Mezzanotte. Manda giù un sorso più lungo di liquore. Passa la bottiglia a Gilles. Anche Gilles ne beve una lunga sorsata. Poggia la bottiglia sul tavolo mentre Jeanne allunga un braccio verso di lui lasciandosi andare giù fino a toccare con la tempia, lo zigomo e la guancia il tavolino. Gilles le prende la mano. Gliela bacia. Jeanne chiude gli occhi). Martini girl.
(Anche Gilles si abbassa sul tavolo portando il viso vicino a quello di Jeanne. Jeanne apre gli occhi, lo guarda, Gli soffia sul viso).
(Gli soffio leggermente sulla faccia).
Martini girl, alito di vaniglia e alcol (lo bacia).
(Gli do un lieve bacio sulle labbra, stringendo di più la sua mano).
Bacio al Martini.
(Resta ancora seduta al tavolino. La mano ancora tesa verso di lui, che non c’è più. Gilles è tornato nel suo ambiente. Il viso di Jeanne ancora poggiato sul tavolo. Si alza). Tante stanze e tutte vuote. Tutte aperte. Tutte abbandonate, come se fosse successo qualcosa all’improvviso e sono scappati tutti.
(Si siede sul letto e prende un libro dimenticato sul comodino: un volume che parla della dissoluzione del rock’n’roll, dalla copertina nera come la notte dei crimini dell’anima. Con quattro segnaletiche. Pieno di storie d’amore finite male. Fa caso alla data di edizione).
Guarda, Gilles, qualcuno deve essere stato qui poco tempo fa, questo libro è recente.
(Lo apre dove c’è un segnalibro, comincia a leggere).
“Alla loro bambina, Michael e Paula, avevano dato un nome da paradiso esotico: Heavenly Hiraani Tiger Lily. Perché era il Cielo Divino nuovo e limpido arrivato a soffiare via quello pesante e plumbeo messo sopra la loro unione da Bob Geldof. Almeno così doveva essere. Invece il Cielo azzurro un giorno si sarebbe coperto delle nuvole peggiori per una bambina. Paula Yates alla fine non si faceva più neanche la tintura sui suoi capelli finto biondi, non si truccava più. La presentatrice più trendy della televisione inglese, l’ultima delle groupie very charmant, quella che presentava negli anni Ottanta su Channel 4 il programma cult The Tube, sembrava invecchiata di dieci anni da un giorno all’altro. Sempre strafatta di droghe con amanti che le servivano solo per rilassarla un po’ quando la testa le tirava troppo per tutto quel dolore che le si muoveva dentro e le spingeva le pareti dei ricordi. Pezzi di passato come vomito di una bevuta eccessiva o di un’overdose che purtroppo non riusciva a rendere confusi malgrado la sua roba da farmacia e pusher e boy che gliela davano prima di scopare senza neanche fargliela pagare (o facendogliela pagare anche troppo cara – lei era la ricca protagonista della televisione e la donna di due rockstar). Nessuno però le regalava più i vestiti alla moda da farsi inquadrare in TV. Lei in TV non ci andava più. E quando Heaven la chiamò, il 17 settembre del 2000, nella mattina gonfia di nubi come gli occhi della mamma, Paula era nuda sul pavimento della camera da letto della sua casa di Notting Hill, il corpo trascurato, sporco di vomito come la bocca, il seno di due misure in più rifatto per piacere ancora di più a Michael, vomito anche sui capezzoli, e non rispose. Era già successo che Paula non rispondesse a sua figlia. Quella volta però non era Tiger Lily ma una delle tre bambine avute dal suo ex marito Bob Geldof, Peaches Honeyblossom. La ragazzina di nove anni fu trovata in strada fuori casa in lacrime perché la madre non le apriva: aveva avuto un collasso per un’overdose da barbiturici. Per quell’episodio il giudice dei minori aveva riaperto la pratica per la custodia delle bambine. Si dice che l’avesse chiesta Bob Geldof che non aveva mai accettato che lei l’avesse lasciato per il cantante degli INXS e si tenesse le figlie. Adesso era domenica, il tribunale era chiuso, gli assistenti sociali a casa con le loro famiglie ed era il decimo compleanno della terza figlia avuta con Geldof, Pixie. Non le aveva comprato nessuna torta”.
Suicide blonde. Mi bruciano gli occhi e non ci vedo bene. (Si strofina l’occhio, quello che doveva essere senza la lente. Posa il volume sul letto).
Me la ricordo lei a The Tube, che ti credi, abbiamo solo otto anni di differenza io e te. Sì, era bella e chic. (Pausa). Michael Hutchence c’è stato a Les enfants du rock. Mi sembra. E anche a Lunettes noires pour nuits blanches. O forse a nessuno dei due. Di certo a The big breakfast, devo ricordarlo lì, sì, fu lì che si conobbero. Lei sempre biondissima. Lui l’aveva di certo già vista in Tv. Forse già pensava a lei. Suicide blonde.
(Pausa).
Mi dicesti, toccandomi i capelli, «Sei bionda anche tu». Sì, certo. Guarda, ho anche un po’ di ricrescita. Ma chi se ne frega.
A Lunettes noires però c’è stato Andrzej Żuławski; no forse anche lui era in un altro programma, in ogni caso litigò con Ardisson, un’altra trasmissione di Ardisson, che gli chiedeva di Sophie Marceau, riguardo il suo film del momento, La fidélité. La metteva sul personale: quanto c’è di autobiografico nella pellicola? L’ha tradita? E cose di questo tipo, detestabile… L’hai visto?
«No» mi dicesti.
Żuławski chiuse la discussione andandosene. Anche se una volta lo sentii parlare male della sua ex moglie, di Sophie Marceau.
«Non erano sposati».
Ne sei sicuro?
No. Non lo conoscevi poi così bene.
Va be’, è uguale. Diceva che era un’ignorante, che quando l’aveva conosciuta era davvero un’ignorante, non aveva mai letto un libro in vita sua, disse. Ed era maleducata, volgare, non si lavava. Sai, lui il grand’uomo che veniva da una famiglia di letterati. Così civilizzato e colto. Ma il suo era solo rancore. Era evidente: ormai era invecchiato e stava morendo. Poi fece un gran sorriso.
(Pausa).
Eppure mi è dispiaciuto quando è morto. Tu lo hai più visto?
«Un paio di volte. L’ultima era a Parigi per il montaggio di Cosmos». Gli regalasti un tuo libro. Gli scrivesti una dedica e lui si commosse. Mi hai detto che si commosse.
Cosa ci avevi scritto?
Non lo ricordavi, ma doveva essere qualcosa che riguardava il suo essere stato un po’ un maestro per te, almeno un tempo deve essere stato così, una cosa del genere. Forse sembrava un addio. Sì, anch’io lo trovai invecchiato. E debole. Indifeso. Malato.
Che fine malinconica: senza più la donna della sua vita, pieno di rabbia ma pure di rassegnazione. L’uomo sicuro di un tempo ora rideva sperduto. Con un ultimo film che per lui era stato un errore. Fatto con pochi soldi e tanti compromessi. Non ne voleva parlare. Ma Cosmos non è piaciuto neanche a me. A te è piaciuto?
No, non era piaciuto nemmeno a te.
Morto con ancora in testa le immagini della prima moglie che se ne era andata neanche due anni prima dopo una vita di follia, così diceva lui: che era pazza. Raccontava che una sera rientrò a casa e trovò suo figlio da solo, tutto sporco di marmellata, perché lei l’aveva abbandonato inseguendo un suo delirio mistico. Diceva che era ispirato a lei il personaggio di Isabelle Adjani in Possession. Ma questa storia dovresti conoscerla meglio di me. Probabilmente non era vero niente. Chissà se è andato al suo funerale. Non credo. Disprezzava sempre chi lo aveva lasciato. E mentiva. Anche lei era molto bella. Capelli biondi lunghi e lisci e grandi occhi chiari. Anche lei era un’attrice. Morire sbagliando. Sbagliando tutto.
«Però L’amour braque lo riscatta da ogni errore» dicesti.
Sì, è vero. È un film bellissimo. E anche loro erano bellissimi e innamorati all’epoca.
(Pausa).
(Faccio colare dalla mia bocca un filo di saliva su due dita della mia mano e le appoggio sulle sue labbra. Gilles le lecca. Con le dita umide gli seguo il contorno della bocca, poi quello degli occhi. Lui abbassa lo sguardo).
L’hai ascoltato il disco degli Spiritual Front? Sì, quello intitolato Amour braque. No, vero? … Mmm, già, capisco…
(Pausa).
Dovresti, è molto bello e… in copertina ci sono due amanti nudi, lei è nuda del tutto, lui indossa un paio di pantaloni neri. Lei è sdraiata su un letto, le lenzuola bianche, le gambe aperte, punta un coltello sull’addome di lui, che le è sopra, gli porge la lingua. Anche lui ha un coltello, tenuto nascosto dietro la schiena… Una mano serra un pugnale con un teschio sull’impugnatura, lo stringe sulla lama, intorno c’è un cuore fatto di filo spinato, la scritta Amour braque…
Non mi hai mai vista con una maglietta degli Spiritual Front, è strano, no?
Ci sto bene, sai? La mia preferita è quella di Open wounds, con i due amanti che si baciano puntandosi i coltelli alle schiene. Ancora coltelli. Anche qui.
(Pausa).
«Ricordo una tua carezza a un loro concerto. Mi passasti vicino e mi sfiorasti con la mano il viso» mi hai detto. «Ma non credo che tu la ricordi».
Invece sì. Perché non dovrei ricordarla? E ricordo anche che mi allontanai dall’altra parte del locale. Aspettando che tu mi cercassi tra il pubblico per restituirmela. O un bacio sulla guancia. Ma tu non ti spostati da lì.
(Pausa).
Mi dicesti che tutto era stato catturato da quella carezza. Ricordavi questo. Di quella sera ricordavi la mia carezza e nient’altro. Ricordavi che non sapevi che fare. Mi hai detto che ricordavi che non volevi che quell’azione finisse in un errore. Eri capace di affrontare chiunque, di notte, in un quartiere malfamato. E avevi paura di sbagliare una carezza. Di dirmi…
(Pausa).
“È più facile uccidere quando non riesci più ad abbracciare”. Era in un tuo libro.
(Pausa).
Io sono più coraggiosa di te.
(Pausa).
Sì, lo sono sempre stata.
(Pausa).
O forse lo ero. Comunque se non fosse stato per il mio coraggio…
E a cosa è servito? Ad avere dei ricordi. Ad avere dei ricordi, Gilles. Magari un po’ confusi. A tratti sbagliati. Ma ricordi. Per essere qui. Ancora qui. In questo niente. In questo tutto. Con il mare, la luce strana e la sabbia rossa.
(Pausa).
Dai, continua a leggere, per favore.
(Pausa).
(Riprende il libro e legge). “Pure se l’amava ancora. Per anni Geldof non riuscirà più a fare niente prostrato da quel rapporto andato così male. Racconterà tutto, quando il dolore più stordente sarà passato, in un disco pieno d’amarezza, Sex, age and death, in cui una canzone, Inside your head, dice: Ti sei presa l’oro, a me è rimasto il piombo / ti sei presa il succo e mi hai lasciato la buccia / ti sei presa il palazzo e io ho avuto la baracca / ti sei presa la vita, mi hai lasciato la morte. La separazione legale nel 1996 affidava Fifi Trixibelle, Peaches Honeyblossom e Pixie a Paula. Si dice che proprio il fatto che lei non vuole fargliele vedere fosse il motivo più forte degli ultimi litigi tra loro due. Avevano litigato anche quel giorno. Gridavano. Poi Michael l’aveva chiamata. Qualcuno riferisce di aver sentito urlare anche lui al telefono. Geldof stava rendendo la vita difficile a quella relazione quasi con metodo. Forse lei piangeva. Forse aveva ripensamenti. Forse gli rinfacciava quella scappatella con la modella ventitreenne Carolina Rorich avuta pochi mesi prima e Michael continuava a dirle che erano solo cazzate dei giornali. La conosceva appena. Diceva. E poi lei piangeva ancora, ancora per l’ostilità di Bob. Forse. Forse i genitori di Michael non vedevano di buon occhio il loro legame e facevano pressioni sul proprio figlio perché la lasciasse e si tenesse la piccola Heaven di sedici mesi. Sembra che il padre di lui, Kel Hutchence, non volesse che quella bambina vivesse con una donna come Paula: lei era quella sposata, quella che andava con tutti, quella che aveva posato nuda per i giornali. Lui però le aveva spedito delle rose rosse. Le aveva indirizzate anche alla sua piccola bambina. Il bigliettino diceva: «Alle mie splendide donne, con tutto il mio amore. Michael». Forse avevano parlato soltanto al telefono senza tanti drammi e si erano detti «Ti amo» alle 5 e 30 del mattino, ora di Sydney, dove lui stava incidendo il suo disco solista. Poi non si sarebbero più sentiti. Poco dopo, Michael Hutchence l’avrebbe lasciata sola per sempre impiccandosi con la cinta dei pantaloni nella suite 524 al quinto piano del Ritz-Carlton Hotel, il 22 novembre del 1997. Dopo tre anni Paula stava per raggiungerlo. Anzi, c’aveva già provato nel 1998 tentando di soffocarsi come il suo Michael con una cintura”.
Ma dove stai leggendo? Non era lì, hai saltato le pagine, dà qua, lasciamo stare, va, che è meglio. Dai. È troppo triste questo libro, poi un albergo e… gli hotel sono maledetti.
(Toglie con delicatezza il libro dalle mani di Gilles e lo rimette sul comodino. No, non gli toglie nessun libro dalle mani, è lei a posarlo. Prende un pacchetto di sigarette e se ne accende una).
Vuoi? (Gli porge la sigaretta dopo una boccata. La porge al vuoto. Fa di no con la testa). Già, non fumi.
Non ti piace.
Neanche a me. Giusto una ogni tanto. Vedi, è un pacchetto da dieci. (Fa ancora un paio di tirate e spegne la sigaretta su un posacenere sopra il comodino).
Lei fumava tanto, si drogava e fumava. Dovremmo cercare un altro modo per morire.
(Pausa).
Eppure è una bella storia, quella tra Paula Yates e Michael Hutchence, rischiare tutto, così, per un amore.
(Pausa).
No, è orribile (dice abbassando il tono della voce, quasi un sussurro, scuote la testa).
(Pausa).
(Rialza il tono della voce). Un libro interrotto e dimenticato, un letto non riordinato, e sì, sembra proprio che chi era qui sia scappato all’improvviso… erano due, come noi. Scappare – scopare. (Sorride).
Che stupido gioco di parole, eh Gilles? Ma se ci pensi, non è poi così stupido, no? Adesso abbiamo un posto dove stare: lontano da tutti. Anche da noi. Scappare – scopare.
(Si mette giù sul letto).
Guarda che strane ombre. (Fa osservando il soffitto).
Che ci facciamo qui? Eravamo noi due, quei due, vero? Non mi ricordo quasi più niente. Ma adesso va bene così.
(Si rimette seduta e apre la camicia di Gilles. Gli accarezza il torace. No, è solo Gilles ad aprirsi la camicia).
Ti depili intorno ai capezzoli e sul petto, come una ragazza lo fa sulle gambe e sotto le ascelle, a volte sul pube, io il pube non lo depilo mai: hai la pelle liscia di una ragazza.
E come una ragazza, i tuoi capezzoli s’inturgidiscono.
Ti depili anche le ascelle. Hai sempre un bel corpo, Gilles. Continui ad allenarlo, vedo. Tiri ancora di boxe?
Già. È importante avere un bel corpo, ti protegge un po’ dalla solitudine: ti guardi allo specchio, ti senti e… un bel corpo è sempre un corpo in attesa… è importante… ma c’è anche qualcosa di triste in questo.
(Ora Jeanne apre la sua camicia e si guarda il seno nudo; senza alcun sostegno del reggiseno).
Dovrei fare qualcosa anch’io, sto perdendo tono e sono molla sulla pancia. (Si osserva l’addome con qualche piccola piega dalla posizione).
(Gilles mi accarezza il seno indugiando sui capezzoli che cominciano a ingrossarsi e indurirsi, poi la pancia).
Sono bella così? Molla?
«Così».
Comunque ho ripreso a correre, e ora va un po’ meglio. Tocca (si tocca l’addome).
(Gilles s’inginocchia, mi solleva la gonna e mi toglie gli slip bianchi – Jeanne si sfila gli slip –. Gli poggio un piede sulla spalla e lui mi accarezza il sesso, comincia a leccarmelo mentre lo fisso. Mi tocca anche il piede).
Sei bellissimo, Gilles, quando mi lecchi.
«Sei bella come un film di Bertolucci».
(Mi dice staccando appena la bocca dalla mia fica umida tra i peli folti e alzando lo sguardo).
Antonioni, Gilles… era Michelangelo Antonioni, ora sei tu a non ricordare. Non ricordiamo niente… Philippe Garrel. I baci di soccorso. Senza quei baci, quando Nico morì, lui tentò il suicidio. Senza i baci. Senza soccorso.
(Gilles mi guarda in faccia ancora per qualche istante e riprende ad accarezzarmi il sesso. Lo bacia. Mi infila piano un dito nella vagina, la strofina in profondità e seguita a leccarmi. La clitoride. Le labbra. Continuo a guardarlo. A osservare quell’azione su di me che mi ricorda l’amore).
Non mi piace Antonioni: troppo sfacciatamente poetico. Vanno di moda gli occhi, non è ridicolo? Mi fanno male i capelli, ridicolo. E poi la poesia non esiste.
(Gilles non smette di leccarmi e di penetrarmi, ora con due dita. Una, dell’altra mano, è nell’ano. Continuo a fissarlo).
«Allora sei bella come una canzone di Nick Cave».
E questa in che film era?
«In nessun film. Romantiche, malinconiche, avvolgenti, umide e assassine. Le sue canzoni. Le tue poesie». Le mie poesie, già.
(Gilles riporta la bocca sulla mia fica. Lascio uscire un po’ di pipì, solo un po’, poche gocce incerte, poi, piano il mio piacere. Gilles mi lecca ancora, bevendomi. Una poesia umida).
La poesia. No, non esiste… e se esiste, dà solo fastidio, è finta, inutile, un inganno. (Si lascia andare di nuovo giù, guarda ancora il soffitto. Porta un piede sul letto, vicino al pube).
Nick Cave era nel Cielo sopra Berlino. “Vi parlerò di una ragazza”. Avrei voluto essere una trapezista. Illudendomi di volare mentre cadevo dal trapezio nel vuoto.
O dall’insegna del Million dollar hotel.
«Mi piace quando cammini a piedi nudi» mi dicevi sempre.
(Gilles mi accarezza il piede che sfiora il mio pube, ha tolto il dito dall’ano, senza smettere di leccarmi e accarezzarmi il sesso). Le scarpe, i tacchi a spillo, che idiozia, che follia, per troppo tempo non mi hanno fatto sentire la terra dove camminavo. Camminare scalza sporcandomi i piedi della polvere di un altro pianeta.
Di questo posto nel nulla… Zabriskie Point. Bum! From here to eternity. From her to eternity. Da qui all’eternità. Da lei all’eternità.
Un’esplosione, e tutto finisce, così. Finire adesso… mentre scopiamo: scappare – scopare, vedi che ha un senso?
(Jeanne si toglie anche la camicia. Ora è nuda. Seduta. Gilles le si avvicina. Le sfiora la schiena. Il seno. L’addome. Si poggia con la testa sul suo pube. Le labbra della sua bocca su quelle vaginali di Jeanne in un languido bacio. Lei non si accorge di niente. Lui non è lì, per lei. Come sempre. Solo in un breve momento pare sentirlo davvero, allora si piega su di lui. I suoi capelli lunghi vanno a toccare quelli corti di lui. Si sta masturbando. Lui le lecca il sesso. Poi lei si srotola lentamente la fascia dalla mano).
(Gilles sente sempre più il sapore del mio piacere sulla sua bocca. Forse non l’ha mai dimenticato, questo sapore. Quest’odore forte. Che impregna l’aria e i nostri ricordi a volte scordati apposta, altre perché così succede. Leccarmi tenendomi le labbra aperte, vuol dire ricordare. Esce languido. A volte è lattiginoso, denso. Poi più liquido e trasparente. Mi giro e mi inginocchio sul letto. Lascio scivolare le mani in avanti sulle lenzuola abbassandomi con il busto, facendo aderire i seni al letto. Siamo entrambi nudi. Gilles mi apre i glutei morbidi e mi lecca l’ano con un po’ di peli intorno, mi rimette un dito dentro il culo, che io lascio cedere. E ancora nella fica. La dischiude e la lecca strofinandomi la clitoride. Penetrandomi forte con due dita unite. Il rumore dello sfregamento sembra fortissimo: annulla il silenzio, lo amplifica. Sono inginocchiata come in una preghiera per questo amore, per questo momento che somiglia all’amore. Porto la mano dietro prendendo il membro rigido di Gilles, gli tolgo le dita bagnate e me lo metto dentro la vagina. Lui mi scopa solo qualche secondo, forse un minuto, forse alcuni minuti, non capisco, tra l’attimo e l’eterno, ed esce. Glielo riprendo e lo dirigo sul mio ano umido. Inculami, gli dico. Mettimelo nel culo. Gilles entra piano ma fino in fondo, fino all’intestino. Rimane immobile. Poi si muove, sono ancora pochi secondi, forse ancora un minuto, forse qualche minuto. Cerco di serrare l’ano per tenerlo in me. Lui esce. Mi volto, siamo inginocchiati uno di fronte all’altra, gli tengo il sesso e mi sdraio, le mie gambe aperte, la mia mano lo porta ancora nella mia fica, lui mi afferra i piedi e riprende a scoparmi, li stringe forte, i piedi, stringo la mia vagina sul suo pene, sono fradicia, il suo cazzo scivola fuori e Gilles si sdraia sul letto, allora gli riprendo il sesso, lo masturbo, e mi masturbo, lo porto nella mia bocca, ha il mio odore, il mio sapore, lo succhio, carezzandomi la clitoride, ancora non capisco se per pochi secondi, un minuto, forse di più, poi mi metto sopra di lui rinfilando il suo membro nella vagina sempre più fradicia, sempre di più, è un mare che cola sul suo cazzo, un ginocchio è sul letto, un piede sulla sua spalla, è una posizione scomoda, come il nostro amore, sembriamo un quadro di Egon Schiele, lui fa per togliermi da sé, ma lo blocco con le mani sul petto, con durezza, faccio no con la testa. No, ti prego no. Adesso no. E ripeto):
In una storia, ogni parola, ogni gesto, tutto deve essere al proprio posto, tutto necessario… (Sussurra). E questa è la nostra unica storia, gesti necessari. Solo questi gesti. Queste azioni. Belle, intime, naturali, facili, difficili, scomode.
(Pausa).
Leccami il piede.
(Gilles lo fa togliendo il mio piede dalla sua spalla, mentre continua a penetrarmi nella fica. Sono quasi immobile sopra di lui. Lo guardo incantata mentre la sua lingua mi lecca la pianta e le dita, lasciate rilassate tra le sue labbra. Non si cura della polvere. Della sabbia sul mio piede. Rimaste lì, attaccate alla pelle. Le sue labbra si macchiano di rosso, la sua saliva sulle dita. Ora contratte. Non porto lo smalto sulle unghie. La mia fica cola).
Adesso la bocca.
(Porto il piede indietro e mi abbasso su Gilles fino a baciarlo. È un bacio lungo, pieno di saliva).
I baci di soccorso.
(La saliva per medicare. Poi levo il sesso di Gilles dal mio e, voltandomi, mi porto con il sedere e la vagina sul suo viso).
69 mon amour.
(La mia bocca soffia questa frase sul suo membro, in un sorriso, e torno a succhiarlo, facendo aderire il più possibile le mie labbra al suo sesso rigidissimo, duro come l’alfabeto tedesco. Il mio culo con i glutei dischiusi si abbassa ancora un po’ sul suo volto, sulla sua bocca. Gilles mi lecca sia l’ano sia la vagina; entrambi palpitano, la fica continua a depositare sulla sua lingua liquido di piacere che si fa sempre più abbondante. Sempre di più. Gli cola ai lati della bocca. Il suo sesso sa ancora di me. Sempre di più. Mi giro di nuovo e mi rimetto sopra di lui).
Infilami ancora un dito nel culo, mentre mi scopi.
(Gilles mi penetra l’ano col dito, mentre mi muovo piano sopra di lui. Il suo pene immerso nel mio sesso. Piantato come a non voler più uscire da lì. Aumento il movimento e ora mi strappo la fascia dalla mano, me la mordo, come sempre, come sempre per riaprirmi la ferita. Il membro di Gilles sta per venire in me, lo sento. Io sto seguitando a venire su di lui, adesso con violenza. Ma Gilles, d’un tratto, mi toglie con forza da sé e, girandosi, eiacula abbondante e irrefrenabile sul lenzuolo. Cado sul letto, è un precipitare senza nessun appiglio. Lo guardo, masturbandomi seduta, con rabbia e disperata frenesia, con la mano insanguinata, per finire di venire con lui. Gli occhi lucidi, bagnati. Se è possibile, più della mia fica, adesso bagnata anche di sangue. Arrabbiata e confusa gli dico):
Perché? Eh? Ti ho chiesto perché? Volevo che mi venissi dentro… lo sai… tu non hai mai voluto niente da me, niente!
(Pausa, respira con affanno).
Oppure… ma che hai fatto in questi anni? Non rispondesti.
Dio, Gilles. No, no, no Gilles.
(Jeanne comincia a piangere).
(Tu sei solo capace di abbassare la testa senza dire nemmeno una parola. Piangi con me. Una volta mi mandasti un messaggio di auguri, era il mio compleanno, e io ti scrissi che ti regalavo le mie lacrime. Erano lacrime belle, di gioia. Avevano un buon sapore. Mi rispondesti che le avresti conservate nella scatolina delle cose meravigliose – per un istante accenna un sorriso, continuando a piangere –, mischiandole alle tue. Ma non abbiamo mai pianto insieme. Se solo ne fossimo stati capaci. Se solo le tue lacrime si fossero realmente mischiate alle mie. Sulle labbra. Se solo ne avessimo assaggiato il sapore. Forse ci saremmo salvati. Piangi con me. Ma è inutile. Tieni la testa abbassata. E io piango anche per te. Perché io sono più coraggiosa).
(Jeanne non piange più. Si rifascia la mano, cambiandosi la fascia, dopo essersi disinfettata la mano: la fascia di prima era sporca. Si rimette la camicia. Gilles è tornato nel suo appartamento).
Viene dal deserto, questa polvere. Solo dal deserto. Il deserto dietro di noi.
Non mi piace più questo posto.
(Si chiude la camicia. Si rimette le mutandine).
La luce ora è rossa come la polvere perché quello è un altro pianeta. E questo non è neanche l’hotel di Wenders.
Qual è il mio stato delle cose?
(Alza le spalle, non risponde). Questo me lo prendo. (Prende il libro, ne legge un ultimo frammento, come per distrarre Gilles da quella domanda a cui non vuole rispondere, a Gilles che non c’è, o forse per ricordargli in che situazione si stavano mettendo):
“Da quel giorno le sue pillole erano diventate da leggenda. Come caramelle alla menta e miele quando hai il mal di gola. Aveva provato a disintossicarsi, era entrata e uscita dalla clinica, ma solo per tenersi le bambine. Non aveva nessuna intenzione di stare bene (aveva anche scoperto di non essere figlia del telepredicatore Jess Yates di Stars on sunday, rubrica su ITN, ma di Hughie Green della trasmissione televisiva della BBC Opportunity knocks, ma che gliene fregava ormai). Ha ancora qualche amante celebre, tipo il cantante Finley Quaye e l’attore Marc Warren, che lascia subito, non può più amare nessuno. Era diventata pazza, dicevano. La sera prima la videro vagare a piedi nudi, ubriaca, per Notting Hill. I piedi sporchi d’asfalto e depressione. Sosteneva che Michael l’avessero ucciso. «Lo hanno ammazzato», ripeteva. «È stato Bob, io lo so; perché non volete credermi?» Diceva. Michael Hutchence si era suicidato e non capiva il perché (o magari lo sapeva così bene da essere andata fuori di testa – magari non era mai stata così lucida come in quel momento). Nessuno però lo ha mai capito davvero. Bastavano quelle difficoltà nella loro relazione per giustificare un suicidio? Michael e la sua band erano in un periodo felice, era uscito quell’anno un altro disco degli INXS, Elegantly Wasted, che li aveva tirati fuori da una leggera crisi attraversata nei Novanta (certo non era il successo di Kick del 1987, ma era comunque roba da chart), aveva un progetto a suo nome, una donna che amava e una bimba bella come il cielo d’Australia. Aveva parlato tempo prima, più di tre anni, con Bono nella villa francese di Èze del cantante degli U2 riguardo proprio al suicidio, commentando quello di Kurt Cobain (a volte Michael soffriva di crisi depressive, ma ora anche quelle sembravano roba passata grazie all’aiuto dello psichiatra inglese Mark Collins) ed entrambi erano d’accordo che fosse un gesto stupido e che loro non l’avrebbero mai compiuto. Se lo erano promessi.
Aveva detto Michael alla sua manager, Martha Troupe, per telefono alle 9 e 38 del mattino: «Ne ho abbastanza». Non aveva scritto nessun biglietto d’addio. Aveva dato un pugno al muro. Aveva cenato con i genitori, ma con il padre pare non avesse discusso di quella questione di Paula e la bambina. Aveva chiesto a una cameriera due sigarette e quando lei gliele aveva portate lui le aveva dato un bacio sulla guancia ringraziandola. Aveva fatto ritorno in albergo verso le 22 e 30 ed era salito in camera con due suoi amici, Andrew Rayment e Kym Wilson, un’attrice con la quale aveva avuto una storia in passato ed erano ancora in buoni rapporti. Aveva salutato i due intorno alle 3 del mattino. Avevano bevuto qualcosa, ma niente di che, e nessuna droga, i tempi della cocaina per Michael erano passati da quando si era avvicinato alla religione. Aveva telefonato e si era messo la sua cintura intorno al collo (o qualcuno o qualcuna gliela aveva messa). C’è chi dice che così, in uno stato d’asfissia, si provi maggiore piacere sessuale. Il cazzo ti sta dritto come non mai e quando vieni non la smetti più. E allora non pensi più. Ma non risulta che ci fosse una donna con lui. Autoerotismo. Disperazione. Bono, saputa la notizia, ha pensato che Michael stesse attraversando un momento di insopportabile disperazione e che l’avesse incontrato proprio lì, in quella stanza. Un ospite sgradito che non è riuscito a tenere fuori dalla porta. Ha mischiato il dolore alla rabbia per il gesto del suo amico e ha scritto una canzone, Stuck in a moment you can’t get out of, che dice: Non ho mai pensato che tu fossi uno stupido / ma caro mio guardati / Devi stare su in piedi, portare il tuo peso / Queste lacrime non vanno da nessuna parte, baby / Devi riuscire a mantenerti insieme / Sei stato bloccato in un momento, e ora non riesci a uscirne / Non dire che dopo andrà meglio […] Le notti che riempisti di fuochi d’artificio ti hanno lasciato senza nulla […] L’acqua è calda fino a quando non scopri quanto è profonda / Non stavo saltando, per me era una caduta / E giù distante verso il nulla assoluto.
La caduta è un tonfo. Con i sigilli della polizia e la visita del coroner Derrick Hand. Col cadavere ritrovato sul pavimento del bagno con la cinta legata alla maniglia della porta che si era sfilata dal collo. Sotto la terra del Northern Suburbs Memorial Gardens di Sydney. Perché verso quel nulla assoluto invece di restare a vedere il suo Cielo aprirsi? Chiederlo a Paula era inutile. «Mamma non si sveglia», disse Heavenly rispondendo al telefono a un amico di famiglia che aveva chiamato. La diciassettenne Fifi Trixibelle arrivò poco dopo a casa con la polizia e si inginocchiò vicino alla madre, vicino al suo corpo c’erano una bottiglia di vodka rovesciata e un flaconcino di pillole di barbiturici, entrambi semivuoti. Sul comodino c’erano tracce d’eroina e cannabis. Peaches Honeyblossom non avrebbe mai dimenticato quel giorno. Mai quello in cui piangeva fuori la porta di casa e chiamava Mamma. Fu trovata il 7 aprile 2014 morta nella sua abitazione del Kent nelle stesse circostanze della madre, overdose d’eroina e ricordi insopportabili. Fifi Trixibelle coprì il corpo di Paula Yates con una sottoveste, di quelle ancora alla moda e carina”.
(Rimette il libro dov’era).
Sì, è proprio una storia orribile.
(Adesso sembra che siano realmente nella hall dell’hotel, anche se lui non si avvicina ed è ancora nel suo appartamento).
Una pausa. A Parigi piove.
GILLES Solo una pausa.
JEANNE Solo una pausa.
GILLES Il tuo stato delle cose.
JEANNE Sto lì. Lo sai.
GILLES No, non lo so.
(Pausa).
Reciti ancora?
JEANNE No, non più.
(Pausa).
Non è rimasto niente di quei giorni.
(Gilles la guarda. Lei abbassa gli occhi. Dopo un lungo silenzio, rialza lo sguardo).
GILLES È la prima volta che sento la tua voce.
JEANNE (Sorride). Te lo dissi dopo il primo abbraccio. Era vero, hai parlato solo dopo quell’abbraccio. Eravamo l’attrice e il drammaturgo. Ci studiavamo nei nostri movimenti. Nei nostri corpi estranei. Eravamo sudati. Eravamo lì, ma non mi ricordo più dove. Non ricordavamo i nostri nomi. Eravamo due attori. Davanti a tutti. Eravamo da soli. Eravamo insieme ad altri. Eravamo gli esclusi. Eravamo i marginali. (Sorride ancora. Sorride anche Gilles). Tu mi parlasti di Jean Genet. Ti dissi che anch’io rubavo i libri. Ti parlai di Sarah Kane. I lacci degli anfibi intorno al collo. Tutte quelle pillole. Ti parlai anche di Sylvia Plath. Il suicidio è una possibilità, ti dissi. Tu annuisti. Basta superare quel momento e si è salvi. Mi dicesti poi, guardandomi un po’ preoccupato, era come un suggerimento. A volte disegno o faccio altro, e passa, aggiunsi, abbassando lo sguardo. Forse ti sentisti sollevato. C’era un video di David Bowie. Mangiavamo in un bar per pochi soldi. Insalata di riso e Aperol. Cantava Life on Mars? Tu mi spiegasti che la fantascienza non c’entrava niente, quella canzone parlava di disagio familiare e di una trasmissione televisiva. Eravamo due disagiati. La televisione parlò di un altro attentato. Tanti morti per le strade di Parigi. E noi a fare queste cose, ti dissi. Ci pensavo spesso. Si può recitare in un teatro quando fuori si spara? Si può vivere una storia d’amore quando intorno a noi si muore? Ti domandai. Si può raccontarla? Eravamo un uomo e una donna senza risposte. Ti parlai anche di Michel Foucault e di Bernard-Marie Koltès, li leggevo di frequente in quel periodo. Ebbi un brivido. Oggi è un senso di spossatezza. Rende il pensiero languido e vago. Tu mi parlasti di Egon Schiele e di Wally Neuzil. Lui la lasciò per sposarsi. La lasciò per un ordinario matrimonio borghese. Mi raccontasti che quando lui fu incarcerato per una falsa accusa di rapimento e corruzione di minorenne e per esposizione di disegni pornografici a dei ragazzini, gliene bruciarono uno in tribunale, di quei disegni, lei non lo abbandonò un istante. E lui aveva abbandonato la sua modella preferita e la sua amante. Fummo d’accordo che fosse una cosa orribile. Decidemmo che avremmo fatto un lavoro teatrale sulla loro storia. Tu Egon e io Wally. Ma non avremmo parlato di quell’abbandono né delle loro morti precoci. Il pittore e la sua modella. Solo questo ora ci interessava. Due amanti. Eravamo scandalosi. Qualcuno se ne andò mentre recitavamo. Eravamo sfacciati. Eravamo timidi. Occupa case e ruba, c’era scritto su un muro. Concordammo che fosse giusto. Se ne avessimo avuto bisogno l’avremmo fatto. L’avevamo già fatto. A Place de la République la rivolta era finita. I poliziotti parlavano con le ragazze, fumavano, non badavano a noi. Eravamo rimasti in pochi. Sconfitti più dalla pioggia che non la smetteva da un mese che dalla repressione. Sotto le tende per non bagnarci troppo. Prima che partisse l’ultima corsa del métro la piazza si svuotò. Noi passeggiammo. Non pioveva più. Tu avevi una tua camicia che mi avevi portato per una scena che poi non facemmo. Ce la facciamo solo per noi due, che ci importa, ti dissi. Non tirasti fuori quella camicia. Michael Hutchence e Paula Yates avrebbero ballato fuori dagli studi televisivi. Anche Serge Gainsbourg e Jane Birkin l’avrebbero fatto, nella città deserta di notte. Lo fecero la prima sera che uscirono insieme. Ubriachi fradici e felici. Lui c’è stato a Les enfants du rock. Non mi sbaglio. E anche a Lunettes noires pour nuits blanches. Forse avrebbero danzato anche Alain Bashung e Chloé Mons. Si innamorarono dopo un video di lui in cui lei recitava. Era ambientato di notte, in interni. Storie balorde. La loro invece fu una bella storia. Poi lui morì. E lei cantò le sue canzoni, con il grande seno e i capelli biondi. Le cantò per l’uomo che amava ancora. In fondo, pure loro erano due marginali. Anche se il telegiornale aprì l’edizione della sera con la notizia della sua morte, Alain Bashung è morto, fu il primo titolo. Tutta Parigi pianse. Piansi anch’io. La città sembrava uscita dal finale dell’Eclisse di Antonioni. I lampioni accesi, le vie vuote, i palazzi spenti. E noi. Mi piaceva ancora Antonioni. Avevo scritto una poesia. Mi dicesti che era molto bella. Era molto arrabbiata. Ero molto arrabbiata. Avrei voluto ascoltarla dalla tua voce, che ora non era più sconosciuta. Ma non te lo chiesi. E tu non tirasti fuori la camicia. Mi dicesti che era a righine. Maschile. So che mi sarebbe stata bene. Ti sarebbe piaciuto come mi stava. Solo la camicia e niente sotto. Parlavamo d’altro per non mettere fine al nostro incontro. Era troppo presto. Per non parlare di noi. Eravamo di nuovo soli. Eravamo io e te. Eravamo e poi non siamo stati più. Quell’abbraccio ci ha fregato. (Pausa). O che ne so. (L’occhio con la lente, quello che lei ricorda fosse con la lente, comincia a lacrimarle. Se lo asciuga. Sembrano le lacrime di un pianto malinconico e sommesso).
La polvere, mi sta graffiando la lente.
(Si guarda intorno nella hall. Adesso innervosita e come persa).
Le mie scarpe. Le mie scarpe, Gilles. Dove ho lasciato le mie scarpe? Aiutami a cercare le mie scarpe.
(Non è la hall: è solo il suo appartamento. E sono di nuovo ognuno per conto proprio).
[1] Pubblicato su “Verde” del 23 aprile 2018.
 Barbara Caridi fotografata da Sergio Gilles Lacavalla, postproduzione foto Ilaria Turini
Barbara Caridi fotografata da Sergio Gilles Lacavalla, postproduzione foto Ilaria Turini
Nota dell’autore: “Questa è una variante di Jeanne e Gilles, già pubblicata su Verde l’estate scorsa. Rispetto alla precedente versione, la storia letta nel libro trovato nell’hotel riguarda Paula Yates e Michael Hutchence. Inoltre, gran parte dell’atto è interpretato da Jeanne in un lungo monologo. Gilles è lì, “così lontano così vicino”, ma parlerà solo alla fine. Come nell’altra versione, alcune scene sono sessualmente esplicite. Il corpo nudo è necessario sia per il realismo della scena, perché la scena lo prevede, sia perché il corpo nudo è di per sé un elemento di drammaturgia, non solo di regia: il corpo nudo è linguaggio, una frase, un discorso. Tutto ciò che avviene qui, è già avvenuto. Ora la scrittura si intitola L’Hotel degli Amori Perduti (suicide blonde version n. 1).“
La pièce, scritta da Sergio Gilles…
View original post 7.497 altre parole

Ascenseur pour l’échafaud #5: Robert Mapplethorpe
Il nero era diventato la sua ossessione. Nero su nero. La scala che porta al primo piano del Mine Shaft è nera. Nessuna insegna. All’835 di Washington Street c’è solo una freccia bianca che indica una porta rossa. Sopra la freccia c’è scritto “PRIVATE CLUB”. Oltre la porta e la scala ci sono uomini che si baciano, sopra e sotto, nei due piani, quello inferiore è più scuro, si baciano e si toccano nelle parti del corpo superiori e inferiori, si masturbano, si inculano. Alle pareti sono appese le opere grafiche omoerotiche dell’artista in incognito che si firma soltanto Rex: sono raffigurati uomini muscolosi e virili. L’immagine che fa da logo al club è quella di un minatore in canottiera e pantaloni aderenti, stivali e casco da lavoro, ha un grosso piccone tra le mani guantate. C’è una vasca da bagno in uno dei locali, all’interno c’è un uomo adagiato che si lascia urinare addosso da altri uomini. Sono vestiti di pelle nera, da finti poliziotti, da cow boy, da operai edili, camicie a scacchi, canotte e torsi nudi sotto i giubbotti. Alcuni hanno il membro che esce dalla chiusura aperta dei pantaloni, calzoni di pelle o Levi’s, altri sono senza pantaloni. Tengono il pene fuori dagli slip di latex o hanno già tolto gli slip. Certi perizoma sono aperti sia davanti sia dietro, il sedere è del tutto scoperto. Calzano stivali da motociclista. L’uomo nella vasca è nudo, ha il cazzo duro e si masturba mentre riceve l’urina dei complici di quell’azione avvolta nel nero e schizzata di giallo, hanno i sessi non ancora completamente eretti per permettersi di inondare l’uomo che viene quando un getto di urina gli irrora il glande. Sperma e urina si scontrano e si mischiano. È un’esplosione. Un geyser di liquidi organici. Poi gli uomini dai cazzi semieretti si spostano in un altro angolo del club, preferibilmente al piano più nero, i sessi si irrigidiscono fino a eiaculare in una bocca, in una mano estranee eppure così amichevoli, quanta amicizia, complicità e vicinanza è racchiusa in questi momenti di gioia e infinito. Qualcuno beve alcol e parla al bar, sotto le luci un po’ più alte di quella zona, ci si scambia carezze come preliminari. L’infinito è uno spazio nero fuori dal mondo. Uno spazio immenso che racchiude tutto il mondo. Il mondo è nell’antro nero di un culo forte. L’ano è una galleria buia che dilatandosi illumina la tua natura. Nel nero di quel buco profondo tutto va a finire. Il nero allargato dal piacere stordente in cui si infila il bianco del seme senza alcun fine riproduttivo. Il succo della tua unica reale identità. Senza altro progetto se non quello di soddisfare quel momento. La vita potrebbe finire qui, chi se ne frega. Un pugno fino al polso e l’avambraccio lubrificati opportunamente si fanno strada per raggiungere l’intestino. C’è chi ama farsi defecare addosso da quel buco nero che si spalanca con tutti i residui di un giorno finalmente finito, finalmente terminato così; un giorno liberato dal desiderio fino a poco prima trattenuto. Qui puoi non trattenere niente. Nel nero della miniera al Little West 12th Street di Manhattan, New York City, ognuno va a cercare il motivo delle proprie incursioni. Robert Mapplethorpe cercava il suo nero più nero da scopare e fotografare: scopare e fotografare sono la medesima cosa. Scattarsi un autoritratto e masturbarsi sono la stessa cosa. Si infila una lunga frusta di cuoio nell’ano e si fotografa guardando l’obiettivo.
«Cosa stai facendo, Robert? Perché non vieni a dormire, sono le tre».
Patti si era inginocchiata vicino a lui. Lui non rispondeva, incollando e colorando su un foglio di carta le figurine ritagliate da una rivista porno e da cartoline prese dai rigattieri sulla Orchard e su Canal Street. Erano figurine di freak di Tod Browning confuse a uomini nudi, marinai di Genet e motociclisti alla Tom of Finland.
Lei guardò il collage e capì che il suo amore stava dirigendosi altrove. Il Mine Shaft non aveva ancora aperto la porta rossa, ma lui era già al di là di quell’uscio. Ormai lontano da lei. Fu solo questione di tempo e avrebbe trovato il suo nero. Intanto aveva coperto le pareti imbiancate con del raso nero.
«Non parliamo più».
Il silenzio era diventato insopportabile.
Patti abbandonò quel silenzio.
Se ne andò ad abitare da una sua amica, Janet Hamill, nel Lower East Side. Si leggevano le poesie che scrivevano. Distraevano il silenzio. Patti disegnava. Quindi prese un bilocale sulla Clinton Avenue. Mentre Robert era a San Francisco a cercare quelle figurine in un corpo in carne e ossa. In più corpi. In qualcuno doveva trovarle. Al ritorno incontrò un ragazzo chiamato Terry e Terry e Robert ebbero un breve convivenza. Fu il primo segnale serio. Perché Terry non era solo un corpo. Era un flirt. Durò poco, ma quel tanto che bastava per sentire che ormai sarebbe stato sempre più difficile tornare indietro. Ci provò. Eccome se ci provò. Robert e Patti fecero un altro tentativo per salvare, o almeno prolungare il più possibile, il loro amore per l’eternità.
Al ritorno da un viaggio a Parigi con la sorella Linda nei vicoli del simbolismo, Patti lo raggiunse nel loft sulla Delancey. L’appartamento al 160 di Hall Street, dove avevano vissuto la loro storia d’amore e dove era calato tutto quel tenebroso silenzio, era un ricordo dolceamaro. Era vicinissimo e troppo lontano. Dio quanto erano pesanti quei silenzi. Scendevano sul tuo corpo e lo piegavano. Trascini i piedi. Occupavano ogni pensiero. Tutto lo spazio.
«Ho bisogno di te, Patti. Sto male».
Se l’erano giurato che si sarebbero sempre aiutati. Aiutarsi vuol dire amarsi. Robert si era beccato la gonorrea. Lui nella parte dell’Uomo da Marciapiede. Eccoli là i bei risultati. Lui non parlava, ma lei capiva che la strada verso i limiti della sua sessualità e della sua arte sarebbe diventata sempre più pericolosa. La gonorrea era stato solo un avvertimento. Una ferita di striscio. Gliela avrebbe curata. Ma puoi fare per sempre la crocerossina? La guerra è ancora lunga. Patti aveva voglia di scoppiare a piangere e affogare con lui nelle sue lacrime. Non può permetterselo: ora dei due deve essere quella più forte. Supereremo anche questa.
Robert non riusciva a mangiare per l’ascesso alle gengive e urlava e delirava per il dolore. Non si reggeva in piedi. I suoi bei capelli neri appiccicati di sudore e sporco. Nella pidocchiosa stanza dell’Hotel Hallerton sull’Ottava Avenue, l’hotel dei tossici e dei disperati terminali, dove avevano preso alloggio per quei pochi dollari che gli rimanevano fuggendo dall’appartamento sotto il Williamsburg Bridge dopo una sparatoria notturna che li aveva terrorizzati, «Meglio che lasciate questo posto», disse loro un poliziotto, Patti provò con tutti i modi che poteva permettersi a dare sollievo al suo fragile amore malato. Lo baciava sulle labbra. Una smorfia di dolore. La paura e l’incoscienza del contagio. La morfina donatale da un altro disperato come loro che si stava lasciando morire in una stanza sullo stesso lercio corridoio fu un breve sollievo. Macchie sul pavimento e sugli arti di quello spettro. All’Hotel Hallerton puoi solo sperare che la morte ti trovi un altro alloggio prima che dalla reception ti arrivi il conto che non sai come saldare. Ci vuole un medico. Anche se l’unica medicina possibile era andare là dove potevano accadere le cose, l’albergo che dà un’altra possibilità ai poveri artisti sfortunati, o un’altra illusione: il Chelsea Hotel al 222 West della Ventitreesima Strada a Manhattan. La 1017 e poi la 204 furono le stanze dove i due artisti, «Perché siamo due artisti, tu e io, vediamo e sentiamo le cose allo stesso modo, sì, siamo due artisti, Patti, dimmi che ci credi ancora», videro sbocciare piano piano la loro arte mentre recidevano giorno dopo giorno il loro amore per non lasciarlo sfiorire. Lui riprese a dormire sul bel seno di lei, magra da far paura come lui ma con il grande seno, lo accarezzava. Tutti quei capelli di Robert a coprire un suo capezzolo, li avevano lavati, il capezzolo si inturgidisce di desiderio e languore di un pomeriggio newyorkese, la mano di lui sul suo pube, il pene semirigido. Lei gli sussurrava una canzone. Notte. Lui si addormentava. Sogni di tenerezza con la sua donna, di successo, marchette in un angolo buio a San Francisco e New York, il corpo di lei e poi quello di un uomo, più uomini, più membri dritti, i volti degli uomini si confondono come i cazzi. Lecca. Succhia. Secrezioni vaginali e sperma. Al collo ha ancora le collanine che realizza e vende, è proprio bravo con le mani, piccoli gioielli che presto si toglierà.
«Tagliami i capelli. Un taglio da rocker anni Cinquanta».
Robert non ebbe più dubbi sul fatto che gli piacevano gli uomini quando, tornando a prostituirsi nell’Est Side, a volte sulla Quarantaduesima in compagnia del musicista e scrittore tossico Jim Carroll, con cui Patti ora aveva una relazione tenera e da niente, capì che più dei soldi cercava il piacere che gli davano quegli incontri. Il suo primo vero amore, il suo primo ragazzo importante, si chiamava David Croland, era un giovane ex modello della Boys Inc. ed ex ragazzo di Susan Bottomly alias International Velvet, attrice e superstar della Factory, ed era ben inserito nell’ambiente di Andy Warhol e della moda come dell’arte. Robert lo amava. Lo usava. E David si lasciava usare volentieri. Amare vuol dire usarsi. Mentre il medico del Chelsea, il dottor Herb Krohn, faceva un piercing al capezzolo sinistro di Robert, David lo teneva sulle sue gambe. La fotografa Sandy Daley riprendeva quel momento di intimità e dolore per un breve film intitolato “Robert Having His Nipple Pierced”. La stanza 1019 occupata da Sandy Daley è il set. La cinepresa inquadra David che carezza il volto di Robert. Si sposta sull’espressione di Robert tra il tormento e l’estasi. Robert aveva una camicia a righe azzurre e bianche aperta sul petto, cerca sicurezza nel suo amante toccandogli la nuca. David, a torso nudo, gli sfiora le labbra. Al collo di entrambi ci sono le collanine di Mapplethorpe. Quel piercing sembrava introdurlo alle pratiche del piacere attraverso il dolore.
Patti non assistette alle riprese, ci registrò sopra solo un suo commento poetico. Disse che la impressionava vedere il fragile torace di Robert venire bucato. Non disse che aveva il cuore in piccoli frammenti che fluttuavano come i palloncini argentati nella stanza bianca numero 1019.
Tra la Settima e l’Ottava. Tra la Diciassettesima e la Diciottesima. Il Max’s Kansas City, al 213 di Park Avenue South, era, come il Chelsea, il luogo dove potevi farti notare e incontrare chi avrebbe fatto di te una stella, baby. Due giovani di talento sono lì ogni sera.
Finita la relazione con David Croland, Robert conobbe Sam Wagstaff. Fu proprio Croland a presentare i due a una festa.
«Chi è questo?» Sam Wagstaff non riusciva a staccare gli occhi dal ritratto, fatto in una macchinetta per foto sulla Quarantaduesima, di Robert con un giaccone e un cappello della marina francese. Sembrava uscito da “Querelle de Brest” di Jean Genet.
«Vuoi conoscerlo?»
Iniziava la seconda e ultima relazione per tutto il tempo dell’eternità di Robert Mapplethorpe. Se quella tra Robert e Patti era stata la storia di due poveri amanti che avevano fatto l’amore su un materasso rimediato tra i rifiuti e in un piccolo letto di una stanza d’hotel per gli artisti del disagio e dei sogni da realizzare disperatamente, quella tra Sam e Robert sarà la storia tra un uomo ricco, bello e colto, collezionista e curatore di arte contemporanea al Wadsworth Atheneum di Hartford e del Detroit Institute of Arts, e un ragazzo di venticinque anni più giovane dall’ambizione smisurata alla ricerca solo di chi lo ami e lo protegga con il suo potere, un mecenate e un compagno sensibile pronto ad assecondare ogni sua voglia.
Sam Wagstaff: «Cerco qualcuno da corrompere».
Robert Mapplethorpe: «Be’, lo hai trovato».
Sono belli e dolcissimi i due nelle Polaroid scattate da Robert che li ritrae nudi mentre fanno l’amore. Si stringono i falli nel pugno. Robert gli sta per succhiare il cazzo. Sta per venirgli sull’addome tirato. Sono le foto del sesso e del romanticismo espliciti. Sam Wagstaff gli comprerà, dopo gli scatti di Robert con la 360 Land Camera prestatagli da Sandy Daley e con una Polaroid tutta per sé regalatagli dal curatore del Metropolitan Museum of Art John McKendry, una Hasselblad 500C/M. Quando gliela rubarono, si comprò una Graflex 4×5 pollici con dorso Polaroid per poi tornare definitivamente alla Hasselblad. Perché i collage e le foto a sviluppo istantaneo colorate sono roba passata. Ora l’aspetta la perfezione di una macchina per fermare il nero. Gli occhi grandi si spalancano di più con quell’obiettivo. Puoi vedere come mai avevi visto prima in quel nero. Puoi creare il tuo nero.
Il loft sulla Ventitreesima che affacciava sulla YMCA e l’Oasis Bar preso da Patti e Robert come studio per un centinaio di dollari al mese, dove avevano alternato le giornate al Chelsea, adesso, lasciato l’albergo di Manhattan, è diviso in due abitazioni-studio. Una porta aveva separato il loro amore infinito. Un giorno Robert la chiuse per non aprirla più. In mano ha la chiave di quella di un grande loft al quinto piano del numero 24 di Bond Street, regalo da cinquecentomila dollari del suo ricco amante.
«Stai attento, amore».
Di Larry Hunt, che aveva posato per Robert Mapplethorpe nel 1978 seduto su un divanetto vestito con un giubbotto di pelle, camicia a quadri, jeans e stivaloni con i lacci, la polizia di Los Angeles trovò al Griffith Park solo la mandibola con qualche dente. Difficile l’identificazione. Era scomparso alla fine dell’inverno del 1981, dopo essere uscito un sabato sera dalla casa di Falbrook che divideva con il fidanzato modello fetish e culturista Steven Darrow. La sua macchina fu rinvenuta parcheggiata davanti a un locale leathersex sadomaso di Los Angeles. Nessun segno di effrazione.
Robert Opel, il primo gallerista di San Francisco di Robert Mapplethorpe, fu assassinato alle nove di sera del 7 luglio 1979 nella sua galleria al 1287 di Howard Street da due uomini armati di fucile a canne mozze e automatica. I due chiedono soldi e droga, visto che si sapeva che Opel riforniva di anfetamine molti artisti. «Non abbiamo niente» risponde lui. Alla Fey Way Studios ci sono anche la socia di Opel, Camille O’Grady, e Anthony Rogers. Vengono portati sul retro della galleria dall’uomo armato di fucile mentre quello con la pistola rimane nella sala espositiva con Opel e gli intima di nuovo di consegnargli soldi e droga. «Ti faccio saltare la testa, se non me li dai», gli dice poggiandogli la canna della pistola sulla fronte. «Allora dovrai farlo, perché qui non c’è niente». Robert Opel si accascia a terra colpito da un proiettile in testa. Verrà dichiarato morto al San Francisco General Hospital alle dieci e mezza di sera. I due rapinatori fuggono con cinque dollari e una macchina fotografica. La polizia arresterà il 10 luglio Robert E. Kelly e Maurice J. Keenan mentre si apprestano a lasciare la California per la Florida. Saranno condannati all’ergastolo per l’omicidio di Robert Opel. Keenan fu l’esecutore materiale. Riuscì a fuggire tre volte dalla prigione prima della fine del processo che lo farà entrare nel carcere di massima sicurezza della contea. Si sospettò che avesse dei complici tra la polizia. In molti dissero che quella non fu affatto una rapina finita male ma un assassinio su commissione. Opel aveva già avuto problemi con la polizia. Dovette lasciare Los Angeles dopo aver protestato per la chiusura della spiaggia nudista spogliandosi e litigando con il capo del Los Angeles Police Department Ed Davis (una cosa seria rispetto all’incursione del 2 aprile 1974 al Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles durante la Notte degli Oscar: Opel correva nudo sul palco mentre un attonito e divertito David Niven presentava la serata). Tra i poliziotti molti ce l’avevano con lui e quei froci di artisti che ospitava nella sua galleria: oltre a Mapplethorpe, Tom of Finland e Rex, con tutti quegli uomini vigorosi in divisa e i cazzi enormi che facevano l’amore tra di loro. Ma, soprattutto, ce l’avevano con lui, e proprio quelli della città dove ora risiedeva, per essersi esibito, il 24 giugno dell’anno precedente, davanti al Municipio di San Francisco in una performance intitolata “Il Processo a Dan White”. Dan White era un ex consigliere del San Francisco Board of Supervisors, ex ufficiale di polizia ed ex vigile del fuoco colpevole dell’omicidio del sindaco democratico della città George Moscone e del consigliere dichiaratamente omosessuale Harvey Milk. White, apertamente contro i diritti dei gay e per la difesa delle famiglia e della religione, aveva sparato ai due politici che non volevano accettare la sua richiesta di reintegro nel Consiglio di Vigilanza dopo che aveva rassegnato le dimissioni perché in contrasto con la politica progressista a favore delle minoranze sessuali dell’amministrazione cittadina. Dan White, la mattina del 27 novembre 1978, entrò negli uffici del municipio e scaricò la sua .38 Smith & Wesson sui due nemici. Fu riconosciuto colpevole solo di omicidio volontario invece che di primo grado perché venne accolta la tesi difensiva che lo voleva affetto da grave depressione. Sarà condannato a sette anni. Uscirà dopo cinque e si suiciderà il 21 ottobre 1985 con il gas di scarico della sua automobile. L’irrisoria condanna scatenò i disordini della comunità gay del 21 maggio 1979 in quella che fu chiamata la White Night Riots. Il bersaglio della furia degli attivisti per i diritti degli omosessuali sarà soprattutto il San Francisco Police Department, accusato di aver condizionato il processo a favore di un loro ex membro. Per rappresaglia la polizia in tenuta anti sommossa fece irruzione all’Elephant Walk, un bar gay del Castro District, distruggendo il locale e malmenando e ferendo chiunque gli capitasse a tiro. «Schifosi rottinculo». Allora ecco l’esibizione di Opel nei panni del “Giustiziere dei Gay” e del suo complice nel ruolo del poliziotto.
«Stai attento, amore».
Un uomo urina in bocca a un altro, sono “Jim e Tom, Sausalito” in uno scatto del 1977. “Dominick e Elliot” posano nel 1979, uno è a torso nudo, pantaloni neri, e tiene il pene dell’altro che è crocifisso nudo a testa in giù. “Lou, NYC” è del 1978, il dito mignolo della mano sinistra di Lou penetra nella fessura del proprio glande. “John, NYC”, ancora del 1978, si infila un dildo nel culo. Anche un pugno penetra nell’ano. L’esibizione dell’omosessualità in quelli che erano gli aspetti più inaccettabili non poteva che provocare a Robert Mapplethorpe guai. Anche negli ambienti gay che si definivano più progressisti. Gli omosessuali dei diritti civili considerano l’omoerotismo maschio e sadomasochista dei ritratti di Mapplethorpe un ostacolo alla loro necessità di integrazione. Quelle foto rinchiudevano gli omosessuali in un ghetto fatto di leathersex, vizio e violenza maschili. Idioti, pensava lui sempre più amareggiato dall’intolleranza di chi credeva dovesse essere al suo fianco. Dall’intolleranza di travestiti, checche e lesbiche femministe.
Patti non sapeva cose gli sarebbe accaduto, ora erano lontani da tempo, lei si era sposata nel 1979 con Fred Sonic Smith e la coppia avrà due figli, vivono a Detroit. Sapeva però che sarebbe stato prima o poi inghiottito dal nero di giubbotti e pantaloni di pelle e stivali. Il nero della pelle. Il nero verso cui lo portava la sua ambizione, la sua mai soddisfatta sete di soldi, sesso e scoperte. Sentiva che c’era un nemico nascosto in tutto quel buio. Un nemico che non riusciva a vedere in faccia ma avvertiva che poteva avere qualunque volto.
«Chi è?»
«Stai tranquilla, Patti. So badare a me stesso».
Non smise mai di pensare a lui. Con amore. Pregò per Robert senza più le sue collanine. Per Robert che aveva detto che tra Dio e Satana aveva scelto quest’ultimo. Lucifero, portatore di luce. Fotografia vuol dire scrivere con la luce.
Patti e David erano stati i suoi primi modelli. Entrambi avevano posato nudi. Sembrava che Patti e David fossero degli specchi in cui veniva riflessa la sua condizione sessuale del momento. Anche se nessuno più di se stesso avrebbe rappresentato il proprio stato anno dopo anno. Messi uno in fila all’altro, i suoi autoritratti scrivono una biografia verso il nero. Il viso progressivamente si indurisce, in uno scatto impugna un coltello, indossa il solito giubbotto di pelle. In un altro imbraccia un mitra. La stella a cinque punte terroristica gli fa da sfondo. In uno del 1985 ha le corna sataniche che gli spuntano tra i capelli. È inquietante. Anche nell’autoritratto del 1980 truccato in maniera androgina è disturbante. Bello e inquietante. Inquieto.
«Facciamo l’amore un’ultima volta?»
Non le diede il tempo di rispondere.
«Dai, scherzavo» le aveva detto Robert con un sorriso e la voglia ancora di poggiare la testa sulla sua pancia, sul suo pube, mischiare i suoi capelli alla sua peluria. È solo un momento di stanchezza e smarrimento. Come era venuto sarebbe passato. Non puoi distrarti dal successo.
Sono due adulti con il loro amore per l’eternità diviso per sempre.
Nel 1975, con l’album “Horses”, Patti Smith era diventa famosa. Lui le aveva scattato la foto di copertina.
«Stai attento, amore».
Dai, non tirarti indietro. Sali la scala nera. Nel nero la documentazione del mondo, delle pulsioni e delle soddisfazioni degli ambienti sadomasochisti è la sua grande rivelazione. «Voglio fotografare qualcosa che non è mai stato fotografato prima».
Ma il nero che cercava più di tutti a un certo punto comprese che era nei corpi dei suoi modelli di colore. I suoi Mandingo con cui scopare e scattare. A volte innamorarsi. Innamorarsi sul serio. Come di Milton Moore dal sesso massiccio e perfetto. In “Man in Polyester Suit” il suo pene sbuca rilassato dai pantaloni del vestito economico. Il “Portfolio Z” racchiude le foto dei suoi modelli e amanti neri. Il cazzo eretto di “Philip” è fuori dalle mutande bianche, i testicoli dentro. Se lo tiene con una mano. Quello di “Dennis Speight” crea un’ombra sull’addome che pare raddoppiarne le dimensioni. “Jack Walls” punta la pistola come punta il pene rigido tirato fuori dai calzoni. Ken Moody dalla schiena e i glutei perfetti. Ken Moody che non riuscirà ad avere. I muscoli sono quelli di un monumento classico. I loro sessi sono sculture da esposizione. Il corpo della bodybuilder Lisa Lyon è l’equivalente bianco di quel nero: la bellezza di una statua nelle linee di una donna. Lisa che tende l’arco a seno nudo come un’amazzone. Nuda del tutto esce dal mare come un’ipertrofica Venere, su una collina contrae i bicipiti. Tira i pettorali in studio. Lo sfondo è grigio, mette in evidenza i quadricipiti, i tricipiti, di profilo le linee spettacolari del suo fisico, nuda. Il sedere più bello del mondo. Fa indossare anche a lei pantaloni di pelle e lingerie leathersexy. In “Lisa Lyon with Gun” la ritrae che impugna una rivoltella. Le mani sono coperte da guanti a rete neri, il corpo è ancora nudo. È ancora inquadrata di profilo. Il volto è celato dai capelli. Le foto furono pubblicate nel 1983 nel libro “Lady Lisa Lyon”, con testi dello scrittore Bruce Chatwin. Furono esposte per la prima volta lo stesso anno al 142 di Greene Street, New York, alla Leo Castelli Gallery dal 5 al 19 marzo. Ormai Mapplethorpe è un fotografo ricco e famoso che espone nelle gallerie e nei musei, ritrae le star della musica, del cinema, della letteratura, della pittura e personaggi del jet set, fa foto di moda. Con Andy Warhol si scambiano un ritratto. Lisa si fa inturgidire i capezzoli con le dita. Guarda in macchina. Guarda Robert. Votato solo al nero. Non illuderti, piccola. Neanche Sam Wagstaff si illudeva. Era sempre lì, al suo fianco, pronto ad assecondare ogni suo desiderio e ad accettare i suoi numerosi nuovi amanti. Anche Robert continuava ad amarlo, anche lui accettava le sue nuove relazioni. Il nero era diventato l’esclusiva ossessione di Robert. Il pene e i testicoli di Mark Stevens adagiati pesantemente su una base di granito, il sesso bianco di “Mr. 10½” aveva anticipato le misure di quello nero da museo. Il pene e i testicoli di Ajitto escono tra le sue cosce piegate, le ginocchia alla fronte, è seduto su un piedistallo di marmo coperto da un drappo bianco, il pene sfiora i talloni e la stoffa. Cazzo da esposizione. Fotograferà anche statue di marmo. I suoi ritratti di neri sono l’oltraggio per tutti: per i bianchi conservatori e razzisti e per molti neri che vedranno in quelle foto il corpo dell’uomo di colore ridotto a oggetto sessuale. C’è qualcosa di più oltraggioso di un oggetto sessuale? Da qualunque posizione lo si guardasse, quel nero faceva paura. Il membro esagerato spaventava e ridicolizzava le dimensioni di tanti bianchi. Cervelli ristretti e cazzi piccoli. “Thomas e Dovanna” danzano stretti, lui è nudo, la sua epidermide scura in risalto con l’abito e la cute bianchi di lei.
C’era il “Portfolio Y” a calmare le acque: era la collezione di foto di fiori. Ma cosa sono i fiori se non gli organi sessuali delle piante? Non se ne esce.
«Guardate le immagini» urlava al Congresso il senatore repubblicano del North Carolina Jesse Helms. «Guardate le immagini» insisteva furibondo. Mostra la foto dell’uomo in poliestere. Ha sul suo tavolo quelle del “Portfolio X”, quello dedicato agli scatti sadomaso, e altri scatti di “negri”. «Se nessun senatore sa di cosa stia parlando, dico: guardate le immagini». Denuncia le oscenità dell’ultima mostra di Robert Mapplethorpe intitolata “The Perfect Moment” in programma al Contemporary Arts Center di Cincinnati e chiede l’incriminazione per esibizione di materiale pornografico del direttore del museo Dennis Barrie. La mostra, organizzata da Janet Kardon dell’Institute of Contemporary Arts di Philadelphia, era stata inaugurata con successo nel dicembre del 1988 nella città della Pennsylvania e ora affrontava il tour del 1989. I problemi erano iniziati dopo le esibizioni al Museum of Contemporary Art di Chicago quando la mostra doveva essere ospitata alla Corcoran Gallery of Art di Washington DC. La direttrice del centro, Christina Orr-Cahall, il 12 giugno decide di annullare la retrospettiva di 175 foto di Mapplethorpe che avrebbe dovuto aprire le porte il 30 giugno intimidita dalle proteste degli ultraconservatori della American Family Association e preoccupata di perdere i finanziamenti alle arti del Congresso degli Stati Uniti. Manifestanti per la libertà di pensiero proietteranno sulla facciata della Corcoran alcune delle foto incriminate e un autoritratto di Mapplethorpe, con il ciuffo da rocker e la Kool al mentolo tra le labbra. Nonostante i tentativi di bloccare la mostra nell’Ohio da parte di quegli altri bigotti dei Citizens for Community Values e le insistenze adirate di Jesse Helms, interviene la polizia il giorno dell’apertura e la chiude temporaneamente, dopo quattro mesi di processo a Cincinnati, Dennis Barrie, minacciato di morte con la sua famiglia, la polizia gli consigliò di girare con il giubbotto antiproiettile, viene assolto perché “The Perfect Moment” non è oscenità ma arte, mentre la mostra aveva riaperto ed era andata avanti registrando un’affluenza di pubblico mai vista. Chissà Mapplethorpe cosa avrebbe detto, cosa avrebbe fatto. Forse si sarebbe indignato, sarebbe rimasto sconvolto, o forse avrebbe sorriso soddisfatto di aver sollevato l’ennesimo polverone, quando ormai era il fotografo più stimato, nel senso di valutazione dei suoi scatti, d’America. Ma non poté reagire.
Robert Mapplethorpe era morto per le complicazioni dell’AIDS il 9 marzo 1989 alle 5 e 30 del mattino al New England Deaconess Hospital di Boston. «Sono un perfezionista, e le cose non sono mai perfette». La vita non lo è mai. Guarda come va a finire. La vita che gli girava ancora intorno il 27 luglio 1988 all’inaugurazione della retrospettiva al Whitney Museum of American Art di New York. Lui se ne sta lì, seduto su un divano, vestito con un elegantissimo smoking, più morto che vivo. Sorride, i suoi occhi grandi sono enormi e cercano di catturare gli ultimi scatti.
«Ci aiuteremo sempre». E adesso Patti come può aiutarlo?
I regali dell’addio che Robert e Patti si era scambiati furono la foto di copertina del nuovo disco di lei “Dream of Life” realizzata da di lui mentre lei gli aveva scritto i testi di presentazione degli album “X” “Y” e “Z” per il catalogo di “Perfect Moment”. Come quando tutto era iniziato si donarono le rispettive creazioni artistiche.
Il Mine Shaft era stato chiuso il 7 novembre 1985 dal Dipartimento della Salute di New York per ordine del sindaco Ed Koch. «Stanno distribuendo la morte» disse alla stampa Koch. Il Procuratore Generale Robert Abrams incriminerà sei uomini tra proprietari e dipendenti del club: Richard Bell, John Dobson, Vincenzio Caravello, John Pascarella, David Givens e John Clark con le accuse di smercio di alcolici senza licenza, evasione fiscale e cospirazione per manomettere le prove e corrompere testimoni. Richard Bell era stato un poliziotto condannato e cacciato dal NYPD nel 1973 per furto di cocaina sequestrata dai collegi. «Stavano vendendo la morte» ripeté il sindaco. Forse era proprio lì, in tutto quel nero a due piani che Robert aveva trovato l’ultima foto. Forse in un bar per negri, forse negli incontri con i suoi amanti nello studio di Bond Street. Forse, più semplicemente, nell’amore con Sam Wagstaff, che l’aveva preceduto morendo anche lui per l’AIDS il 14 gennaio 1987. L’amore è un salto nel buio. La camera oscura di Bond Street e quell’ultima foto, quella che mostra Robert Mapplethorpe in primo piano, impugna un bastone davanti a sé, il pomello è un teschio. Il suo viso è consumato dalla malattia. Il bastone è nero. Indossa un maglione nero. Lo sfondo è nero. Il nero sta inghiottendo tutto.
[1] Pubblicato su “Verde” del 26 marzo 2018.
 Alessia Arti, Un iguana
Alessia Arti, Un iguana
“Robert Mapplethorpe era morto per le complicazioni dell’AIDS il 9 marzo 1989 alle 5 e 30 del mattino al New England Deaconess Hospital di Boston. «Sono un perfezionista, e le cose non sono mai perfette». La vita non lo è mai.” Ascenseur pour l’échafaud di Sergio Gilles Lacavalla, invece, lo è spesso (oggi ad esempio). Alessia Arti idem: sua l’illustrazione. Buon inizio di settimana amorevoli lettori, state attenti.
View original post 4.883 altre parole
Ascenseur pour l’échafaud # 4: Sarah Kane[1]
Nota dell’autore. I frammenti estratti dalle pièce di Sarah Kane sono nella traduzione italiana di Barbara Nativi. I titoli ho preferito lasciarli in inglese per conservare le varie sfumature di significato che alcuni di essi hanno.
Non poté fare a meno di ridere. Era una risata appena accennata, più che altro un sorriso ironico, con gli occhi abbassati gonfi e lucidi di sonno indotto e pianto da psicofarmaci, la mano che sfiora la bocca come per coprirla, quasi temesse che qualcuno potesse accorgersi della sua espressione, di quella smorfia tra l’amaro e il triste divertimento che diceva chiaramente Vi ho fregato. E, in effetti, li aveva proprio fregati. La paziente che doveva essere tenuta sotto stretta sorveglianza si alza dal letto e se ne va in bagno senza che nessuno se ne accorga. Avrebbero dovuto fermarla se lasciava la stanza. Se tentava di fuggire, sottoporla a trattamento sanitario obbligatorio. Nessuno che la fermi e la leghi al letto. Perché lì non c’è nessuno. Sotto il letto ci sono i suoi anfibi. Priva dei calzini, se li mette ai piedi. Li guarda e sorride. Che stupidi, pensa. La luce sfinita del bagno del King’s College Hospital riflessa sui Dr. Martens è l’ultima luna visibile alle 3 e mezza del mattino. La luna fa pena alle 3 e mezza del mattino. Anche lei fa pena alle 3 e mezza del mattino. Con un affaticato residuo d’orgoglio, nel suo pigiama, duplicata nello specchio, si fa proprio pena. La luna è una lampadina che rischiara la sconfitta. La drammaturga più in vista del nuovo teatro inglese ha perso. La lampadina è il riflettore acceso sulla sua disperazione. La lampadina comincia a scottare, e lei sta bruciando. Era stato sempre così. Si svegliava fra le tre e le quattro e non si riaddormentava più. Anche se teneva la luce spenta, non riusciva a riparare lo sguardo da quella luna artificiale che illuminava la parte più oscura dei suoi pensieri. Si metteva a scrivere. E tutto peggiorava. La necessità d’amore si risolveva in giochi di sevizie e distruzione. Nella crudeltà di ogni rapporto. Alla fine nella lunga confessione di una mente danneggiata irrimediabilmente dalle proprie parole. Andare sempre più a fondo in esse. “Io scrivo la verità e lei mi uccide”. Le sue parole illuminate da quella lampadina erano spietate. Avrebbe voluto solo una tregua. Una sospensione dell’ansia. Poter non pensare, poter staccare i fili elettrici, rompere l’interruttore, sbriciolare la lampadina. Ma lei non può più niente. Se non serrare gli occhi e non riaprirli più. Mai più. Identificava le 4 e 48 come l’ora in cui “la lucidità mi fa visita”, scriveva nel suo ultimo dramma finito tre giorni prima intitolato con quell’orario e la psicosi che portava con sé. La lucidità di quando non è più notte e non è ancora mattina e tutto ti appare per quello che è in realtà. Orribile. Lo spazio di tempo in cui tu non sei niente, non vali niente e pensi di farla finita. “Ricorda la luce e credi nella luce. Nulla importa ormai”. Alle 3 e 30. Alle 4 e 48. Ciò che conta è non arrivare a un’altra luce a cui ha smesso di credere, a un nuovo giorno. “Nulla importa ormai”. Ancora la scrittura, le revisioni, le prove a teatro, la critica che ti maltratta, ti insulta, il pubblico che ti ama e nessuno ti ama, se non ti ama una persona, una sola persona, non ti ama nessuno. Non c’è nessuno nel tuo letto dopo essere uscita dal teatro. Ti svegli alle 3 e 30, alle 4 e 48 portandoti dietro gli ultimi istanti di un sogno in cui c’è lei e tu le baci la bocca. Sei sveglia e vorresti sulle labbra il sapore della sua saliva, quello degli umori del suo sesso, lei ti sorride, tu la lecchi tra le cosce, con una mano le fai indurire un capezzolo, le infili un dito nel culo e continui a leccare, lei socchiude gli occhi, viene di nuovo e le tua bocca è bagnata. La tua bocca è asciutta. Le labbra screpolate dal desiderio insoddisfatto, dalla trascuratezza, non metti più il burro di cacao, dalla solitudine, sono aride. Vieni a vivere da me, porta le tue cose e vieni da me, oppure prendiamo un appartamento a Chelsea, che ne dici? Staremo più vicine al teatro. Lei non c’è, sei sola nel letto e la tua bocca è asciutta. Alle 3 e 30, alle 4 e 48. Allora cosa vuoi aspettarti da un altro giorno? Un giorno prosciugato dell’amore. La notte con la lampadina accesa. A casa tua. Arriva dalla strada anche la luce di un lampione. È gelida e rarefatta. In una casa di cura, reparto neurologia, vicino a dove abiti, a Brixton. Disse: «Sono innamorata». Aveva scritto “Cleansed” e disse al collega e amico Mark Ravenhill: «Eh già, mi sono innamorata», con quel sorriso che non ti comunica niente di buono. Sapeva che la sua speranza nell’amore avrebbe incontrato presto in uno sguardo indifferente, in una frase crudele, in un rifiuto, in un tradimento la disillusione. Mi piaci. Lei non ti risponde. Mi hai sentito? Ti ho detto che mi piaci. Lei non ti ascolta. Forse ti deride. «Mi sono innamorata» e essere innamorati, come aveva letto in “Frammenti di un Discorso Amoroso” di Roland Barthes, “quando si è respinti, è come essere a Dachau”. Il dramma si svolge in un’università trasformata in una specie di campo di concentramento dove si eseguono esperimenti torture sugli amanti. Per testare la loro resistenza, fino a che punto si è pronti a soffrire per amore. Fino all’eliminazione. O a sopravvivere, con il proprio amore intatto, malgrado le mutilazioni. Rod: “Tu moriresti per me?” Carl: “Sì” […] Rod: “Io non morirei per te”. Carl: “Non c’è problema”. Ma Carl tradisce Rod, uccidi lui non me, supplica, dopo essere stato sodomizzato con un palo per ordine del crudele direttore del college Tinker e minacciato di farlo morire impalato. “Ti amo Rod morirei per te”, lo schernisce Tinker e poi gli taglia la lingua. Gli fa inghiottire l’anello che sanciva il loro amore. In un’altra scena gli mozzerà anche le mani. Ancora un’altra e saranno i piedi a essere amputati. Non puoi più danzare per chi ami. Rod alla fine si sacrificherà per il suo povero vile pentito amante perdonato e innamorato sempre più lasciandosi tagliare la gola dal loro aguzzino. “Io. Non Carl. Io”. Grace, al suo adorato fratello morto d’overdose d’eroina iniettata in un occhio per sua richiesta da Tinker e tornato in un’allucinazione, fantasia, sogno più reale della realtà, forse è questa la realtà, per amarla ancora dice: “Amami o uccidimi, Graham”, dopo averlo baciato dolcemente sulle labbra. Si baciano ancora. È “un bacio più profondo”. “Io pensavo sempre a te”, le dice lui. Lei risponde che “non importa. Sei andato via ma adesso sei tornato, è questo che conta”. Anche lui dirà: “Amami o uccidimi”. Ma lei non era tornata. Amami o uccidimi. Non c’è alternativa. Ascoltami: se non mi ami mi uccidi. Il fratello protegge con il proprio corpo quello della sorella da una scarica di proiettili di fucile automatico. Grace era stata massacrata di botte e violentata davanti ai suoi occhi per essersi accoppiata con quel tossico consanguineo, la “troia”. Lui le tiene la testa. Dal suolo spuntano narcisi che sbocciano. Per lei non c’è nessun fiore, se non quelli di convenzione del dopo spettacolo. Che non odorano neanche. Consegnati recisi, già morti. Si sente morire. Quando, nella primavera del 1998, sostituì, perché malata, Suzanne Sylvester nella produzione di James MacDonald di “Cleansed” presso il Royal Court Theatre, lei interpretava Grace, era nuda ed era già delusa e senza più speranze. «Com’è recitare nel proprio dramma?» le chiese Ravenhill. «Non sto recitando nel mio dramma. Perché quel dramma è stato scritto da qualcuna che aveva speranza». Colei che amava non desiderava più il suo corpo, probabilmente non l’aveva mai desiderato, i suoi pensieri in quel corpo rivelato in scena con tutti i sentimenti scoperti sull’epidermide. Il pubblico la guarda. Lei è nuda. «Ti ritrovi completamente nuda davanti a centinaia di persone… Il primo istinto è quello di scappare via, ma in realtà quello che ti viene richiesto è molto semplice. Che cosa voglio? Che cosa provo? E come arrivo a provare questo?» Guarda in platea: «Che cosa voglio? Che cosa provo? Come arrivo a provare questo?» Cosa provo per te è qui sulla mia pelle, i peli si drizzano, puoi vederli in controluce, quelli degli avambracci, quelli del pube, la leggera peluria bionda sulle cosce che non si vede se non in questo riflesso strano che fanno le luci, sento freddo e sento caldo, sono solo pochi momenti ripetuti, non è una notte per noi due, nude, sole, ma è meglio di niente, guardami, sono nuda per te, e lei non la vede tra il pubblico. Inutile cercarla. Aspettarla dopo. Non è venuta. Togliti i vestiti. Me li tolgo anch’io. Graham aveva levato la maglietta a Grace. Le aveva guardato i seni. Le aveva succhiato un capezzolo. Lei gli aveva aperto i pantaloni, gli aveva preso il pene in mano. Si erano spogliati del resto degli abiti. Si guardano i corpi nudi. Si accarezzano. Si abbracciano. Fanno l’amore. Dammi i tuoi abiti. Indosserò i tuoi abiti. Mettiti i miei. Sono puliti. Sono pulita. Non mi importa che lo sia anche tu. Ma finita la recita si rimetteva i suoi soliti vestiti. Se li toglieva rischiarata dalla lampadina. Le dita infilate nel suo sesso sotto gli slip sono pugnalate al cuore, colpi della mano che distruggono la vagina e spaccano l’osso pubico. Frantumano ogni possibilità d’amare che schizza via in mille pezzi. Robin, colui che aveva indossato gli abiti del fratello di Grace, si impicca con i fuseau di lei, per amore di colei che non lo ama. Grace è legata al letto, ha subito l’elettroshock e un intervento chirurgico, il sesso cambiato, i seni sono stati asportati, due macchie di sangue. Sola nel suo letto, anche lei sanguina: dentro di sé. Poi il sangue tracima. Il sangue cola sul letto, inzuppa le lenzuola come mestruazioni senza controllo, come una ferita tra le gambe provocata dal morso violento di un amore arrabbiato, è sudore freddo e il dolore è diventato insopportabile. Nelle sue notti quasi mattina di solitudine le sembrava di sanguinare come Grace. Come lei soffriva di poter essere trasformata in chi amava. Non basta scambiarsi gli abiti. Bisognerebbe scambiarsi i corpi. Diventare il corpo altrui per non avere più bisogno dell’altro, di un’altra da sé. Ma lei ne ha bisogno più che mai. Non vuole trasformarsi in chi ama. Vuole colei che ama, il suo corpo che respira caldo sopra il suo. Simile al suo ma diverso. La scena è sempre la stessa. Lei è lì accanto, masturbarsi a vicenda, baciarsi, amarsi e addormentarsi sfinite e appagate una addosso all’altra. Alle 3 e 30, alle 4 e 48. Ti alzi per andare a fare pipì. Torni e la guardi dormire, sei inginocchiata sul letto vicino a lei e la guardi respirare tranquilla nel sonno. Alle 3 e 30, alle 4 e 48. Lo sguardo si sposta lento dalla punta ai lacci. I lacci sono sufficientemente lunghi e robusti. Più neri della notte londinese del 20 febbraio 1999. Lo sguardo ha un’accelerazione che corrisponde ai gesti necessari per sfilare quelle stringhe. Movimenti veloci prima di ogni ripensamento. Prima che qualcuno la scopra e butti giù la porta. Veloci e precisi. Basta quello di un solo anfibio. Si toglie l’anfibio, finisce di sfilare il laccio. Il piede nudo a contatto con il pavimento freddo le dice di tutto il gelo che avvolge ogni povera vita che ha perduto per sempre “la fede nell’amore” e vaga folle per Denmark Hill, attraversa un corridoio e si chiude a chiave in un bagno. Non dovrebbero lasciare la chiave nella serratura del bagno degli aspiranti suicidi. Signorina, lasci la porta aperta. Signorina, non si chiuda dentro, lasci la porta accostata. In questa situazione non puoi che sentire su di te tutta la crudeltà e la violenza delle relazioni. È colpa tua se tutto va male. Se c’è guerra in un appartamento londinese o di chissà dove, se c’è guerra per le strade, ovunque. È colpa tua. L’hai voluto tu. In “Blasted”, il suo esordio del 1995 definito dal critico del Daily Mail Jack Tinker (sì, proprio come il nome del torturatore di “Cleansed”) “una disgustosa festa di sporcizia, un dramma che sembra ignorare ogni limite di decenza senza avere, al tempo stesso, nessun messaggio da veicolare per giustificare le oscenità, né alcun merito artistico”, attaccato da tutti e difeso da Martin Crimp, Harold Pinter e Edward Bond, l’amore è un hotel di sentimenti indecisi, squilibrati e di reciproca dipendenza, un teatro di guerra in un interno a ore, a giorni transitori, a stagioni scandite dalla pioggia in una camera di lusso dove la relazione tra un malridotto, cinico e razzista giornalista gallese di 45 anni chiamato Ian, con la pistola e killer, così dice lui mentre lei gli fa una fellatio, per un’organizzazione antiterroristica, trapiantato a Leeds, città in cui si svolge l’azione, e un’ingenua, ma “non stupida”, e innocente ragazza di 21 anni del sud di Londra del “ceto medio-basso” dal nome di Cate, è un gioco di seduzione e soprusi che termina con l’irruzione nella camera di un soldato che porta con sé tutta la brutalità del conflitto combattuto fuori sotto le bombe e i colpi di fucile. Il soldato sodomizza con il proprio membro il giornalista tenendogli l’arma puntata alla tempia come aveva fatto Ian con Cate, svenuta in una delle sue crisi epilettiche. Lei era partita e lui veniva tra le sue gambe aperte. Piange il soldato ricordando la stessa violenza a cui avevano sottoposto la sua ragazza, ammazzata recidendole la gola, le orecchie e il naso, piange e incula il giornalista che non racconta queste cose, per fargli capire, o perché con qualcuno deve pur prendersela o solo perché ha “voglia di fare l’amore”, toglie il suo cazzo e gli infila la pistola nel culo. A Col, la ragazza del soldato, un proiettile sparatole nell’ano l’aveva finita; piange come Ian malato delle sue azioni. Uno stupro domestico porta allo stupro di guerra. Quindi il soldato acceca Ian succhiandogli via gli occhi, la stessa cosa l’avevano fatta a Col, li mastica, li inghiotte, infine si fa saltare il cervello con la sua arma. C’è una bambina affidata a Cate da una donna quando lei era uscita dal bagno per fuggire da Ian e da quella situazione, la bambina muore per gli stenti del conflitto. Viene seppellita sotto il pavimento della stanza, una croce fatta con assi di legno legate con la fodera della giacca del suo amante a benedirla, la bambina è mangiata per fame dall’accecato Ian. Eppure, in tutto questo orrore, c’è ancora uno struggente male espresso bisogno di pietà. Cate ha portato da mangiare a Ian il cibo ottenuto in cambio di una prestazione sessuale con un soldato. Il vestito imbrattato di sangue sul ventre. Il sangue sbrodola come le lacrime rosse sul viso del suo infelice amore. La ferita che le aveva provocato Ian con un morso praticandole sesso orale si è riaperta. Cate imbocca Ian. Lo disseta con del gin. Piove dal soffitto aperto da un colpo di mortaio. Anche lei beve un sorso di gin. Si succhia il pollice. Ian: “Grazie”. C’è un avanzo di tenerezza. Come nel rapporto tra Tinker e la spogliarellista a gettone di “Cleansed”, che si lascia chiamare Grace. “Mi piace il tuo cazzo, Tinker. Mi piace sentire il tuo cazzo dentro di me, Tinker. Scopami, Tinker” […] “Come ti chiami?” “Grace”. “No, voglio dire –” “Lo so – ho capito. Mi chiamo Grace”. “Ti amo, Grace”. Una richiesta di salvezza nella Stanza Nera di un peep-show, in una stanza d’hotel. La redenzione che sta nel supplicare una pistola per uccidersi. Ma Cate ha tolto le pallottole. Gli amanti balordi non riescono a lasciarsi. Meglio un amore balordo che questa solitudine. Le sue storie non riescono più a tenerle compagnia. L’incapacità d’amare è una patologia che investe tutto e tutti. Decide delle storie personali e invade la storia di un’intera società. E questa società la disprezza. “Phaedra’s Love”, la sua seconda scrittura teatrale che debuttò nel 1996, rappresenta il declino della monarchia inglese distrutta da unioni amorose che hanno come conseguenze solo il fatale errore, la degradazione e la morte quale unico modo di espiazione. A qualunque livello è così. La regina Fedra e il re Teseo si suicidano dopo aver avuto rapporti sessuali con i figliastri Ippolito, linciato dai sudditi e squartato da Teseo perché accusato falsamente da Fedra, innamorata di lui e gelosa del suo rapporto con la figlia Strofe, di averla stuprata, lo scrive in un biglietto d’addio e si impicca, e Strofe, che, celata la sua identità, per reazione alla difesa del fratellastro è violentata e sgozzata dal monarca. Il principe Ippolito è un giovane inerte, debosciato, che vuole scoparsi tutti, pur senza nessuna voglia, donne, uomini e anche il prete che gli chiede di confessarsi e redimersi dai suoi peccati, gli eiacula in gola, il prete è inginocchiato davanti al suo basso ventre (“Vai. Confessati. Prima di finire bruciato”); nella noia di giornate davanti alla Tv mangiando patatine e dolcetti, Ippolito si lascia fare un pompino dalla matrigna come regalo di compleanno (Fedra: “C’è qualcosa tra noi, qualcosa di terribile, lo senti? Brucia”). Lui le viene in bocca senza staccare gli occhi dalla televisione, poi la rifiuta. (Strofe: “Non è gentile con la gente dopo che ci ha scopato”). Tutto è così umiliante nell’amore. Lei lo sa bene. Puzza di sudore, farmaci e amore andato a male. «Ho perduto per sempre ogni fiducia nell’amore», continuava a dire, facendosi ricoverare per due volte al Maudsley Hospital, l’istituto psichiatrico di Denmark Hill. Ricette di psicofarmaci lunghe come la scena di un atto unico. La lista la metterà in “4.48 Psychosis”. Per fortuna quel sempre ha i minuti contati. Poi più niente. Niente di niente. “4.48 Psychosis” porta a questo niente in un percorso clinico dove nessuno capisce il suo dolore. Quel Mi piaci non ricambiato è straziante. Nessuna medicina può sostituire un Anche tu, anche tu mi piaci. Invece ci sono soltanto pasticche, diagnosi di patologia mentale e tutte quelle parole del “Dottor Questo” e “Dottor Quello” e “Dottor Come va” che uccidono una dietro l’altra: sono parole a nessuno, sentite ma inascoltate. Non serve a niente metterle in scena adesso, per chi? Rivolte a chi? Non è vero che un autore scrive per il pubblico, per se stesso, per il teatro, tutte cazzate per giustificarsi e darsi importanza. Scrive per una persona sola, solo per lei. Non aspetterà che quelle parole debuttino in un teatro. Il tempo è scaduto. “Sono triste. Sento che il futuro è senza speranza e le cose non possono migliorare. Sono stufa e insoddisfatta di tutto”. «La depressione non riguarda il vuoto» disse. «Ma è essere così pieni che tutto si annulla». Fine di ogni dolore nel lindo bagno del reparto per malattie mentali di un ospedale a Camberwell, sud di Londra, ancora a Denmark Hill, là dove le menti tormentate cercano sollievo. Non un granello di polvere, non un rumore, odore di disinfettante. Il laccio ha fatto un piacevole fruscio uscendo dai passanti, in tutto quel silenzio è come un vento che soffia dal Mare del Nord, un vento che fa vibrare le foglie degli alberi nei boschi e nelle campagne intorno alla nativa Brentwood nell’Essex, investe i campi sportivi della Shenfield High School dove le ragazze più carine corrono con i calzoncini della scuola e giocano a calcio e lei le amava tutte, taciturna e timida le amava, le guardava sotto le docce, ridevano affaticate e le amava, entra da una finestra aperta nelle aule dei corsi di teatro delle università di Bristol e Birmingham, il fruscio delle pagine di un copione sfogliate con un’attrice, sentire il suo leggero profumo alterato dal sudore delle prove di lettura, il suo alito avvicinandosi di più. Il laccio e la maniglia della porta – anche la maniglia brilla nel riverbero della luna-lampadina delle 3 e 30 – sono la sua salvezza. Lo spillone che buca quel palloncino pieno di irrimediabile sconforto che preme sulle pareti interne della vagina e del cuore, della sua giovane esperienza invecchiata dai rifiuti e dalla malattia. Da un senso di colpa per il suo modo d’amare che si porta dietro dalla rigida e bigotta educazione evangelica della famiglia. A sedici anni la fece finita col giudizio di Dio, ma mai si liberò di quel senso di colpa inculcato dal padre e dai libri sacri – la Bibbia, la raccolta delle peggiori nefandezze. Amo e sono colpevole. “Sono colpevole, vengo punita” scrive in “4.48 Psychosis”. “Vorrei uccidermi”. Sono colpevole di non riuscire a farmi amare. Eppure amo e tu mi piaci. Mi piaci tanto. “Non riesco a fare l’amore. Non riesco a scopare”. “Sono un fallimento completo come persona”. Ventotto anni compiuti da neanche tre settimane e non poterne già più di tutto. «Ho perso la fede nell’amore». “Crave”, del 1998, è la messa in scena di quattro amori disperati, malati, ossessivi. I quattro personaggi della pièce non hanno nomi, sono individuati solo con lettere dell’alfabeto: A, B, C e M. A volte anche il sesso può apparire indefinito. I personaggi, comunque, anche per suggerimento dell’autrice, si possono identificare con un uomo maturo, A, che ha una deviata, irresponsabile e dolente passione per la giovane C, che lo detesta e si sente abusata da lui, e probabilmente lo è, o lo è stata quando era più giovane, una bambina o poco più, e da un giovane uomo, B, che umilia il desiderio di M, donna di mezza età, di avere un figlio da lui, pur senza nessun amore. C’è voglia, c’è urgenza, c’è brama, ma mai amore vero e realizzato. Soltanto impulsi e aneliti frustrati. Il lungo monologo di A, da tante attrici equivocato e interpretato come un bellissimo momento romantico di una donna verso un’altra donna, in realtà è una dichiarazione di amore soffocante e patetico dell’abusatore verso la sua vittima. ”[…] e io non so come non so come non so come comunicarti qualcosa dell’assoluto eterno indomabile incondizionato inarrestabile irrazionale razionalissimo costante infinito amore che ho per te” conclude A mentre C, sottovoce, ripete: “Ora basta ora basta ora basta ora basta ora basta ora basta ora basta ora basta”. Un uomo e una giovane donna, voglio fare l’amore con un ragazzo di quattordici anni che mi svergini su un campo e mi violenti fino a farmi venire, dice C, forse è il desiderio di un’adolescenza che ritorna, uniti in un rapporto che dichiara la corruzione di ogni purezza. Lei non dà tante indicazioni. Una volta confessò di essere stata abusata a otto anni. A e C ricordano Ian e Cate di “Blasted”. Ma A è anche lei, l’autrice, che opprime e tortura i suoi personaggi, dunque se stessa; è A come era Tinker. È l’aguzzino e la vittima. C – che interpretò in alcune repliche – è stata, o è ancora, in un ospedale psichiatrico, come lei. C: “Sono depressa perché sto per morire […] Sono cattiva, sono malata e nessuno può salvarmi […] Mi accendono la luce ogni ora per controllare se respiro ancora”. I personaggi cambiano pelle, contesto, situazioni ma paiono riproporsi a ogni pièce. Sempre più perdenti. “Amami o uccidimi” è diventato “Sopprimimi o rinchiudimi”. La sconfitta d’amore adesso smarrisce i suoi connotati più visibili e concreti per diventare parole erranti nella terra desolata dei sentimenti irrealizzabili. Anime in pena che non risolveranno mai i loro amori confusi. B, da colui che rifiuta gli approcci di M, si ritrova a lei legato da un bisogno che arriva all’improvviso, quasi incomprensibile. M: “Mi hai chiesto di sedurti”. B: “Non di incastrarmi”. E adesso eccolo lì. B: “Mi piace averti dentro il mio sistema”. M: “Nessuna prestazione richiesta […] Nel mio letto una terza persona di cui mi sfugge il volto”. Poverino. B: “Le cose che voglio le voglio con te”. M: “Non. Sono. Io”. B: “È successo qualcosa”. M: “Ma non potrei mai dire che ci siamo amati”. C’è sempre e ancora e non cessa mai una sofferente dipendenza dall’altro, la sua dipendenza senza nessuno da cui dipendere. O dipendere proprio da chi non c’è. Niente che dia sollievo a questa astinenza. Ora è lei a leccartela. Le vieni in bocca. Vieni ancora mentre lei ti strofina due dita dentro e ti bacia, le labbra, le lingue, la saliva anche sul mento, sui capezzoli. Ti bacia e le vostre bocche hanno una il sapore dell’altra. Il gabinetto è caldo dei caloriferi accesi, tenuti alti, lì c’è gente malata, eppure il pavimento non riesce a riscaldarsi. Non si riscalda mai. Il freddo è tristezza e colpa, sul tuo piede scalzo vicino all’anfibio. “Quello che mi tiene legata a te è il senso di colpa” dice C ad A. Un altro senso di colpa. Uno schifosissimo senso di colpa. E mai, mai mai che si sia corrisposti. Sei sfinita. Ricorda con rabbia i tuoi fallimenti. È un male precisissimo e indistinto. C: “Ascolta. Sono qui per ricordare. Ho bisogno di… ricordare. Ho questa tristezza addosso e non so perché”. Perché si continua ottusamente a stare dentro questa malinconia come in un bagno caldo che ti avvolge ma non ti lava, l’acqua calda è spossante, poi fredda e la reazione è terribile? Perché non riesci a lasciare quella vasca d’angoscia? Pure se a volte ti ripeti di non sentire niente, non sento niente. Non sento niente, dici. «Ho perduto la fede nell’amore. Questa è la mia opera più disperata». Sul comodino vicino al letto nel suo appartamento ci sono alcuni libri inerenti il tema del suicidio. E le pagine di “4.48 Psychosis”. “Una notte tutto mi fu rivelato. Come posso ancora parlare? […] Ricorda la luce e credi nella luce. Un attimo di chiarezza prima della notte eterna”. Adesso diranno: Ecco la solita egocentrica – che poi chi ti conosce di persona si accorge di quanto tu sia timida. Non le bastavano gli scandali delle opere passate, l’ultima l’ha ambientata proprio dove ti trovi ora. Lo diranno, puoi starne certa. E il tuo dramma verrà ridotto a una nota del suicida in cerca dell’ultima stupefacente shockante pubblicità. Ma che ti frega, come se in questo momento ciò avesse importanza. Lega il laccio alla maniglia, lo tira per accertarsi della solidità del nodo. La distanza tra la maniglia e il pavimento è sufficiente. Dalle centocinquanta pillole di antidepressivi e le cinquanta di sonniferi ingurgitate tre giorni prima l’avevano salvata – anche se lei quello non l’aveva considerato un salvataggio quanto un accanimento terapeutico. Voglio vedere, davanti a quel laccio così resistente da tenere legato un hooligan del Manchester United di cento chili, figuriamoci una giovane donna minuta di neanche cinquanta, come avrebbero potuto ancora trattenerla in quel posto senza via di uscita a cui lei affidava la sua ultima speranza. Vediamo un po’. Sarà inutile suonare l’allarme quando mi troverete. Inutile correre, tentare una rianimazione, inutile anche piangere e recriminare, accusare il personale infermieristico di non avermi controllata come si doveva. Accuse della famiglia contro medici e infermiere in tribunale. «Nessuno mi aveva comunicato che era una paziente da monitorare continuamente» si giustificò davanti al giudice del Southwark nel corso dell’inchiesta Julie Forrester, l’infermiera che avrebbe dovuto tenerla sotto osservazione in base alle disposizioni degli psichiatri dottor Sedza Mujic e dottor Nigel Tunstall. La direzione sanitaria del King’s College Hospital avrebbe ammesso una non sufficiente comunicazione tra medici e infermiere. Mentre un portavoce dell’ospedale ha concluso che, in ogni caso, niente avrebbe evitato ciò che è accaduto. «Era una stella luminosa, ma era tormentata dall’angoscia mentale, tormentata da pensieri di suicidio» ha detto il coroner Selina Lynch. «Purtroppo ha fatto la sua scelta in un momento in cui soffriva di una malattia depressiva». Potevano dire tutto quello che volevano, arrivare a qualunque verdetto. Avrebbe vinto lei. Nella sua sconfitta, avrebbe vinto.
Sono le 3 e 32.
“Non ho nessuna voglia di morire
nessun suicida ne ha mai avuta”.
Robin: “Se potessi cambiare una cosa della tua vita cosa cambieresti?”
Grace: “La mia vita”.
Il laccio non cede.
“Alle 4 e 48
quando la disperazione mi fa visita
mi impiccherò
al suono del respiro del mio amante”.
Sei una romantica del cazzo, Sarah Kane.
Sono le 3 e 35 ed è sabato. La sera le ragazze carine andranno a ballare.
[1] Pubblicato su “Verde” del 19 febbraio 2018.
Ascenseur pour l’échafaud # 4: Sarah Kane[1]

Ascenseur pour l’échafaud # 3: Egon Schiele[1]
Il fuoco cominciò ad annerire il bianco, una parete bianca dietro l’esile figura indifesa, lentamente, quasi indeciso, poi prese coraggio e accelerò la sua avanzata accartocciando il soprabito arancione aperto sul corpicino nudo posto tra tutto quel bianco ora nero e consumato, che si sgretolava: non si poteva più fermare, in pochi secondi il corpo infantile fu mangiato dalle fiamme. Odore di fumo, carta e oltraggio.
Con lui portarono via anche i suoi disegni. Si trattava di una serie di schizzi a matita, alcuni accennati ad acquerello, ritraevano nudi di giovani. Erano stati al centro di polemiche a una mostra a Praga dalla quale aveva dovuto ritirarli in seguito alle richieste della polizia, forse una denuncia anonima o li aveva visti un funzionario del commissariato di zona, ma lui aveva sempre pensato che fosse stato solo un malinteso e non ci fosse niente di male nel loro erotismo. Non seguì alcuna azione penale. Così aprì il cassetto dove li teneva e li mostrò ai due gendarmi, o meglio, a un gendarme e a un messo comunale. Gli agenti, «dai vestiti colorati, i bottoni luccicanti», esaminarono il materiale, guardavano foglio per foglio, circa un centinaio di fogli, da «dietro la loro maschera di persone buone» che tradiva una morbosa attrazione per quei corpi acerbi e sinistramente seducenti, poi, richiudendo le opere dentro la cartella in cui erano custodite, le sequestrarono come elementi di prova, come corpi del reato. Avevano strappato dal muro un altro disegno con raffigurata una bambina coperta solo da una mantella arancione, il cappuccio alzato sulla testa; misero anche quello nella cartella. Lui li aveva osservati procedere nelle loro diligenti operazioni sospeso tra lo sgomento e una certa tranquillità. In fondo non aveva niente da nascondere. Di cosa mai doveva preoccuparsi? Lui era un artista. Era colui che sarebbe stato riconosciuto come il più importante pittore della Secessione Viennese e dell’espressionismo. Quelli erano solo disegni e l’affare di Praga nient’altro che un incidente di percorso dimenticato da tutti. Eppure doveva saperlo. Doveva sapere che l’Austria era bigotta e invidiosa. Che la sua gente non sopportava l’eros svelato nella verità di un desiderio inquieto. Poteva tollerare quello decorativo e d’oro del maestro Gustav Klimt. Di certo non quello angosciante dei suoi corpi sofferenti e distorti. Lui nudo negli autoritratti, incurante degli sguardi ipocriti, il pene tra le gambe ossute, né ostentato né nascosto, le pose strane, troppo strano e immorale quel corpo. La vagina di una modella esibita tra le cosce aperte, una con due dita della mano magra dischiude le labbra vaginali: il sesso diventava una ferita dolorante nelle fantasie represse degli uomini e delle donne per bene. Intollerabile per donne rassegnate alla negazione del piacere e per mariti che menavano alle mogli e consumavano i rapporti coniugali con muta e sorda violenza. Le puttane rinchiuse nei bordelli o nell’ombra pesante dei palazzi delle vie buie del peccato dell’integerrimo Impero Austro-Ungarico che si preparava a mandare i propri figli a morire nello scannatoio della Prima Guerra Mondiale. Era stato costretto a lasciare il villaggio di Krumau an der Moldau, la cittadina boema in cui era nata sua madre Marie e dove si era rifugiato per stare lontano dall’insopportabilmente borghese Vienna, perché la gente del posto non vedeva di buon occhio la peccaminosa convivenza fuori dal matrimonio tra lui e la sua modella. Niente disturbava più della gioventù e della bellezza vissute senza inibizioni in giorni fatti d’arte. Lei posava per lui, a volte vestita, altre nuda, i grandi occhi azzurri, poi facevano l’amore. Erano scandalosi. Erano bellissimi. Tutto così semplice. Dovettero fuggire come ladri. L’integrità morale delle famiglie era salva. E allora doveva saperlo. Doveva aspettarsi che un oscuro burocrate avrebbe schedato le sue opere come pornografiche e lui come un delinquente.
Tutto era iniziato con un equivoco. Egon Schiele si era trasferito nel piccolo comune di Neulengbach, a una trentina di chilometri da Vienna, con la sua donna e musa Walburga Neuzil, detta Wally – ex modella e amante di Klimt che aveva preso il posto davanti alla tela, alla carta e nel cuore di Schiele della sorella minore del pittore, Gertrude, affettuosamente chiamata Gerti, la sorella, della stessa età di Wally, ormai perduta dietro l’amore per il compagno di studi di Schiele all’accademia di belle arti, il pittore Anton Peschka. Vivevano tranquilli, lavoravano e si amavano. Sembrava che in quel centro di circa ottomila abitanti nessuno facesse caso a loro. Qualche voce girava per via dei bambini che a volte scorrazzavano per casa e che lui ritraeva, ma i bambini erano allegri e giocavano con Wally, Wally che avrebbe voluto dei figli da Egon, «Lascia che mi sistemi, amore, e poi avremo anche noi i nostri bambini», le ripeteva lui. Lei sorrideva fiduciosa e lo baciava. I bambini si divertivano e facevano le smorfie davanti ai colori di Egon. Egon e Wally andavano a comprare da mangiare nel centro del paese e conoscevano i genitori di quei ragazzini, spesso abbandonati per strada a loro stessi, la vita non era facile per nessuno in quegli anni e bisognava tirare la carretta se si voleva mettere una scodella di minestra a tavola: qualcuno che li intrattenesse un po’ e desse loro un frutto e una fetta di pane e miele faceva comodo. La casa dei due era fuori dal centro abitato e una sera di temporale, bagnata fradicia e intirizzita, suonò al cancello una ragazzina poco più grande di quei bambini, la tredicenne Tatjana Georgette Anna Von Mosig.
«Vi prego, fatemi entrare», disse a Egon, con il viso bagnato di lacrime miste a pioggia. Entrata in casa, raccontò di essere fuggita dal padre, un alto ufficiale della marina militare in pensione dai modi autoritari che le impediva anche di respirare, figurarsi di divertirsi come ogni adolescente. Doveva non aver dimenticato la rigida disciplina delle forze armate. La famiglia era il suo equipaggio.
«Vi scongiuro, non mandatemi via. Non voglio tornare a casa».
La ragazza erano giorni che girava intorno a quella abitazione, sbirciava dalle finestre Egon Schiele che ritraeva Wally. Si immaginava al posto della modella. Si immaginava già adulta. Si immaginava libera e seducente. Aveva anche scambiato due chiacchiere con Egon quando lui dipingeva in giardino e lei si avvicinava con in mano un catalogo della Künstlerhaus. Fingeva di interessarsi d’arte, tradendo il fatto di non sapere che proprio dall’abbandono di alcuni artisti dissidenti dell’edifico sulla Karlsplatz che ospitava la Società degli Artisti Viennesi era nata la Secessione.
«Non può rimanere qua», disse Wally in un sussurro.
«Vi prego. Vi prego».
«Non possiamo mandarla via, con questo tempo si piglierà una polmonite», disse Egon, convincendo Wally a prendersi cura della ragazza e a metterla a dormire con lei. Lui si sarebbe sistemato nello studio, sul divano.
«Domani però la riaccompagniamo a casa».
«No, non a casa! Voi non conoscete mio padre. E mia madre, che è sua complice. Portatemi da mia nonna a Vienna. Lei mi vuole bene, mi capisce e ci penserà lei a me. Vi supplico».
Fu una notte tranquilla. Dopo la cena e un po’ di conversazione, e alla fine anche qualche risata per sdrammatizzare gli eventi e far calare la tensione, andarono a letto, la ragazzina e la giovane donna si fecero un po’ di confidenze parlando di uomini come due donne adulte, prima che la fuggitiva, con una camicia da notte di Wally, si addormentasse sfinita. Si lamentò nel sonno. Nei sogni il padre era un mostro crudele. La madre una strega. Quando riapriva gli occhi vedeva Wally dormire tranquilla al suo fianco. Wally era bella. Anche Egon le piaceva. Più di Wally.
La mattina successiva tutti e tre si recarono a Vienna. Egon lasciò Wally e Tatjana alla stazione e tornò a Neulengbach per lavorare a un quadro interrotto prima dell’arrivo della giovane. Un quadro di nudo. La stanza l’aveva riscaldata per far posare Wally. Quel tepore aveva accolto la ragazzina come un caldo abbraccio complice. Tatjana non se ne sarebbe più voluta andare. Egon diede appuntamento a Wally per il giorno dopo alla Westbahnhof. Ma quando tornò alla stazione, rimase sorpreso di vedere la sua compagna ancora con la ragazza.
«Non se l’è sentita di andare dalla nonna, è anziana, non voleva preoccuparla», la giustificò Wally. «Ha passato la notte nella mia stanza d’albergo. Ma arrivati a Neulengbach tornerà a casa, vero, piccola?»
La ragazza fece sì con la testa. Per tutto il viaggio in treno non parlò. Giunti a casa di Egon e Wally, chiese di restare ancora un po’. Il buio arrivò senza che se ne accorgessero. Passò un’altra notte ospite della casa-atelier calda delle sessioni di nudo e d’amore.
«Wally, domani mattina, che lo voglia o no, la riaccompagni dai suoi genitori, va bene? E non farti più incantare dalla sua faccetta afflitta».
«Certo, Egon, stai tranquillo».
Non fecero in tempo. Nelle prime ore del mattino si presentò al cancello di casa Schiele il padre della giovane. Lei lo vide dalla finestra e corse a rinchiudersi nella stanza da letto. Egon uscì in giardino, aprì il cancello e accolse con il suo sorriso migliore l’ufficiale in pensione. Austero e accigliato, ma calmo, l’uomo disse a Egon che aveva saputo da gente del paese che la figlia era a casa sua e aveva già sporto denuncia contro di lui per rapimento e corruzione di minorenne. Egon stava spiegandogli come erano andate davvero le cose, l’uomo sembrava credergli, quando fu interrotto da un grido della ragazza. Corsero dentro, si precipitò nella stanza anche Wally, e la trovarono sul letto, il letto era sporco di sangue e la giovane aveva i polsi tagliati da un paio di forbici. La lama non era così ben affilata e la ragazza poi non così convinta del suo gesto e tutto si risolse con una garza ben stretta sui polsi. Egon e Wally lasciarono padre e figlia a parlare da soli. Quando uscirono dalla camera, l’uomo teneva la figlia quasi in un affettuoso abbraccio. Diressero uno sguardo rassicurante a Wally e Egon, a cui l’uomo strinse la mano. Tatjana diede un bacio sulla guancia a Wally, salutò Egon e i due se ne andarono.
Ed ecco, qualche giorno dopo, la visita del poliziotto e del messo comunale.
Rinchiuso il 13 aprile del 1912 nella cella del tribunale locale in attesa di giudizio, a Egon Schiele, fino al processo dei primi di maggio, non verranno mai notificati i capi di accusa. Era per via della faccenda della figlia dell’ufficiale in pensione? Ma sembrava risolta, non c’era più ostilità nei modi dell’uomo. Per quei disegni sequestrati? Ma era assurdo, non erano altro che disegni, di certo non punibili con il carcere. Le domande sul perché della sua detenzione non gli davano tregua. Occupavano tutto lo spazio della cella. La cella è umida, sporca, buia, i suoi pensieri sono ancora più tetri. Dipinge sulle pareti con un dito inzuppato di saliva. Il muro l’assorbe in un istante. La saliva termina presto. Poco da bere, cibo scarso e da penitenza. Doveva pentirsi delle sue colpe. «Sono innocente. Di questo sono colpevole. Della mia innocenza. Dell’innocenza dei giovani ritratti nel loro erotismo». Il 16 aprile Wally può fargli visita. Non possono neanche baciarsi. Un secondino li osserva. Il secondino se la vorrebbe fare. Il secondino umilia l’artista a ogni occasione. A Wally però la direzione del carcere ha concesso l’autorizzazione di portare al suo uomo matite, pennelli, colori e carta per dipingere e scrivere. Wally sapeva che senza quelli il suo Egon non ce l’avrebbe fatta. E così Egon scrive un diario e, soprattutto, dipinge e disegna tutto ciò che vede: la branda dura, le sbarre arrugginite, le pareti grigie e lerce che trasudano umidità e delitti. Il pavimento opaco dei corridoi che è costretto a pulire inginocchiato a terra con la spazzola, lo straccio e l’acqua putrida. Il cortile dei dannati con le mura troppo alte per far filtrare il sole. Tutto è così oscuro e deprimente. Poi un giorno Wally gli porta un’arancia: è il regalo più bello. Una luce colorata sul grigio-marrone delle coperte. “Un’arancia è stata l’unica luce”. Lui la dipinge invece di mangiarla. Un’arancia e il sorriso di Wally. Potrà affrontare il dibattimento. Il 30 aprile è trasferito nel carcere di St. Pölten dove si svolgerà il processo. Le accuse di rapimento di Tatjana Georgette Anna Von Mosig e corruzione di minorenne sono cadute in seguito al ritiro della denuncia, nonostante le pressioni che la polizia aveva fatto sul padre della giovane per mantenerla e dare una lezione come si merita a quel pervertito. Egon Leon Adolf Schiele è processato solo per esibizione di materiale osceno a minori, visto che per il giudice i bambini che frequentavano la sua casa non potevano non aver visto quei disegni. È una tragica farsa che si conclude con la condanna ad altri tre giorni di prigione da sommare ai ventuno già scontati.
Egon Schiele scrisse nei suoi diari dal carcere: «Non lo nego, non l’ho mai negato, che ho disegnato e dipinto soggetti erotici. Ma nessuna opera d’arte erotica è immonda quando è artisticamente rilevante, diventa tale solo tramite l’osservatore, se costui è un essere immondo. Potrei citare molti artisti, Rops, ad esempio, ha fatto solo quadri erotici, o lo stesso Klimt, e nessuno è stato messo in carcere per questo. Non voglio però giustificarmi, non sarebbe degno di me. Dunque non lo nego. Dichiaro invece del tutto falso che ho mostrato intenzionalmente tali disegni a dei bambini. Che avrei corrotto dei bambini. Ma andiamo! È un’infame menzogna! Tuttavia so che ci sono molti bambini corrotti. Ma cosa significa poi corrotti? Gli adulti hanno dimenticato quanto essi stessi erano corrotti da bambini, cioè stimolati ed eccitati dall’istinto sessuale? Hanno dimenticato come l’impulso li tormentava e li bruciava quando erano bambini? Io non l’ho dimenticato, perché mi ha fatto soffrire terribilmente. E mi fa soffrire ancora».
Il giudice, come esempio, brucia con la fiamma di una candela il disegno della bambina con la mantella arancione.
«Allora andate nei musei a fare a pezzi le massime opere d’arte», scrisse ancora nelle memorie. «Chi rinnega il sesso infanga nel modo più basso i genitori che l’hanno fatto venire al mondo».
I quadri del carcere hanno titoli emblematici, sono manifesti poetici ed esistenziali, sono una denuncia sociale. “Non mi sento punito ma purificato!” è la visione del corridoio della prigione con un albero dipinto sul muro. Autoritratti deformi sono intitolati “Prigioniero!”, “Resisterò per l’arte e le persone che amo”, “È un delitto porre dei vincoli a un artista, significa uccidere una vita nascente”. Nel “Lottatore”, del 1913, si ritrarrà ancora spogliato, lo sguardo vigile verso un oscuro pericolo.
Uscito dalla prigione è prostrato, pur nel sollievo della riacquisita libertà, l’aria della primavera è piacevole e sensuale, e non arreso. I suoi nudi continuano a rivelare nel corpo sessuale il dramma e l’angoscia di vivere come corpi inconciliabili con i tormenti interiori e un’epoca che andava alla rovina. Wally tira su la gonna, apre le gambe, non ha le mutande, ha un paio di calze nere sorrette da giarrettiere rosse come i capezzoli, il seno scoperto, rosse come le labbra della bocca, rosse come quelle vaginali esibite sotto un ciuffo di peli scuri: “Donna con le calze nere” del 1913. “Nudo femminile sdraiato con gambe divaricate” è un quadro del 1914. Ancora quel rosso dei capezzoli e delle labbra della bocca, Ia peluria nera del pube ora occulta le labbra del sesso, un paio di calze marroni coprono metà gamba. Indosseranno le calze al ginocchio anche il soggetto ritratto nel “Nudo femminile con calze verdi”, di quel disgraziato 1912, le gambe accavallate lasciano intravedere i peli pubici neri come i suoi lunghi capelli e le scarpe, e la donna del “Nudo femminile seduto”, ancora del 1914: i capezzoli sono sempre scarlatti come la bocca, le cosce aperte. In “Due ragazze”, dello stesso anno, una è sopra l’altra, il coccige di quella sopra le apre i glutei, quella sotto tiene le mani incrociate sul collo dell’altra e ha delle culotte bianche. “Due ragazze abbracciate”, “Due ragazze sdraiate in posizione incrociata”, in entrambi i quadri una delle due donne è vestita, il tessuto degli abiti a contatto della pelle scoperta e sensibile dell’altra, sono opere del 1915. Il “Nudo femminile sdraiato sul ventre” evidenzia le natiche forti della ragazza, il mento poggiato sul palmo della mano, l’aria del volto indifferente. Tra i glutei della donna del “Nudo femminile piegato” di schiena, la vagina è come una cicatrice fresca, ancora rossa. I due quadri sono del 1917 e Wally in quelle figure e nella sua vita non c’è più. Se non come ricordo che pare modificare i tratti delle modelle. Al suo posto c’è sua moglie e la sua nuova musa, Edith Harms, figlia della media borghesia di Vienna, la città dove è tornato a vivere Schiele dopo la detenzione – basta con la piccola provincia di campagna –, che gli darà un’unione rispettabile agli occhi di tutti. Il 17 giugno del 1915 si erano celebrate le nozze. Il 21 successivo Egon è partito come militare. La Prima Guerra Mondiale vuole tutti gli uomini validi con la divisa addosso. Lui come artista si risparmia il fronte: presta servizio con l’incarico di furiere e dipinge ufficiali e prigionieri russi. Praga, il ritorno a Vienna, poi Mühling e di nuovo Vienna, al museo militare. Lei lo segue sempre. Quando non sono nella capitale austriaca, Edith aspetta la libera uscita del marito in una stanza d’albergo vicino alla caserma.
«Non è vero, Egon. Non può essere vero. Quando andavamo al cinema con le sorelle Harms, quando uscivamo con loro a prendere il gelato tu già…».
«Wally, ascoltami. Ti prego ascoltami. Non è finita. Io ho ancora bisogno di te. Ma devi andartene da qui».
«Non puoi farmi questo. Ma perché? C’ero io quando ci cacciavano via da casa nostra, quando ti hanno messo in carcere. C’ero io a portarti i colori e le arance. C’ero io nei tuoi quadri. C’ero io nuda con le calze. Io nel letto», urlò Wally in lacrime, prima di lasciare quella che era stata la loro l’ultima casa-studio viennese.
«Aspetta, Wally! Non così, Wally, non così!»
Pochi giorni dopo lui le dà un appuntamento in un caffè. Le porge un foglio tirato fuori dalla cartellina dei disegni.
«Guarda qua, Wally. Vedi, ho scritto un accordo tra di noi, un contratto, una promessa, leggi: c’è scritto che ogni anno passeremo le vacanze estive insieme. Anche se mi sposerò, tu sarai sempre il mio amore, la mia Wally, che ne dici? Io voglio vederti ancora, per sempre».
Quella fu l’ultima volta che lui la vide. Wally Neuzil si arruolò come crocerossina e prestò servizio presso l’ospedale militare di Vienna, prima di chiedere il trasferimento al fronte. I corpi che adesso vedeva non erano deformati da conflitti interiori ma mutilati dalla guerra. Morirà il 27 dicembre del 1917 con il corpo deturpato dalla scarlattina, a Sinj, in Dalmazia. Nessuno ha mai saputo dove è stata seppellita. Aveva ventitré anni. L’aveva uccisa lui, che ora si ritraeva con la moglie. Nel quadro “Coppia seduta”, Edith si stringe a Egon, lui indossa solo una camicia alzata sull’addome, pare assente, lo sguardo vitreo perduto altrove. Lei è vestita, ai piedi ha un paio di calzini arrotolati alle caviglie, gli occhi chiusi e sembra capire che suo marito sarà sempre innamorato della sua modella preferita. La famiglia del quadro omonimo raffigura Egon e Edith nudi. Lui è dietro di lei, lei è ingrassata, sono seduti, davanti a loro, tra le cosce di lei, c’è un bambino, vestito. Il quadro è del 1918 e sono tutti e tre tristi. Il dipinto esprime un’infelicità infinita. Quel bambino non nascerà mai. Edith Harms spirerà il 28 ottobre a causa dell’influenza spagnola che stava provocando più vittime della guerra ormai giunta al termine in una nazione distrutta e sconfitta. Era incinta di sei mesi. Egon Schiele ritrae la sua agonia. Poi la seguirà senza tante opposizioni: la febbre spagnola sarà l’ultimo abbraccio con sua moglie che lo trascinerà con sé il 31 ottobre 1918.
Anche se fino alla fine l’abbraccio che Egon ricorderà, sentendolo sul suo corpo stremato e consumato dalla malattia, sarà quello di Wally, solo quello di Wally. Il suo abbraccio energico e dolcissimo, traboccante d’amore. Al termine pieno di disperazione. Un anno prima di morire, Egon Schiele aveva dipinto “Abbraccio (coppia d’amanti II)”: Egon e Wally sono nudi e stretti l’uno all’altra, i loro capelli si confondono, lei tiene le mani sul viso e sulla schiena di lui con le dita nelle stesse posizioni di quando Egon si ritraeva in tanti quadri. Con “atto d’amore”, del 1915, si stringono ma sono vestiti, lui le tiene i capelli tirati su, lei ha sollevato una coscia sul suo fianco, non si guardano, guardano, con gli occhi svuotati dai sentimenti, punti che non saranno più in comune. Un altro abbraccio porta la data 1915-1916: ci sono ancora lui e Wally, lui indossa un cappotto marrone, lei un vestitino dai disegni color arancio. Lui studia la loro immagine riflessa in uno specchio. Lei lo cinge con le sue braccia, le sue braccia sono magrissime ed esageratamente lunghe, come due elastici, due corde che vogliono legarlo a sé, le mani nelle solite posture di quelle di Egon. Lei ha l’espressione triste. Fu iniziato poco prima che si lasciassero, quando lui già sapeva che stava finendo tra di loro e lei avvertiva la malinconia dell’abbandono, e fu portato a termine l’anno dopo, quando di lei non restava che la nostalgia. Era intitolato “L’uomo e la fanciulla”. Appresa la notizia della morte di Wally, Egon gli cambiò titolo in “La morte e la fanciulla”.
[1] Pubblicato su “Verde” del 22 gennaio 2018.
Con la pubblicazione della terza puntata di Ascenseur pour l’échafaud, possiamo dire di essere i primi a dare il via alle celebrazioni per il centenario della morte di Egon Schiele (31 ottobre 1918): non dobbiamo linkarvi nulla, lo conosciamo tutti, vero? Altrimenti leggete la lectio magistralis di Sergio Gilles Lacavalla, basterà, scoprirete della sua vita, della sua pittura e della musa Walburga “Wally” Neuzil. L’illustrazione è di Federica Consogno. Viva il lunedì, buon inizio di settimana con le cose splendide che vi regaliamo.
View original post 3.610 altre parole
amoR[1] (variazioni sul tema di un incontro)
Nota dell’autore. “amoR” è un atto unico che racconta la storia di una lei e un lui in una città. È il racconto di sentimenti che sono aspettative deluse e desideri: che sono luoghi. Può essere rappresentato sia in forma di monologo di lei sia di dialogo tra lei e lui che si trasforma nel monologo di lei. Qui è nella forma monologo che indica ben chiaro l’eventuale svolgimento come dialogo. Parole per corpi che non si sono mai incontrati, se non in una carezza, in un abbraccio non compreso, in notti infinite di parole e musica, in sguardi. Con Le Soldat Perdu, il nome della mia nuova compagnia teatrale, sto affrontando il tema del rimpianto e della perdita – forse l’ho creata per parlare di ciò. Se in “Jeanne e Gilles” c’era il rimpianto da parte dei due protagonisti di non essere riusciti a perpetuare il loro amore smarrendolo in motivi che non sono mai riusciti a capire fino in fondo, e il tentativo di ricrearlo in un pomeriggio in un albergo abbandonato come loro si rivelerà il solito fallimento. La solita disperata illusione. In “amoR” il rimpianto sta nel non essere riusciti neanche a esprimerlo in un pomeriggio, soltanto un pomeriggio o una notte, questo amore. Ma che cambia? In tutte e due le situazioni il risultato è lo stesso, per tale motivo alcuni momenti di una storia li ritroviamo nell’altra, istanti ed elementi che riverberano nei diversi personaggi che a tratti si confondono, e che, tutto sommato, sono sempre gli stessi. Gli amanti perduti sono sempre gli stessi. Un amore finito, un amore non vissuto, sono la medesima cosa. Resta la domanda di cosa sarebbe stato delle loro vite se fossero stati capaci di amarsi. Potevi essere felice e non ne sei stato capace. O peggio, non ne hai avuto il coraggio. Forse. Tutto qui. Le Soldat Perdu non sa la risposta, per tale motivo si pone la domanda. In “amoR” ricorrono anche alcune vicende estranee e vicine ai due poveri amanti mai stati amanti che i più attenti si accorgeranno di averle già lette in altre mie scritture: perché poi le cose si ripetono. Perché Le Soldat Perdu è immerso in queste storie di vita e malavita, perché le nostre storie sbagliate sono solo alcune tra le tante storie sbagliate. La città dell’atto che leggerete, come dice il titolo, forse un po’ scontato, è Roma (letto al contrario così che dia amoR). Ho voluto un titolo semplice perché l’amore è semplice; siamo noi che lo rendiamo complicato. Semplici sono i desideri dei due amanti, perciò impossibili. Se questa scrittura parla di ciò che poteva essere e non è stato, lo stesso vale per questa assurda decadente città. Ho chiamato la mia compagnia Le Soldat Perdu (Il Soldato Perduto, nome preso dal film “Apocalypse Now Redux”) perché a volte si è stanchi della guerra che distrugge le nostre piccole vite. Che poi questa guerra l’abbiamo dichiarata noi o la stiamo solo subendo combattendola con le poche inutili armi che abbiamo a disposizione, è un altro discorso. “Lei è stanco di questa guerra, glielo leggo negli occhi. Ha lo stesso sguardo che avevano i soldati della nostra guerra. Li chiamavamo les soldats perdus, i soldati perduti. Se vuole posso offrirle un po’ di cognac”. “No… io devo… devo andare a occuparmi dei miei uomini”. “La guerra ci sarà anche domani”. “Sì, è vero, ha ragione”. (“Apocalypse Now Redux”, Francis Ford Coppola) LEI Forse i luoghi dove non abbiamo mai abitato sono i nostri luoghi. Un’estraneità che diventa conoscenza in un’ipotesi. Hai mai nostalgia di un posto dove non hai vissuto? «Abiteremo un appartamento per ogni stagione: quattro case in quattro zone diverse di Roma», dicevi tu. «Ma Roma ha solo due stagioni», ti feci notare io. «Inverno e estate». «Allora un appartamento per ogni fase del giorno: uno per la mattina, uno per il pomeriggio, la sera, la notte. Uno per ogni mese dell’anno, tutti in quartieri diversi: conosceremo questa città abitandone la quotidianità. I momenti delle nostre giornate. Perché solo così potremmo dire di conoscerla veramente. Di conoscerci». «Perché vuoi conoscermi?» ti domandai. Tu non rispondesti. Ci conoscevamo appena. C’è la storia di un incontro. Lui pensa che lei sia bellissima e… sorprendente. Semplicemente sorprendente. Anche lei è meravigliata nel vederlo. Non si aspettava uno scrittore che sembra più un peso leggero di pugilato che un intellettuale. “Sai, ti fai certe idee. Chiuditi la camicia”, gli dice lei fuori. “Fa freddo”. Forse non fu quella sera. Ma glielo disse. Deve averglielo detto. Perché lui lo ricorda. Lui ricorda ogni momento di lei. E lei deve avere queste attenzioni. Tornando a casa, lei gli manda un messaggio sul cellulare augurandogli la buona notte e dicendogli che è contenta di averlo conosciuto. La luce sul cellulare illumina la notte delle sue parole. Una notte diventata luminosissima. Da quanto per lui la notte non era così luminosa. Sì, lei era proprio sorprendente. C’è qualcosa che può colpirti di più della spontaneità? Lui ricambia. Avrebbe voluto dirle anche altro – lui avrebbe sempre voluto dirle altro, ma ogni volta gli mancavano le parole, con lei era uno scrittore senza parole, che pena! Non trovate? Povero piccolo scrittore senza parole, a che ti è servito riempire tutte quelle pagine. Che fallimento, povero stupido tesoro! Lui le aveva regalato un suo libro scrivendole una dedica presa dall’Idiota di Dostoevskij: “La bellezza salverà il mondo”, diceva la frase. Almeno per quella notte, lui ne è convinto. Se non proprio il mondo, almeno il suo, di mondo. Il suo mondo insensato, davanti a quegli occhi riprendeva il senso perduto, forse mai avuto, forse dimenticato. Incontrarla per caso e dirglielo. Se poi lui davvero la rincontrasse per caso, attraversando la strada, in una mattina, un pomeriggio, di sicuro glielo direbbe che è proprio bella. Poi, si sa come a volte vanno le cose e quello che poteva essere rimane l’unica realtà conosciuta. Potevamo essere e invece non siamo stati. Incontrarsi per caso, ormai. Ormai, ormai, ormai: quanto sarebbe bello non dover dire ormai. «Inventiamoci un ricordo», ti dissi. «Dal nostro balcone di vede Via del Corso: lo sai che lì c’ha suonato Chet Baker? Il jazzista americano. Sì, in strada, per raccogliere i soldi per l’eroina. Era il periodo in cui gli andava proprio male. Siamo sul nostro bel balcone e sorseggiamo un drink. Non guardiamo la gente che passa giù, perché giù non c’è più Chet Baker a suonare. Ascoltiamo un suo disco che arriva dalla camera adiacente al balcone, la camera è grande, il balcone è piccolo, come tutti i balconi sopra il Corso, ma c’è spazio a sufficienza per noi due soli, siamo seduti su due sedie, i miei piedi nudi poggiati sulle tue gambe, sporchi sulla pianta del pavimento del balcone impolverato dal cielo di Roma, e ci guardiamo i visi. Il cielo a Roma è sporco eppure splendido a quest’ora. Sembra proteggerci e dà una bella luce ai nostri volti. Qualcuno ha detto che il cielo di Roma è un grande direttore della fotografia. Chet Baker alzò anche un po’ di soldi. Riuscì pure a suonare in qualche piccolo club. Siamo all’ultimo piano, sotto la folla del sabato pomeriggio, le persone sono onde di un mare in tempesta, il nostro balcone è la salvezza sopra l’albero maestro di una nave, fisso, solido, sicuro, nonostante lo scafo sia sballottato dalla burrasca. C’è qualcosa di violento in tutta quella gente che passeggia e fa compere nei negozi uno attaccato all’altro, i portoni delle abitazioni sono vie di fuga, un ladruncolo prende l’ascensore, preme un pulsante a caso, mentre sale conta i soldi, torna in strada lasciando il portafogli nella cabina e le sue porte aperte, ha anche le tasche piene di cioccolatini del bar, le scale, consumate e storte dal tempo, conducono all’albero maestro dove i due amanti si stanno arrampicando, anche loro hanno dei dolci, pasta di mandorle e bonbon per il Martini. Chet Baker riuscì a non impegnarsi la tromba. Non lo arrestarono mai a Roma». «Questa città non ho ancora capito se accoglie o respinge», dicesti tu. «E chi lo sa, forse entrambe le cose. Comunque ci sono i portoni, no? Comunque quella storia su Cher Baker l’ho letta in un tuo libro». L’alito sa di cioccolata e liquore. «Poi c’è una casa davanti alla residenza dell’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America. Proprio lì si andò a schiantare contro un camion la Ford Thunderbirdh del 57 del cantante torinese Fred Buscaglione. In una fredda mattina di febbraio del 1960 alle 6 e 15 circa, all’incrocio tra Via Paisiello e Viale Rossini. Correva verso il Rivoli, l’hotel dove abitava nei suoi soggiorni romani. La sua casa ai Parioli. Con la sonda spaziale Luna 1 che gli diceva: “Avanti, Fred, accelera, corri, corri di più. Non avere paura. Dai”». «Come James Dean con la sua Porsche 550 Spyder, la sua Piccola Bastarda, l’aveva battezzata così l’attore americano, sotto il sole pomeridiano della California Jimmy premeva sull’acceleratore e Fred con la sua Criminalmente Bella faceva scoppiare il contachilometri verso la fine rischiarato da due lune che andavano a sparire verso il sole di un gelido inverno romano. “Su, spingi ancora”. Come dici tu. “Andiamo”. Anche Jimmy cercava la morte. Nessuno ha pensato al suicidio di James Dean». «Figuriamoci a quello del Grande Fred. Fred voleva morire da quando sua moglie l’aveva lasciato». «Pure James Dean era stato abbandonato, da Anna Maria Pierangeli, si era sposata con un altro. O forse era innamorato del suo meccanico, Rolf Wütherich. Tanti anni dopo morirà anche lui, diventato pazzo da quell’incidente e ancora su una macchina guidata ad alta velocità. Acceleri, acceleri di più. Non fai caso a chi ti si para davanti. Una Ford Coupé bianca e nera». «Un Camion Lancia Esatau. Non so di che colore. Deve essere andata così per Fred e per Jimmy Dean. Per quegli abbandoni e perché la vita di tutti i giorni era diventata meschina. Che ci fai delle stelle quando le tue giornate sono grigie e meschine. Tutti sono meschini. Ogni cosa è meschina. Te ne accorgi ed è la fine. Acidità di stomaco – al posto del whisky ormai gli davano il tè, a Fred dal whisky facile – e meschinità. L’acidità ti viene perché sei infelice. Non sono tanto le tragedie – e poi chi decide cosa è per te una tragedia –, quanto la miseria della vita a ucciderti. Con la luna e la sonda sovietica che la mancò miseramente a incitarlo a esibirsi nel suo ultimo imperdibile spettacolo». «Oltre le Colline Perdute il sole accecò James e il suo giovane assassino». «La luna. Il sole. A Roma possono essere bellissimi. Il cielo lurido e splendido non riesce a sporcarli. È questo il motivo per cui non siamo ancora saliti su un’automobile senza freni? Parliamo di quelli: della luna, del sole di Roma. Oppure raccontami una storia nera su questa città nera malgrado il sole e la luna. Ma non tacere. Non tacciamo. Ho paura dello spazio che si crea nel silenzio. Ho paura che il silenzio voglia dire allontanarsi: due persone non si sentono più perché si sono allontanate troppo. Parlano al vuoto. Parlano a vuoto. Allora parla e io ti verrò dietro. Nonostante sappiamo che non riusciamo quasi più a vederci niente di bello in questa città, parla di lei. Prima c’era stata la morte di una ragazza chiamata Wilma Montesi, ecco, mi avevi raccontato. No, non l’avevi raccontato proprio a me, ma l’avevi fatto. Era la serata per Wilma. Dwight Holly distribuiva le carte della malasorte. Aveva diciannove anni, o ventuno, non ricordo, e abitava anche lei ai Parioli, sì, lì vicino, a Via Tagliamento, dove c’è il Piper (se i roadie non l’avessero tirato giù dagli amplificatori su cui si era arrampicato, Kurt Cobain si sarebbe buttato rompendosi l’osso del collo, molti anni dopo Wilma, la data romana dei Nirvana al Piper, la stanchezza e il disgusto di essere una rockstar), nel quartiere Trieste, accanto alle case esoteriche del Coppedè. Dario Argento vi girò alcune scene de “L’Uccello dalle Piume di Cristallo” e di “Inferno, lo sai? Wilma morì sul litorale romano. Una storia torbida che coinvolse politica e musica jazz. Piero Piccioni, figlio del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri democristiano Attilio Piccioni, jazzista col nome d’arte di Piero Morgan. Jet set e Regina Coeli. “Goddess in a dream. In my dream. Wilma Montesi Jazz Love Tragedy”, la cantavano i Macelleria Mobile di Mezzanotte, ricordo bene quella sera. L’elettronica, un sax e la tua voce che a tratti affogava nel torbido mare di quella storia le cui onde si infrangevano su una spiaggia sporcata dal presente. Non c’era nessuno, il locale era desolato. La barista in latex e le bevande colorate dal ghiaccio illuminato dalle luci del bancone. Io però c’ero. Non dimenticarlo». “Wilma nei sogni non ha mai le calze. Il tallone arrossato dalle scarpe. Sempre senza la gonna. Senza calze né reggicalze. Lui la sognava così. Con l’acqua marina che le carezzava i piedi. Piena della sabbia di Torvajanica. Acqua e sabbia. Nella gola. Nella vagina. Le mutande bianche, bagnate. Sembrava dormisse, sulla spiaggia di Capocotta. Con la faccia riversa sul bagnasciuga. Senza scarpe. Le scarpe per bene fanno male. La gente bene fa male. Gente bene e assassina che avrebbe indicato la strada verso il massacro del Circeo e cene eleganti”. Recitavi tu facendo riaffiorare un passato mai passato davvero in una città indelebilmente macchiata dalle sue colpe. La borghesia a Roma fa veramente schifo. I suoi figli fanno schifo. Non cambiano mai. Quando non uccidono – se non è su una spiaggia una banchina del Tevere va bene – sfruttano, ricattano. Li vedi al bar con i loro maglioncini da quattrocento euro, le parole sbagliate e le risate ebeti. Eppure certi quartieri borghesi sono così ricchi di fascino, con una certa grazia». «Un appartamento al rione Prati. Gli edifici in stile umbertino e liberty. Hanno stanze spaziose. L’arredamento sarà minimal. Non c’è bisogno di molto, quando ad abitarle ci sono due corpi. Guarderemo i nostri corpi. Ci basteranno i nostri corpi. I grandi bar, le pasticcerie con tutti quei dolci profumati, più buoni di quelli comprati a Via del Corso». «È per via dello zucchero a velo, il profumo che invade il marciapiede è dovuto allo zucchero a velo buttato sui fornelli per far arrivare l’odore in strada. I bei ristoranti e le pizzerie, neanche care poi. Via Cola di Rienzo. Via Ottaviano. I negozi di abbigliamento e le librerie. Mi leggerai un libro sfogliando le pagine a caso mentre io ti guardo. E il caos di questa città si ordinerà dentro pagine infinite con la musica e in noi corpi ora tranquilli in una pausa rubata ai delitti di una città che ci sentiamo pesare addosso perché siamo infelici. A strapparci noi due un foglio ancora di illudente serenità confusa nei nostri cuori mai in pace. Una frase e un’altra che non avrò ascoltato perché all’improvviso troppe parole scure si avviluppano intorno al battito lento delle mie vene. Poi riprenderanno a scorrere, le tue parole, da una bocca che sento che ha voglia di me e mi dirai che hai mollato la tua anima appena mi hai visto. Me lo dirai perché non sei capace a dirlo. Ma tra i libri si può. L’attribuirai a un poeta. “È arrivata limpida come qualcosa che hai sempre saputo ma che non sei mai riuscito a dire”, canta Liam McKahey accarezzandoci leggero con la sua voce morbida che si spande lenta in un posto dall’odore di carta e vaniglia e luci basse nel mattino di nuvole. Mi dirai che l’hai lasciata dentro di me, la tua anima, o qualcosa che le somiglia, appena sono arrivata come qualcosa di puro e d’inaspettato ma che avevi sempre saputo che c’era, proprio come sta sussurrando il cantante dei Cousteau. E perché non mi hai cercato? Mi aspettavi silenzioso da qualche parte e così ora ci apparteniamo, fino alla morte. Sorriderò spaventata. Io non voglio che mi parli di morte. Roma è mortale, lo so. Le tue storie sono mortali. La tua pistola è vera, non è solo di scena. È pesante. Non so se il caricatore è pieno. Ma è pesante. La camicia nera e la pistola nella fondina marrone sotto l’ascella. Un anello d’argento al dito della mano destra che brilla quando afferri il microfono. Ha una rosa nera stretta tra i denti. Un po’ inquietante. Non so nulla del tuo passato, e anche se deve essere stato pieno di dolore, questo non giustifica niente. Non so niente del tuo presente. Vorrei sapere tutto del tuo futuro, quando sarà il nostro presente. Smettila di parlarmi di morte, di nessuna morte. Ma io faccio lo stesso, forse solamente per intrattenerti e somigliarti e piacerti e perché la città è diventata più violenta. Almeno è così che l’avvertiamo. Con le sirene delle volanti e il rumore degli elicotteri in cielo. Le ambulanze. Un uomo pochi giorni fa ha ucciso la compagna e la figlia di lei e si è buttato giù da un edificio occupato alla Stazione Termini. I soldati alle fermate della metro sono armati di mitra. Una ragazza ha tatuate rose nere e bianche sulle cosce pallide. Mi fermo a guardare quei fiori, poi più su: anche il seno è ornato da rose. La ragazza è completamente nuda. Sulle braccia sono disegnate antiche bambole giapponesi e vittoriane. La pancia, tonica e con delle leggere pieghe per via della posizione della giovane seduta sull’asfalto, è priva di tatuaggi. Il pube è depilato, a parte una sottile striscia di peli neri al centro. Al suo fianco c’è un’altra ragazza, tutta nuda anche lei (indossa solo le scarpe), ma senza nessun tatuaggio. I capelli biondi, tagliati cortissimi. Quelli dell’altra, invece, sono lunghi e neri come la sua peluria e lisci. Il basso ventre della bionda è rasato del tutto. Le labbra vaginali si mettono in evidenza, quasi si dischiudono, mentre poggia un ginocchio sul marciapiede e piega l’altra gamba a toccarsi il seno che scende morbido sulla coscia, tenendo la suola dello scarponcino alla caviglia col tacco a stiletto a terra, e comincia a infilare, lentamente, degli aghi sul braccio e sui seni della sua partner. Righe di sangue colano sull’avambraccio, sulla mano, sui capezzoli e sui fianchi, anch’essi ricamati da rose e bambole dell’età del jazz, colorando di rosso buio i volti, i fiori e la pelle. Non è sangue cattivo. Anzi, è così vitale. Eppure le poche persone che le guardano fanno un passo indietro quasi spaventate, o impressionate. Pensano che quel sangue possa essere infetto. Non c’è musica. La ragazza tatuata si gira di lato e porta il viso a sfiorare il suolo esibendo la schiena, che viene trafitta dalla sua amica con piccoli ganci che fanno piangere di rosso gli occhi delle bambole anni Venti dipinte sotto la pelle delle anche e tracciano righe irregolari sul dorso. Il sangue le solca i glutei senza disegni e le piante dei piedi nudi sporchi della strada. Sopra i piedi ci sono altri piccoli disegni: ancora bamboline. La performer senza tatuaggi ha appena cominciato a leccare quelle ferite, lei non ha paura delle malattie, poi conosce bene la sua amica, e comunque che le importa, quando, alzando appena lo sguardo, si accorge che sta arrivando la polizia. Tocca sulla spalla la sua compagna che solleva il viso. In un attimo sono in piedi, raccolgono gli abiti vicino a loro e il bicchiere con i soldi delle offerte, lo infilano dentro una borsa, e scappano. Gli agenti provano a inseguirle, ma le ragazze sono più veloci, più giovani, più allenate, le gambe più muscolose, sono più furbe e hanno un certo vantaggio: si dileguano per le vie vicino a Piazza della Chiesa Nuova, dove si erano esibite. Una casa su Corso Vittorio Emanuele II o a Campo de’ Fiori. Se le avessero prese le avrebbero massacrate di botte, probabilmente violentate in un commissariato. Comunque le guardie si fanno grandi davanti alla gente per aver interrotto quell’oscenità costringendo le due alla fuga. Dio, ma cosa c’era mai di osceno in quell’esibizione!? Non erano oscene. Erano bellissime. Il sangue era nettare che nutriva splendide rose fesche profumate d’arte e sudore e volti di bambole serene d’altri tempi e d’altri luoghi. Non ho mai avuto il coraggio di tatuarmi anch’io rose sul seno. Quando mi faccio piccoli disegni sulla pelle, con l’acqua poi spariscono. Ho preso la metro, era deserta. Ma c’erano loro, sai? Le ho riconosciute subito, anche se si erano rivestite. Probabilmente entrando in uno di quei portoni aperti del centro dove la ragazza bionda ha disinfettato le ferite della sua partner. Odore di salviette detergenti per la pelle. La ragazza tatuata provava ancora il senso di ebbrezza che devono darle quelle superficiali ferite; lo prolungava ridendo e baciando la sua amica e contando i pochi spicci rimasti nel bicchiere dopo aver fatto la spesa da Tuodì: due birre, un pacco di pasta corta, sugo ai funghi in barattolo e una vaschetta di Profiterolles. Il dolce finale alla cena. Sono scese qualche fermata prima della mia. Il métro era ormai un treno fantasma verso il nulla. Tre controllori oltre i tornelli d’uscita chiedono i documenti a due ragazzi trovati senza biglietto. Lei cerca di giustificarsi, dice appena qualche parola, rossa in viso, ma uno degli uomini in divisa le intima di stare zitta, bruscamente; è un ordine che non tollera repliche. Interviene il ragazzo – penso sia il fidanzato della giovane. Anche lui viene messo a tacere, da due poliziotti che fanno da scorta al personale di controllo: lo ammanettano, dopo una manganellata sui reni. Gli agenti portano via i due giovani. Lei comincia a piangere. Fuori dalla stazione della metropolitana trovo la sera. Avrei voluto almeno il tramonto, avrei voluto che i due ragazzi passeggiassero sotto il crepuscolo, invece è già sera. La luce è quella dei negozi e dei lampioni. Le rose, sotto i riflessi artificiali, ora tracciati dalla pioggia sopraggiunta all’improvviso, marcirebbero. Marcisce tutto in fretta in questa città. Siamo soli e infelici e così ci accorgiamo di tutta la sua durezza, della sua crudeltà, delle sue miserie, non tralasciamo niente, e ci fa male, troppo male. Noi siamo il mondo che sta male, la nostra città che soffre in un interno o agli angoli delle strade. Ne sentiamo la pena, la sopportiamo con difficoltà, spesso non la sopportiamo più. Una ragazza era alla finestra, l’ho vista girare per casa in slip e reggiseno, erano spaiati, le mutandine arancioni con piccoli disegni verdi, non sono riuscita a capire cosa rappresentassero, il reggiseno a righe sottili blu su sfondo rosa, l’ho vista che entrava coperta da un lenzuolo di tela bianca, quasi grigia e ruvida, in un’ambulanza con la sirena spenta. Non c’era bisogno di far lampeggiare la luce né di correre. Ricordi i dettagli quando non riesci a pensare, quando sei così stordita da non riuscire a pensare a niente. A volte te li inventi: i dettagli che piacciono a te. Il suicidio è un’alternativa, la tristezza ti ottura i pori della pelle, il respiro si affanna, ti guardi intorno e non c’è nessuno, nessuno che respiri il tuo respiro. Io però non ho mai voluto morire. Avevo soltanto pianto l’intero pomeriggio abbandonata nella vasca da bagno. Vorrei che mi parlassi carezzando il mio corpo nudo e indifeso nell’acqua profumata, che mi dicessi che il mio seno è perfetto, come la mia pancia e il mio sedere, le mie gambe e i miei piedi, il mio pube con la peluria bagnata – lacrime di piacere e tristezza dal pube. Ti piacerà elencare le parti del mio corpo come in un film di Jean-Luc Godard, perché sei uno scrittore e io ti piaccio. Mi dicevi che ero bellissima, mentre io mi sentivo brutta e volevo solo lasciarmi andare nei tuoi complimenti teneri e sinceri, senza più quelle lacrime di debolezza e insicurezze – lacrime di piacere e tristezza dal pube; sul viso dagli occhi stanchi. Così anche tu ti abbandonavi, giù fino in fondo a quelle parole sul mio corpo trattenendo le tue lacrime; ma mai le mie. Lacrime da uomo innamorato – se solo piangessi, senza abbassare lo sguardo, solo perché ti piaccio, e allora ti commuovo. Una mattina tra i libri e il caffè caldo e le note di piano con le parole del cantante dei Cousteau. Mi laverò appena la faccia, sulla pelle del corpo ancora l’odore della notte e ancora bagnoschiuma d’albicocca e con le labbra screpolate, solo un po’ di burro di cacao messo per strada e i capelli tirati indietro con una fascia, scoprendo il mio viso privo di trucco, ti chiederò di leggermi una poesia. Mi tocchi il palmo della mano con una piccola ferita di carta affilata e ti sporchi del mio sangue penetrando leggermente nella mia pelle. Chiudo la mano sulla tua, quando mi leggi un’altra riga da un libro che non avevo mai letto. “Un così meraviglioso sboccio di bellissimi e foschi fiori l’appresi soltanto a frammenti”, leggi da un libro di Jean Genet. Petali di crudeltà e giustizia si spalancano attimo dopo attimo a frazioni di allucinante, inspiegabile meraviglia in una città che marcisce nel crimine. Riapro la mano lentamente sul tavolino e l’avvicino al tuo viso. Fuori dalla porta a vetro al piano inferiore sta piovendo e il sangue della mia mano si diluisce sul marciapiede per essere poi inghiottito sotto di esso. Nessuno lo vede quel sangue. È solo pioggia per chiunque passi. Forse è davvero soltanto acqua, però adesso tu riabbassassi lo sguardo, anche se volevi leccarmi la mano, e continui a leggere e allora io so che è sangue. Che cola sul libro; si assorbe nel foglio e sulle tue dita. Alzi gli occhi e confondi il tuo sguardo nel mio lasciandomi dentro le sensazioni che scorrono morbide nelle tue pupille come lacrime a lungo represse. Vorrei che ci lasciassimo andare una volta per tutte nei nostri occhi lucidi. Inventiamoci un ricordo. Inventiamoci un passato. Il presente non ha storia, non ha basi. Che fare se fuori la pioggia si mischia sempre al sangue? Le strade si coprono di fango e si allagano. Tienimi stretta a te correndo sotto la pioggia. Ma non ho il coraggio di dirtelo. Vediamo gli orrori di questa città perché non riusciamo ad abbracciarci. “Ogni uomo è prigioniero del proprio desiderio” continua a cantare Liam McKahey; e noi siamo in trappola ormai. Ormai, ormai, questo ormai lo vorrei, se la trappola fosse la nostra unione, si dice anche relazione, rapporto, storia: raccontiamoci una storia. La nostra storia, stavolta. Usciamo, ha smesso da poco di piovere, l’aria non è cattiva. Malgrado non ce la facciamo a respirarla. Nell’acqua c’è una pagina strappata da un libro con sopra scritto: “Non mi seguirai mai. La fine delle risa e delle morbide bugie. La fine della notte in cui abbiamo cercato di morire”. Io ti seguirò fino alla fine, mi dirai tu, dopo che avremo letto quella frase insieme. Sorriderò annuendo, come a dirti: anch’io. L’odore di vaniglia e caffè è nell’aria fredda fuori dalla libreria e il vento gelido sembra non riuscire a soffiarlo via. Passeggeremo in silenzio. Mi regalerai un paio di scarpe. Me le proverai tu, perché i miei piedi sono stanchi per aver camminato troppo sui tacchi. Compreremo pane fresco, ne mangeremo qualche pezzo verso casa, le nostre case sono ancora una distante dall’altra, strappandolo dallo stesso filoncino dentro la busta di carta con lo scontrino adesivo, e fiori secchi profumati da mettere vicino alle lampade. I chioschi dei fiorai a Roma non chiudono mai. Piazza Risorgimento e in fondo c’è la Città del Vaticano. Sui muri e sui pali della luce, tanti anni fa, c’erano dei manifestini con scritto: “Emanuela Orlandi, anni 15 – alta mt. 1,60. È scomparsa”». «Preti e orge, servizi segreti e attentatori del Papa, lo IOR e la banda della Magliana. Si dirà. Si dice ancora. Tutto qui diventa un si dice, un film, un rebus, un complotto, una favola e ci puoi mettere dentro chiunque e chiunque andrebbe bene, tanto chiunque è colpevole». «Ma forse è solo fuggita da questo schifo di città. Uccisa perché qui nessuno sopporta l’innocenza. Noi siamo innocenti? Anni 15, è scomparsa. Poi il quartiere Della Vittoria. Con l’Osservatorio Astronomico: non ci sono mai entrata in quel posto in alto, non me ne è mai fregato niente di guardare le stelle da un osservatorio, magari con qualcuno che te le vuole anche spiegare, a me le stelle piace guardarle dal nostro appartamento, sul balcone o dal letto rischiarato dalla Luna. La luna, il sole sul letto umido. Hai mai corso allo Stadio dei Marmi, sotto il sole con il sudore che d’estate ti liquefa e d’inverno ti gela? «No». «Era bellissimo sentire i muscoli delle gambe e della pancia tendersi e il fiato accelerarsi insieme al cuore e ti sembrava di morire di una morte piena di vita, ti faceva male e ti faceva bene, sulla pista rossa di atletica leggera vigilata dalle enormi statue nude di atleti di marmo; il senso di eternità che Roma ancora conserva nei suoi monumenti e nel tuo respiro alterato dalla corsa. Riprendere fiato nuotando piano nella piscina del Foro Italico e negli spogliatoi, la doccia è una pioggia pulita e tiepida in cui riesci a non pensare, a non pensare a niente, e l’assenza di pensiero ora è benefica, un sollievo, non pensare a niente se non al tuo corpo bagnato e ti senti davvero immortale. Con uno strano languore al quale ti lasci andare a lungo, nell’acqua profumata di vaniglia e miele che scorre sul tuo corpo e si perde tra i piedi sul pavimento di maioliche. Il costume sulla panca. Poi fuori, con i tuoi abiti addosso e nelle strade grigie, in quella zona le strade sono sempre grigie, anche d’estate, è colpa dell’architettura e degli studi legali, torni a essere una comune mortale e stai di nuovo male. Via Poma, l’omicidio di Simonetta Cesaroni. Portieri, e ancora figli e nipoti della Roma altolocata e fidanzati di periferia. La sua cronaca nera è ovunque. Si perpetua in nuove vittime per nuovi articoli di giornale. Alla fine sembrano tutti uguali. Non si arriva mai alla verità. Se parli di questa città non puoi evitare di parlare dei suoi misfatti, inutile, non puoi. Per noi però saranno soltanto trasmissioni d’inchiesta e documentari alla tv. Una serie su Netflix. Solo per fare qualche commento. Perché noi ce ne fregheremo. Perché gli amanti se ne fregano della cronaca, se ne fregano della storia. Esiste solo la loro storia. Nella nostra casa con la televisione accesa, piatta e appesa alla parete come uno schermo cinematografico. Guarderemo “Babylon Berlin” su Sky e concorderemo che è una bella serie, parteggeremo per il morfinomane commissario della Buoncostume Gereon Rath e l’intraprendente e disinibita dattilografa precaria della Omicidi e mistress Charlotte Ritter e faremo finta di ballare e peccare anche noi al Moka Efti. Dopo usciremo e andremo al mare. Non sarà mai un mare tragico e di violenza. Anche se ogni volta che ci vado non posso non pensarci. Sul litorale romano massacrarono Pier Paolo Pasolini. Scrivevi tu: “Il volto ridotto a un tentativo malriuscito d’icona del tempo, il corpo schiacciato e macellato dal conformismo che rifiuta i tratti marcati della diversità. Sulla tavoletta col suo sangue e i capelli c’era scritto: Via Idroscalo 93. Sul lungomare Duilio di Ostia correva contromano l’Alfa Romeo Giulietta GT 2000 del regista, al volante Pino Pelosi: guidava a folle velocità inseguendo le sue bugie, senza fermarsi mai fino a quando quella macchina sportiva non ha travolto anche lui”. Perciò ci penso. Su quel mare con gli stabilimenti balneari appaltati alla malavita. Sembra che sia tutto insopportabilmente cupo quando… quando mi sento come adesso, parlavamo d’infelicità». «Ma sarà solo il ricordo di un poeta», mi dirai e io accennerò un sorriso. «Cercheremo il ricordo di un poeta. Nei suoi versi. Nei momenti sereni che eppure deve aver avuto. Aveva un bel sorriso, segnato ma bello. Nell’acqua del mare, nel vento sulla spiaggia, deve aver incontrato qualche attimo di felicità. Cercheremo anche noi la felicità sulla sabbia appiccicata alla pelle dopo aver fatto il bagno tra le onde appena agitate. Nei luoghi da lui battuti, tra la Tuscolana e l’Appia, Cecafumo, il Mandrione, il Pigneto, la Casilina, Pietralata, Donna Olimpia, Monteverde e l’Eur dove abitò gli ultimi periodi, in questa città capace di uccidere la propria poesia senza stancarsi, senza averne mai abbastanza: è drogata di male». «Berlino Babilonia e Roma che somiglia sempre più a Weimar, con il destino di soccombere definitivamente ai nazionalsocialisti. Criminali al potere e altre vittime. E neanche i conflitti e il frenetico divertimento prima del crollo». «E noi ci sentiamo colpevoli per l’amore irrisolto e per non esserci divertiti abbastanza. Sarebbe la nostra rivoluzione, il nostro amore sarebbe la nostra rivoluzione. Il fascismo è l’assenza d’amore. “Pasolini is me”, canta Morrissey. “You have killed me”». «La polizia lo ha fermato a Via del Corso, lo vediamo dal nostro balcone. Tu hai un vestitino corto a fiorellini. La schiena scoperta. Lui dice che un poliziotto gli ha puntato la pistola in faccia, dopo aver tolto la sicura. La questura ha replicato che il cantante inglese era stato fermato perché guidava contromano e non aveva i documenti. “Ma come, sono Morrissey, non mi riconosce?” Noi non capiamo bene come siano andate le cose, ma vediamo Morrissey che litiga con l’agente. Morrissey contro la polizia, sembra il titolo di un film di serie B». «Che ridere! Lui ha abitato a Roma. Le foto al Pigneto. Qualcuno sostiene di averlo visto comprare dei vinili in un negozio di dischi da quelle parti. E tagliarsi i capelli in un barbiere vicino a Piazza del Popolo. Piazza Cavour, Visconti e Anna Magnani. “Yes, I walk around somehow. But, you have killed me”». «Abiteremo anche a Piazza Cavour, dove c’è il cinema Adriano. Andremo a vedere un film ogni week end. Un giallo e un horror». «Mi stringerò a te nei momenti di paura». «Una commedia sentimentale…» «Americana…» «Sì, americana. E un film di fantascienza». «E i cartoni animati. Ricordi quel cartone animato, “Giù per il Tubo”? Sembreremo noi quei due topolini di plastilina: io sono Roddy, il topo che vive nella sua lussuosissima casa a Kensington, facciamo che sia a Piazza Mazzini e io sia un maschio e tu Rita, la topolina fuorilegge che vagabonda per la periferia e lo porta in giro giù per il tubo in cui lui è caduto dallo scarico del water, nel pericolo fuori dalla sua tranquilla abitazione dei quartieri alti. Rideremo di gusto guardando il film e ce lo diciamo, che quelli siamo noi, e corriamo veloci sullo scafo e ci divertiamo e abbiamo voglia davvero di scappare giù per il tubo fuori da tutto poiché a volte ci rendiamo conto di non avere niente. Roddy ha una paura folle, ma Rita è una dura e lo trascina nella sua spericolata avventura per salvare la città dalle minacce del gangster cattivissimo che la vuole inondare. Riusciamo a ridere davvero perché avremmo voglia di piangere. Facendo finta di non saperne il motivo. E un musical. In quella sala ci suonarono i Beatles». «Vivremo anche nella parte opposta della città, a sud, all’Eur. Ci sembrerà di essere in un film di Antonioni. Vedremo l’alba come ne “L’Eclisse”. Saremo in una Roma metafisica. Di de Chirico». «Nel “Tito Andronico” di Shakespeare ambientato in un oggi parallelo di quel film con Anthony Hopkins, come s’intitolava? … Ah sì, “Titus”». «Staremo ore a parlare sui gradini del Palazzo della Civiltà del Lavoro, sotto le grandi statue. Cammineremo sotto i suoi portici». «Ricordi quella terrazza? Era più grande dell’appartamento. Aveva il pavimento in cotto rosso e un gazebo per la pioggia – che invece se lo portava via il vento. Il panorama da lì sembrava un quadro di Edward Hopper. C’era anche una stazione di servizio, le piante ai lati delle pompe di benzina, la macchinetta del caffè e degli snack e gli alberi in fondo». «O una foto di Richard Tuschman ispirata alla sua arte, oppure di Gregory Crewdson. Il paesaggio era desolato come alcuni luoghi della provincia americana. Eppure bellissimo. Forse perché c’eri tu. I tuoi occhi erano il paesaggio. E c’era luce oltre il buio». «Però non me lo hai detto. Il paesaggio della tua America e di Roma nei miei occhi. Vorrei fare un viaggio con te su una Dodge Challenger R/T bianca del 1970, come nel film “Punto Zero”. Da Denver a San Francisco. Fermarci nei motel da pochi dollari. Le finestre aperte e fuori non c’è niente e le lenzuola bagnate per il caldo. La Coca Cola fredda del frigobar. Mischiarla al whisky. Anzi, su una motocicletta: nuda come la ragazza che il protagonista in fuga incontra nel deserto del Nevada al confine con la California». «Ti fotograferei come farebbe Stephan Würth su quella strada desolata». «Solo con il fucile e gli stivali da cowgirl, come una modella del suo libro “Ghost Town”. In bianco e nero. La macchina in panne sul ciglio della strada. Senza un’anima viva nel raggio di miglia e il sole sulla pelle nuda. Sentire il paesaggio sulla pelle. Sul seno, sul sedere, sul pube, sulle cosce. Accoglierlo. Farne parte. Vidi “Punto Zero” in televisione da bambina e da allora quella motociclista nuda per me rappresenta la libertà e qualcos’altro che non sono mai riuscita a definire. Così le fotografie di Würth. Lo stesso senso di libertà e di minaccia. Alla fine Barry Newman, crash! Boom! Boom! A tutta velocità, con un sorriso sulle labbra e negli occhi, dritto sul posto di blocco della polizia. Sulla barriera dei Bulldozer. Sam Shepard. Su una Buick degli anni cinquanta da Los Angeles a Phoenix. Fermarsi nella Valle della Morte. Era “Zabriskie Point” di Michelangelo Antonioni. Il protagonista del film muore colpito dai proiettili degli agenti appena atterrato sulla pista con il piccolo aereo rubato. Sembra che per la libertà si debba pagare un pegno. Per questo le modelle di “Ghost Town” sono armate». «Mark Frechette, così si chiamava l’attore del film di Antonioni, morirà davvero, forse suicida, forse ucciso, neanche cinque anni dopo nel carcere di Norfolk dove stava scontando una condanna per rapina a mano armata a una banca di Fort Hill. Uno dei suoi due complici era morto nel conflitto a fuoco con la polizia. La pistola di Mark Frechette era scarica». «Non lo sapevo. Lei, Daria Halprin, sposerà Dennis Hopper, da cui divorzierà quattro anni dopo. “Easy Rider”. Dalla California alla Louisiana e poi verso la Florida. Wyatt e Billy, Peter Fonda e Dennis Hopper (con lo stesso cognome del pittore) sulle loro motociclette. Un furgone affianca Billy, dal finestrino un tale gli punta il fucile e bang! Prosegue. Torna indietro e ancora un colpo che centra anche Wyatt. I due interpreti di “Zabriskie Point” nella pellicola avevano i loro veri nomi. Realtà. Finzione. Viaggi sempre interrotti. Anche la tua America uccide. A un reading raccontasti della Dalia Nera. “Uno squarcio tagliava in due il suo volto: da un orecchio all’altro. Una lacerazione da circo degli orrori, come una versione femminile del Gwynplaine di Victor Hugo con la faccia di Conrad Veidt nel film muto di Paul Leni: la faccia era dell’orrenda bellezza della morte. In quella grottesca risata, l’ultimo viso di Elizabeth Short. Betty Short. Liz Short. La chiamavano la Dalia Nera perché tutto era nero in quella giovane donna: i capelli, gli abiti, il pelo pubico e il cuore. Tagliato in due anche il suo corpo: all’altezza dei fianchi. La metà inferiore mostrava oscenamente la vagina spalancata – privata degli organi interni – con le labbra riverse verso l’esterno (allo stesso modo quelle della bocca). Meglio di una pellicola pornografica. Asportate anche le interiora della parte superiore, con i seni bruciacchiati dalle sigarette e mezzi staccati. Una bambola afflosciata con le gambe rotte, svuotata, solo un involucro mutilato come da un bambino che abbia seviziato il suo giocattolo. Non c’era però traccia di sangue sui suoi capelli. Puliti come il resto del corpo, come appena lavati. Sul South Norton Avenue, tra Coliseum Street e la Trentanovesima Ovest. La trovarono lì. Il 15 gennaio del 1947”. Dwight Holly tirò fuori dal mazzo dei Tarocchi firmati Gelso Nero la carta XIII della Morte, che ritraeva un uomo e una donna in abito da sera impegnati in un ballo figurato sotto una grande falce, una gigantesca mano usciva dal suolo, e la gettò al pubblico. Vedi, mi ricordo tutto. Pare fossero coinvolti nell’omicidio pure Walt Disney e Orson Welles. Topolino è uno psicopatico. Charles Foster Kane un maniaco. Era un fatto reale e un film di Brian De Palma. Elizabeth Short era interpretata da Mia Kirshner, l’ultima donna di Sam Shepard. L’amore della malattia e della morte. La pellicola era tratta dal romanzo di James Ellroy, il primo della tetralogia di Los Angeles. Ho quel libro autografato da lui. Ellroy è Los Angeles. E comunque i denti a Chet Baker glieli spaccarono a San Francisco, mica a Roma. Nei tuoi reading narravi sempre storie di crimini e follia, di eroi sconfitti, di emarginati oltre la legge. Raccontami una storia: solo per me, pensavo quando finivi di esibirti. Solo per me. Ma tu non lo facevi mai. Te ne tornavi a casa insoddisfatto e imbronciato. Come i tuoi personaggi. Solo per me, che ti ci vuole?» «Erano per te. Non te ne accorgevi, ma erano per te». «Non è vero. Però anch’io sono brava a raccontarle, non trovi?». «Sei bravissima». «Non è vero. Ma me le ricordo tutte. Perché io ero attenta, sai? E poi quelle storie erano meglio di niente. Dai, raccontami una storia, solo per me». «“Berlino sei tu, mi disse una volta Lou Reed”. Lo disse alla cantante tedesca Nico. Lui era New York. La sporca New York. Coney Island baby. Lei recitò ne “La Dolce Vita” di Fellini». «“Marcellino, bruttino, cattivo… ci porti queste due creature infelici?” Via Veneto». «Nella stanza 541 dell’hotel Excelsior, Courtney Love si strinse al seno i fiori di Kurt Cobain ma non il suo uomo. La mattina dopo lo trovò sul pavimento ai piedi del letto in coma da overdose di champagne, Roipnol, antidolorifici e farmaci per la gola. La prima volta Kurt e Courtney si mischiarono i loro geni facendo a botte. Poi facendo l’amore. Poi scambiandosi l’ago. Nella camera 541 lui voleva scopare. Lei aveva preso il Valium». «E tu vuoi bere dal mio bicchiere, dove vi ho poggiato le labbra? E tu vuoi dirmi che Roma sono io e non vorresti vivere altrove perché Roma sono io? Anche se gli amanti si uccidono in una stanza d’albergo o in un appartamento? Passeggeremo in silenzio come Christa Päffgen e Philippe Garrel, come Clotilde Hesme e Louis Garrel, les amants réguliers, fino a sentire l’arrivo della malinconia e la eviteremo con un’alta acrobazia: un sorriso tenendoci la mano. Roma come Parigi a primavera o in autunno, lì ci sono ancora la primavera e l’autunno – almeno nei film di Philippe Garrel. Raccontami una storia. Ma non una storia di delitti e di sfacelo, non nasconderti più dietro quelle storie ai limiti. Una storia che parli di noi. Di noi due. Io e te in un appartamento. Un uomo e una donna, normali. Inventati un ricordo di noi due. Meglio di niente, no? “Non facevamo che fare avanti e indietro tra Parigi e Deauville”. Un uomo, una donna. Un ricordo di domani». «In una Roma romantica e musicale. Ascolteremo un disco degli Spiritual Front, tu danzerai e io starò lì a guardarti, mi chiederai di ballare con te e balleremo in casa e poi continueremo in strada. Tu con la maglietta di “Open Wounds”, quella con i due amanti che si baciano puntandosi i coltelli alla schiena. E una gonna corta. O i calzoncini. Ti toglierai le scarpe. Noi due non saremo armati». «“Rotten Roma Casinò”: nella Roma degli Spiritual Front, il gatto di C. C. Askew piange immalinconito davanti a San Pietro. Il sole tramonta dietro la cupola della basilica e il gatto cerca consolazione nel fumo di una sigaretta e suonando una dolente ballata alla fisarmonica. Qui nessun gatto piange per noi e per la nostra sorte, in questa sfinita città da omicidio e dai romanticismi impronunciabili. La Roma noir jazz dei Macelleria Mobile di Mezzanotte dove gli uomini e le donne sono colpevoli e sconfitti dal troppo romanticismo di cui non ricordano quasi più da dove veniva. Quella affascinante, profonda di corpi e pioggia di Calm’n’Chaos. Buia e romantica delle Winter Severity Index. Marziale e sacra degli Ivashkevich. Se ci penso, non trovo momenti di noi due che non siano legati alla musica. Erano tuoi amici, non ci collaboravi solo, erano tuoi amici. Qualcuno lo è ancora o tutto finisce? È così difficile che le cose continuino qui, è così facile perdersi. Il nostro amico regista però c’è sempre. Non lo vediamo mai, ma c’è sempre. Ha una figlia, con la sua fidanzata. Sono bellissimi insieme. “Com’è la vita ora, con una bambina?” gli ho chiesto una sera. “Più complicata…” mi ha risposto e poi ha aggiunto: “No, più bella”. Ci faceva recitare nei suoi film. Ma non ci ha mai fatto recitare insieme. Chissà perché?». «Ricordo quella notte dell’ultimo dell’anno. Proprio quella fra tante. Faceva freddissimo. Il buio era freddo. Gelido. Il Circo Massimo sembrava un prato abbandonato al suo lento declino millenario. L’unica luce calda veniva dalla scena, dove lui era a fare le riprese. L’unico suono caldo era la musica degli Spiritual Front. Il resto era un vociare indistinto e freddo. Freddo e stridente. Ricordo le bottiglie di spumante vendute clandestinamente. Le misere animazioni tornando a casa, clown sui trampoli, mimi e orchestrine, le strade del centro illuminate come un set cinematografico, le luci però non erano mai sufficienti a rischiarare tutto per bene, ogni cosa sembrava sbiadita. Anche la gente che si muoveva in gruppo e rideva e beveva da quelle bottiglie era sbiadita. Mi feci seguire dalla musica che ormai era finita per illudermi che non fossi stato solo quella notte. Solo lui scese dal palco a farmi gli auguri per il nuovo anno. Non ricordo che anno fosse». «Non c’eri al loro concerto sull’Appia Nuova. Quella sera faceva caldo. Quando cominciarono a suonare gli Einstürzende Neubauten capii che non saresti più venuto. Vidi una locandina di una mostra di Egon Schiele. Il manifesto degli Spiritual Front e la locandina di Egon Schiele. Il manifesto era di carta, la locandina era digitale». «Tornare a casa dai concerti ognuno per conto proprio. Non facciamolo più. C’è troppa tristezza nel ritorno da nessuno. Abbiamo quattro case per ogni momento della giornata, no? Tante case per ogni mese e ogni notte. Andremo a un concerto di Nick Cave and the Bad Seeds e poi dove passeremo la notte?» «Che ne dici al Pantheon?» «Perché no? Un attico. Una camera che affaccia sui tetti. Non abbiamo mai dormito insieme. Non abbiamo mai fatto colazione insieme». «La mattina deve essere bella a Via Margutta. Andremo a fare colazione da Rosati, dove si riunivano i pittori della Scuola di Piazza del Popolo: Mario Schifano, Giosetta Fioroni, Franco Angeli, Tano Festa e i loro amici. Se avessimo i soldi collezioneremmo quadri. Solo qualcuno alle pareti. Pieni di arte e droga. Erano pieni di idee innovative e droghe. Mario Schifano e Anita Pallenberg: si amavano. Poi lui la presentò ai Rolling Stones, così si dice, e lei andò con Brian Jones, che la riempiva di botte, allora passò a Keith Richards, che la riempiva di tenerezze. Schifano si consolò per un po’ con Marianne Faithfull. Che belle che erano Anita Pallenberg e Marianne Faithfull!». «Tu sei più bella». «Sì, certo». «Giuro. Però resteremo a casa. La finestra della cucina che dà sul cortile di un vecchio palazzo». «Una delle dimore delle tre Madri progettate dall’architetto alchimista Emilio Varelli. Sentiremo i segreti dei suoi inquilini attraverso le pareti e i tubi dell’acqua. Cose banali. Rivelazioni indicibili. Ti capita mai di guardare nelle finestre di qualche appartamento e immaginare chi ci abiti? Non penso mai a una famiglia: moglie, marito e figli. Sempre a persone sole. Si preparano da bere, lo sorseggiano davanti alla televisione o al computer, mangiano qualcosa, leggono un libro, si masturbano. O a coppie. Ma non parlano mai. Perché conoscono il loro amore e non temono che il silenzio li divida. Si guardano, dirigono lo sguardo fuori dalla finestra, e quando mi vedono io indietreggio e mi nascondo in un angolo in ombra della stanza. Sono per strada, quando scruto nelle finestre, eppure mi sembra di stare in un’abitazione, così arretro. Nessuno si è affacciato. Stanno facendo l’amore. Si poggiano l’uno sull’altra. Immagino lui sul pavimento tra le cosce di lei seduta sul letto. La testa poggiata sul suo pube. Lei gli accarezza i capelli. Poi lei si lascia andare giù sul letto». «Qualcuno immaginerà noi. Da uno di quegli interni ci inventeremo la nostra Roma». «La nostra storia. Vorrei non fosse inventata. Come Egon Schiele e Wally Neuzil faremo del nostro appartamento un atelier. Ho visto un film sulla loro storia al Forum Austriaco di Cultura. Sulla salita di Viale Bruno Buozzi. Vicino alla Galleria di Arte Moderna, dove è esposto anche un quadro di Gustav Klimt. A due passi dall’Istituto Austriaco c’è l’Auditorium Parco della Musica. Mi piace l’Auditorium. Ci vidi uno spettacolo di danza. Parlava di baci. Baciami questa notte, prima che sia troppo tardi e che il giorno arrivi ad allontanarci con la sua luce, prima che quel lampione si spenga. Baciami questa notte, perché il suo buio e le sue ombre ci proteggano e ci avvicinino. Baciami in questa notte perché anche nella notte è difficile baciarsi, pure se vogliamo che sia la più buona delle notti, quella da aspettare al riparo della luce di una lampada vicino a un divano, luce soffusa e delicata, come qui in fondo non c’è mai stata, per questo abbiamo bisogno di un’altra casa, luce che riverbera sul tavolo due cocktail; bevande per addolcire la bocca e inebriare un po’ la testa come aperitivo al bacio desiderato, da non lasciarsi sfuggire nella notte da attendere con le sue promesse della notte più giusta. Ma c’è mai una notte giusta oppure essa è solo l’illusione di un incontro di due bocche? O peggio, la notte è un buio inganno e l’abat-jour serve solamente a mistificare per farci credere che l’incontro sia possibile? Non mi ricordo il nome della compagnia, ricordo i volti e i corpi dei danzatori e i loro baci. Ci saranno notti di baci per noi? Lo spettacolo diceva che certe notti finiscono. E io che parlo di queste notti. Un uomo e una donna si confidano, si sfiorano, si toccano, si spogliano rivelando le proprie seduzioni per poi portare una carezza a una spinta, un abbraccio a un intrappolamento brusco e una parola a un urlo, un sussurro affettuoso a un insulto ad alta voce, con la luce della lampada adesso a svelare la difficoltà di una relazione con la sua componente di sopraffazione che appare ancora più tremenda in un’illuminazione che da soffusa è diventa dura e tagliente. Allora di cosa parliamo? Vogliamo anche noi fare questa fine? Perché è chiaro che neanche la notte più giusta può realizzare l’incontro, non l’ha ancora fatto. Una notte di rapporti desiderati e poi spezzati prima del tempo, prima del bacio. Notte che non è seguita a un pomeriggio di corpi nudi, il tuo sesso eretto, il mio bagnato di una carezza distrutta, nessun bacio, nessuna notte di baci. Kiss me goodnight. No dai, è che ho queste cadute di umore. Scusami. Ti prego, perdonami. Ricordi l’abat-jour che rischiarava languida il mio corpo? Il seno era nudo, un paio di mutandine bianche. Erano a calzoncini». «Fu in quel tuo spettacolo di danza che pensai per la prima volta a una casa tutta per noi: ti alzi di notte e accendi la lampada, il tuo corpo è nudo. La mattina. Quello spettacolo si riproporrà ogni volta che sposti il lenzuolo. Il tuo corpo. Il tuo odore del sonno e del risveglio». «La colazione al bar dell’Auditorium. Sapore di cappuccini e baci mattutini. Da quelle parti, sì mi sembra non fosse lontano da lì, vidi in un piccolo teatro “4:48 Psychosis” di Sarah Kane. L’attrice che interpretava quella pièce si chiamava Elena Arvigo, indossava una sottoveste rossa e i suoi piedi scalzi calpestavano frammenti di specchio. Specchiarsi nella depressione che prenderà per mano Sarah Kane e le stringerà i lacci degli anfibi intorno al collo dopo averle riempito la bocca di psicofarmaci, al King’s College Hospital, e annullarsi nei riflessi di quel disperato struggente ripetuto inascoltato “Mi piaci, mi piaci, mi piaci!”. Magari è stato anche ascoltato, qualche volta, ma per poco tempo, troppo poco tempo, e mai sentito, intendo sentito sulla pelle, negli occhi che si lucidano. “Mi piaci” è più forte di “ti amo”. Tu mi dirai “mi piaci” e ascolterai il mio “mi piaci”. Lo sentirai. “Mi piaci”. Un pomeriggio in una casa al Flaminio. In primavera o d’estate. No, la primavera non esiste, abbiamo detto: d’estate. Sarà più piacevole stare senza abiti. La finestra aperta per far entrare una corrente d’aria. Sullo stereo un disco dei Cigarettes After Sex: “Baby, he’s got to be crazy. Living like he’s John Wayne. Always facing the world and chasing the girl. Baby, he’s got to be crazy. He’s got so much in his heart. But he doesn’t know what to do. All he wants is her. Lying inside his room”, ti canterò. “Mi piaci”. Sarò la tua modella e tu il mio pittore. “Mi piaci”. Ma noi non ci lasceremo come Wally e Egon. Se una persona ti piace non l’abbandoni, così, come niente. Lui la lasciò per sposarsi con un’altra. Un tranquillo matrimonio borghese». «Saremo belli e dannati. Wally e Egon». «Io e te… Ma per lasciarsi bisogna prima essere stati insieme. Noi non siamo mai stati insieme. È vero, non abbiamo mai fatto colazione insieme. Non ci siamo mai addormentati insieme. Non ci siamo mai baciati. Mai un vero abbraccio. Forse una volta sì. Ma ce ne siamo accorti quando ormai era tardi. Possiamo però sempre fantasticare di una casa a Piazza di Spagna dal prezzo inarrivabile, vicino a quella del poeta romantico John Keats. In una delle strade lì vicino visse per alcuni anni la scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann, a Via Bocca di Leone. Poi si trasferì a Via Giulia, dove morì per il rogo causato da una sigaretta mentre si era addormentata in seguito a una forte ingestione di barbiturici. “Vienimi a trovare”, diceva ai pochi amici. “Mi venga a trovare”, a qualche conoscente. Era molto sola. Noi non saremo mai soli. Abiteremo a Cinecittà, nella zona delle ville di fronte al Parco degli Acquedotti, faremo finta di essere due divi del cinema, sempre invitati alle feste dei produttori sull’Appia Antica. Anche se oggi a Cinecittà non si fa più il cinema. E sull’Appia Antica non si fanno più feste. Oppure a San Giovanni. Pieno di gente, ma non come quella del sabato pomeriggio a Via del Corso. Ricordi il primo appuntamento alla Coin?» «Mi sono sempre piaciuti i grandi magazzini. A Parigi passo più tempo alla Galerie Lafayette che altrove. A Boulevard Haussmann ti comprai un bikini stile Costa Azzurra anni Sessanta. Era bianco a righine rosa. Non te l’ho mai visto addosso. Ricordo i movimenti delle tue mani coperte dai guanti di lana. Fuori dalla Coin, prima di salutarci. Era inverno. Nella terrazza dell’Eur era estate». «Ora il bar all’ultimo piano dove abbiamo preso il tè non c’è più. E non c’è mai stato il nostro primo appuntamento. Non ci siamo mai parlati davvero: parlarsi vuol dire parlare di noi due, di noi due insieme. Non raccontarci storie, ma parlare. E non ci siamo più neanche noi, ormai. Ormai, ormai, ormai, non vorrei più usare questa parola. Ormai che… A volte penso di incontrarti. Così, per caso: svolto l’angolo di una via e ci sei tu. Oppure stai attraversando la strada, sei sull’altro marciapiede. Agitiamo le mani per farci notare. Ieri, al supermercato, avrei voluto vederti al reparto dei dolci. Avremmo comprato gli stessi biscotti, quelli secchi secchi. Ne avremmo mangiato uno prima di andare alla cassa. È quando vado nei luoghi in cui non siamo mai stati insieme che ti penso di più. Penso a quel pomeriggio in cui mi parlasti delle difficoltà economiche alle quali ti costringe l’arte. Eravamo usciti dalla Feltrinelli della Galleria Alberto Sordi dopo la presentazione del libro di una nostra amica e camminavamo verso le vie interne oltre Piazza San Silvestro e tu mi raccontasti di quanto fosse difficile andare avanti scrivendo, in una città ingrata che ti frega sempre, eri così disperato, in alcuni momenti arrabbiato. Ma era qualcos’altro a colpirmi. Non capivo bene perché mi facessi quel discorso, a volte confuso, sempre pieno di sfiducia. Lo capii solo molto tempo dopo, capii che mi riguardava… Ma tu che ne sapevi di quello che volevo io? Me lo hai mai chiesto? Mi hai tolto la possibilità di fare una vita di miseria e di difficoltà con te. Mi hai negato la speranza che un giorno insieme ce l’avremmo fatta. Mi hai impedito di sognare in una piccola casa fredda d’inverno aspettando l’estate come un regalo. L’affitto pagato per un altro mese come una conquista. La bohème di due poveri amanti felici. Mi hai tolto gli stenti che in due possono essere romantici – o almeno sopportabili. La gioia di mangiare ogni tanto qualcosa di buonissimo. Quell’abitino tanto desiderato e poi comprato perché per una volta ci avevano pagato decentemente. Mi hai precluso le lacrime di disperazione perché niente va bene. I sorrisi perché qualcuno cominciava a farci firmare bei contratti per le nostre cose. A darci i teatri, quelli con le poltrone di velluto e i palchetti. Io la tua attrice. Tu il mio drammaturgo. Le notti svegli, tu a scrivere, “vieni a letto, sono le quattro”, ti avrei detto, scarmigliata e assonnata, “dai, fammi sentire come viene dalla tua voce”, mi avresti chiesto tu, incurante del sonno e dell’alba che presto sarebbe arrivata, e io avrei recitato quella scena appena composta, e in nessun teatro l’avrei più fatta bene come quella mattina. Hai mai visto i bambini a teatro giocare tra le poltrone mentre i genitori provano? Sono fantastici e felici, lo sai? Saremmo stati unici, come lo sono tutte le coppie innamorate. Saremmo stati bravi. Avremmo ricordato i tempi difficili con dolcezza. E non avremmo avuto più paura che tornassero. Sapevamo che potevamo sopravvivere. Avremmo abitato almeno una di quelle case. Ce ne sarebbe bastata una. Calda d’inverno. D’estate avremmo preso il sole in terrazza, il vento di Roma la sera ci avrebbe rinfrescato, Roma è famosa per il suo vento che viene da ponente. Un vento che non soffia via lontano, ma avvicina. Ma magari non è accaduto niente tra noi perché ce ne stavamo al riparo ognuno nella propria relazione fallimentare. Nei conflitti che alla fine la tenevano in piedi, fino al crollo. Non puoi fare niente contro la sofferenza di chi non ti ama. Puoi solo aggiungere dolore al dolore. In ogni caso non ne valeva la pena. Perché non ne abbiamo parlato? Perché? O perché immaginavamo chissà che storia avesse l’altro. Un’altra lei. Un altro lui. E probabilmente non c’era nessuno. Era solo un fraintendimento e voci che chiacchieravano a sproposito. Forse finì tutto una sera ancora prima di cominciare, in un museo all’aperto, la gente intorno, la confusione e gli spritz e noi che non capivamo. Era estate. Mi lasciasti sola. Ma anche tu eri solo. Eri più solo di me, ma allora… No, è che tu eri affezionato alla tua solitudine, alla tua dannazione, alla tua infelicità, facevano di te uno scrittore, facevano di te un eroe, uno stupido, povero piccolo scrittore senza parole, ma sì, ormai a che serve, ormai, ormai: ormai è tardi. O, più semplicemente, abbiamo avuto solo paura. Di che poi, non lo abbiamo mai capito. Questa città ti spaventa e ti confonde. Ti fa vedere ciò che non c’è. È una città di fantasmi. E i fantasmi non esistono. Ieri al supermercato non ce l’ho fatta a trattenere le lacrime. Ho pianto comprando biscotti secchi, latte della centrale e Ovomaltine. È proprio quando vado nei posti dove non siamo mai stati insieme che ti penso di più. Con rabbia e nostalgia. Con amore. Forse perché lì avremmo potuto essere chiunque. E finalmente noi due. Io e te. In questa maledetta città che uccide ogni amore. È stata edificata intorno a delle rovine, no? Sì, ti fa credere che oltre quei ruderi non ci sia niente che possa resistere a lungo. Sere fa ho visto un concerto di una band che si chiamava Roma Amor, li conosci di certo, una volta hanno anche suonato con gli Spiritual Front. Era in un locale di Centocelle. C’era una canzone intitolata “A Cosa Pensi?” La cantante era bella. Aveva un fiore tra i capelli. Fiori anche sul piccolo palco e lucette. “A quello che tu sai di mio o da quello che credi, a quello che io so di te anche se non mi vedi”, cantava Alessandra Euski, è il suo nome; seduta su uno sgabello, le gambe accavallate, suonava la chitarra, era così intensa e fragile, melanconica. “A chi uscirà sconfitto dal suo tiro alla fune”. Già. Ti feci una carezza a un concerto degli Spiritual Front, ti passai vicino e ti sfiorai il viso con la mano, ricordi? Io ricordo quel concerto lì. Non uno freddo nel buio. Non uno con la tua assenza. Quello. Mi allontanai subito, sperando che tu mi cercassi tra il pubblico per restituirmi quella carezza, o un bacio. Ma tu non ti spostati da là. Ogni volta che vado a un concerto ci penso. Questa città rende timidi. Se solo ci fossimo parlati. È proprio così, non ci siamo mai parlati. Questa è la prima volta, e tu non ci sei. Non ci siamo mai parlati, questo ci ha rovinato. Il gatto degli Spiritual Front posò la fisarmonica e fumò le ultime boccate della sua sigaretta. Si asciugò gli occhi. Anche il fisarmonicista dei Roma Amor – lui si chiama Michele Candela –, alla fine della canzone, ha poggiato lo strumento sulla sedia e si è tolto il berretto. “A cosa pensi? A me ogni tanto? Io non comprendo, ma in compenso canto”. Si chiamavano davvero Roma Amor. Io ero lì da sola. E ti ho pensato». [1] Pubblicato su “Verde” del 18 dicembre 2017.
 Ilaria Turini, AmoR
Ilaria Turini, AmoR
amoRè un atto unico diSergio Gilles Lacavalla che debutterà a maggio in teatro, a Roma, vista l’ambientazione. È una storia nostalgica di una lei e un lui in una città. Nota dell’autore: “È il racconto di sentimenti che sono aspettative deluse e desideri, che sono luoghi. Può essere rappresentato sia in forma di monologo di lei sia di dialogo tra lei e lui che si trasforma nel monologo di lei. Qui è nella forma monologo che indica ben chiaro l’eventuale svolgimento come dialogo. Parole per corpi che non si sono mai incontrati, se non in una carezza, in un abbraccio non compreso, in notti infinite di parole e musica, in sguardi. Con Le Soldat Perdu, il nome della mia nuova compagnia teatrale, sto affrontando il tema del rimpianto e della perdita – forse l’ho creata per parlare di ciò. In Jeanne e Gilles
View original post 10.384 altre parole
Ascenseur pour l’échafaud # 2: Yukio Mishima[1]
Sono urla di scherno. Qualcuno osserva in silenzio. L’espressione addolorata. Altri sono interdetti e non capiscono bene cosa stia avvenendo. Ma i più lo deridono e urlano insulti. Mishima sta facendo il suo proclama e loro lo deridono. Non si capisce niente. Non afferrano quello che dice. Il rumore delle eliche e del motore degli elicotteri della polizia è un frastuono che cancella tutto, si sovrappone a tutto. Ci sono anche gli elicotteri della televisione nazionale e dei fotografi dei più importanti quotidiani del Giappone che riprendono la scena cercando l’angolazione migliore. Le urla dei soldati sono spezzate dalle eliche dei velivoli che sorvolano la base militare di Ichigaya. Guardano su, sul balcone della stanza 201, lo scrittore con i lineamenti distorti per lo sforzo di farsi sentire, lo scrittore che urla con la sua elegantissima divisa della Tatenokai, la Società degli Scudi, lo hachimaki con al centro lo Hinomaru, il simbolo del Sol Levante e gli ideogrammi che riportano il motto di guerra dei samurai e dei kamikaze “Sette vite per il mio Paese!”, è stretto sulla fronte, le vene della testa e sul collo stanno per scoppiare, le mani sono sui fianchi come nell’atteggiamento di un Duce estremorientale, poi in avanti, stringe un pugno guantato di bianco in un movimento da Führer del Pacifico, si agita come un Artaud marziale che mette in scena il suo teatro della crudeltà, quindi porta una mano intorno alla bocca a fare da megafono, lui urla e loro gli gridano contro che è un buffone, un delinquente, un cretino, un eroe fasullo – più falso dei personaggi dei suoi romanzi, che nessuno di loro ha letto. Sembra che quelle parole dicano questo. Il rumore è proprio assordante per comprenderle bene (solo i microfoni della tv a terra riescono a coglierle tutte e con chiarezza e a trasmettere nei televisori di milioni di giapponesi attoniti il discorso dello scrittore e le offese dei suoi detrattori). Ma Mishima pare capirle. Alcune riesce a udirle. Risponde. «Non avete dignità! Fatemi parlare!». Le ingiurie sul grande spiazzale dell’alzabandiera si intuiscono da quei pezzi di parole che si salvano dal frastuono, agli elicotteri si sono aggiunte le macchine della polizia che arrivano sul campo di manovra con le ambulanze a sirene spiegate e le automobili di altri cronisti e fotoreporter, i corrispondenti delle testate estere, il loro vociare, chiedono spiegazioni, raccolgono notizie, i click ripetuti delle Nikon, e dalle espressioni beffarde degli uomini del 32esimo Reggimento di Fanteria schierati senza nessun ordine. Le uniformi sono dimesse: un esercito disarmato che grida la propria impotenza a un uomo che vorrebbe ridare loro e a tutto il Giappone la dignità. Basterebbe un po’ di silenzio per farsi ascoltare. Forse, senza tutto quel chiasso, avrebbero capito. Avrebbero compreso le ragioni di quel proclama urlato al vento artificiale degli elicotteri insieme alle richieste di starlo a sentire, di cercare di sentirlo, di provare a seguire quello che diceva, invece di offendere. «Vieni giù, pagliaccio!». E sarebbero insorti in un mattino traboccante di gloria.
Il silenzio di una corsa mattutina nella neve che amplifica ogni respiro di gioiosa fatica, quando ogni parola reca in sé il valore dell’esistere e dell’erotismo, una corsa in solitario su una pista di atletica umida di rugiada o seguito dai suoi uomini nei campi di esercitazione avvolti dalla nebbia nelle pianure del Fuji, sotto il cielo terso e stordente, i giovani studenti universitari dai venti ai venticinque anni componenti la Tatenokai, la sua milizia personale, il ritmo degli anfibi dietro di lui, un canto militare nel silenzio; il silenzio, solo un po’ di silenzio per farsi udire. Ma il frastuono era già iniziato quando avevano messo in moto il loro piano. I mobili contro la porta per creare una barricata. Il vetro della porta frantumato. I mobili spostati. Il tentativo di irruzione. I tafferugli a colpi di spada e bastone con gli ufficiali intervenuti dagli uffici vicini. Nessuno dei militari rimane ferito gravemente. Ma il sangue è già sulle lame. Ancora mobili contro la porta. Dal vetro rotto alcuni teleoperatori riprendono gli eventi. Le urla e le minacce. «Lo uccidiamo, se non ve ne andate e non date esecuzione alle nostre richieste», aveva gridato Mishina opponendosi all’ultimo tentativo dei militari di porre fine a quell’assurdo colpo di mano. La richiesta di adunata dei mille uomini della caserma. Avrebbero dovuto ascoltare in silenzio. Il silenzio, adesso vorrebbe solo quel silenzio. Lo assale una nostalgia indicibile. Tutto appare ormai indicibile. Tradito dalle parole, non gli resta che l’azione. Ma anche quell’azione sta per essere tradita dalle urla. Il silenzio. Soltanto un po’ di silenzio. Come quello di un dōjō, dove le sole urla provengono da dietro la griglia metallica di un casco di protezione per un’azione d’attacco di kendō. Di difesa. Urla di rispetto e forza. Di lealtà. I soli rumori sono quelli dei colpi degli shinai e del frusciare dei corpi. I silenzi dei corpi. I sospiri di piacere e attesa nel silenzio di due amanti. Con Morita, il suo giovane luogotenente, c’era questo silenzio, che dava a ogni sua parola la necessità di un gesto d’amore. Virile e delicato. Anche nei giochi rudi. Anche nel farsi male. Puro come la neve. Perverso e senza colpe. Due uomini nudi che si sussurrano frasi d’amore e di onore, di amore e morte, perché l’Assoluto si raggiunge solo nella morte. Una morte precoce e violenta. Nella quiete di un pomeriggio con il sole che filtra languido dalle serrande di un interno su due corpi fieri delle proprie forme, Morita, tarchiato e dai tratti del volto volgari e infantili come un ragazzo di vita pasoliniano di buona famiglia che ha studiato, ma con una sua ottusa e ingenua bellezza, sfiorava le spalle e i pettorali del suo maestro, separati dall’assenza di grasso e da una sottile striscia di peli neri, muscoli scolpiti dal sole di un campo di addestramento e dall’acciaio dei bilancieri e dei manubri sollevati in una palestra per soli uomini di Tōkyō, quegli uomini dai muscoli sviluppati ritratti in pose omoerotiche da Tamotsu Yatō nel libro “Giovane Samurai – Bodybuilders del Giappone”, in cui lo scrittore appariva in due scatti coperto solo del fundoshi, impugnava una katana, nelle fotografie surrealiste di Eikō Hosoe posa nudo adagiato con il viso e il petto, una spalla, un braccio, sul seno e la pancia di una donna con le calze bianche, lei sembra incinta, poi è un uomo a essere poggiato su di lui, anch’egli nudo e quasi nella stessa posizione del romanziere con la donna, sono circondati da fiori e foglie, poco più in là si intravedono le cosce e il pube ancora di una donna, Mishima guarda in macchina, il suo sguardo magnetico è protagonista di un primo piano con una rosa bianca davanti alla bocca, il servizio sarà per l’album fotografico “Calvario di Rose”, poi con Mishima c’è il grafico Tadanori Yokoo, sono fotografati da Kishin Shinoyama, Yokoo porta la vecchia divisa della scuola, Mishima è nudo, a parte il solito fundoshi bianco e una fascia dello stesso colore sulla fronte, hanno lo sguardo sprezzante, Mishima è armato di katana, in un’altra foto tiene con il braccio il collo dell’artista pop, come se la sua affilata arma gli avesse staccato la testa, fa da fondale la Nisshōki, la bandiera nazionale con il disco del sole, Shinoyama ritrae Mishima anche nella posa del San Sebastiano trafitto dalle frecce nell’immagine che divenne un’icona, il santo dipinto da Guido Reni riprodotto sulla pagina patinata di un volume di storia dell’arte custodito nella biblioteca di suo padre gli fece scoprire la masturbazione e la prima lattea eiaculazione, in “un’ebbrezza accecante”, l’espressione estatica rivolta al cielo del martirio dello scrittore fattosi santo masochista, poi andava giù sugli addominali disegnati dall’allenamento, Morita carezzava quella pancia solida come la corazza del kendō, anche qui una leggera peluria che dall’ombelico arrivava ai peli pubici, cosa rara per un giapponese, gli piaceva quella singolarità, carezze su un addome durissimo quanto il suo membro eretto: i sessi dei due uomini si toccano, anche quello di Morita è turgido, Morita afferra con decisione il pene di Mishima, si abbassa, se lo porta alla bocca. Sa che la mattina del 25 novembre quel sesso si indurirà per l’ultima volta. Il sapore dello sperma sulla sua lingua sarà l’ultimo ricordo, “il sapore della gloria è amaro”, prima che il membro di Mishima si ricopra di sangue, il sangue impregna il tessuto candido del fundoshi scoperto dai pantaloni sbottonati e calati alle ginocchia della divisa marrone dai riflessi giallo-bruni (lo stilista Tsukumo Igarashi aveva realizzato quell’uniforme, con i polsini, il colletto e le mostrine verdi, su indicazioni di Mishima che ne aveva disegnato l’emblema cucito sui berretti e impresso sui bottoni, un elmo da samurai con in basso una ruota e sopra una spada a più lame, Mishima che aveva disegnato quell’azione suicida), il liquido passa sotto, scorre come acqua limpida di una fontana in un parco d’autunno sul sesso rigido, sangue scuro e poi viscere vomitate dal ventre squarciato, gli sfinteri anali, riempiti di cotone, cederanno ma il sesso continuerà ad avere un ultimo sussulto di amore e fierezza, un’ultima erezione inconsapevole per il suo amante che porrà fine a quel breve e infinito momento tagliandogli la testa. Nel silenzio di una stanza queste sono immagini tremende e sublimi. Mishima gliele illustra. Morita succhia. L’erotismo è penetrato da una sola lettera: c’è una consonante che si incunea, come il membro del suo maestro nel suo ano, nel sostantivo eroismo. I due uomini sono due eroi nel chiuso di una stanza verso il tramonto del loro erotismo e dell’erotismo dell’intero Giappone. Dell’eroismo di una nazione rappresentata da due amanti smarriti. Senza domani. Quando il sole dopo mezzogiorno entrerà nell’ufficio del comandante della caserma del Quartier Generale delle Forze di Autodifesa, i due uomini saranno due martiri. Martire come testimone: colui che documenta il declino di un’epoca e la sua insopprimibile voglia di resurrezione. Per l’Imperatore e per il Giappone ormai perduto. Per il loro amore impossibile. Lo sguardo di Morita sarà lo stesso di Reiko, la devota moglie del tenente Shinji Takeyama del racconto “Patriottismo” (la moglie dello scrittore, Yōko Sugiyama, non era interessata a lui, di certo non al punto da seguirlo fina a lì come il giovane soldato di un esercito inventato, forse lei aveva i suoi amanti, come suo marito; due figli e i doveri coniugali e la discendenza risolti, ognuno a rincorrere le proprie inclinazioni, i propri sogni, i propri bisogni): osserverà, Morita, il suo uomo darsi l’onorevole morte, sarà il testimone del suo sacrificio. Per poi seguirlo nel destino comune già scritto e provato dallo scrittore un’infinità di volte. Si può dire che tutta la sua opera non parlasse che di questo. Questo era il suo obiettivo. “Ho scoperto che la Via del samurai è la morte”, recitava lo “Hagakure”, il codice di etica samuraica risalente al periodo tra il 1710 e il 1716 quando il samurai Yamamoto Tsunetomo, ormai fattosi monaco buddhista con il nome di Yamamoto Jōchō, dettò al discepolo Tsuramoto Tashiro i suoi insegnamenti, e da Mishima riletto e commentato in un volume, “questo grande libro a cui torno di frequente e che ha guidato ogni azione della mia vita. È uno strano libro di impareggiabile moralità. Che libro energetico, rasserenante, che libro umano! La matrice da cui è nata la mia scrittura. Esso è l’eterna fonte sorgiva della mia vitalità. Mi sprona con la sua inesorabile frusta, con la sua voce imperiosa, con le sue feroci critiche, e anche in grazia della sua bellezza, che è la bellezza del ghiaccio”, scriveva nell’introduzione al libro. Lo “Hagakure”, vietato nel Giappone post-bellico e testo inscindibile dall’ideologia di morte dei figli del “vento divino”, i kamikaze, ogni pilota suicida ne teneva una copia sull’aereo, proseguiva dicendo: “Un dilemma di vita o di morte va risolto, semplicemente, scegliendo un’immediata morte. Non v’è nulla di complicato in ciò. Fatti animo e procedi”. Il tempo dei ripensamenti era terminato. Nel silenzio era giunto alla fine delle parole. Era pronto, dopo tante frasi, dopo tante simulazioni, Yukio Mishima, il più famoso scrittore giapponese al mondo, il tre volte dato favorito al Nobel per la letteratura, il controverso drammaturgo e saggista, il giornalista, il regista, l’attore, era pronto. Pronto e deciso come non mai. “Il codice del samurai va cercato nella morte. Si mediti quotidianamente sulla sua ineluttabilità. Ogni giorno, quando nulla turba il nostro corpo e la nostra mente, dobbiamo immaginarci squarciati da frecce, fucili, lance e spade, travolti da onde impetuose, avvolti da fiamme in un immenso rogo, folgorati da una saetta, scossi da un terremoto che non lascia scampo, precipitati in un dirupo senza fine, agonizzanti per una malattia o pronti al suicidio per la morte del nostro Signore. E ogni giorno, immancabilmente, dobbiamo considerarci morti. È questa l’essenza del codice del samurai”. C’è un breve film di mezz’ora in bianco e nero espressionista su uno scenario di teatro nô, muto con le didascalie e la musica dal “Tristano e Isotta” di Richard Wagner presa da una registrazione del 36, fu diretto e interpretato nel 1966 dallo stesso romanziere (aiutato alla regia da Masaki Dômoto, l’attrice Yoshiko Tsuruoka ricopre il ruolo di Reiko), si intitola “Patriottismo”, è tratto dall’omonimo racconto pubblicato nel 1961, rappresenta lo stesso doppio suicidio in seguito a “L’incidente del 26 febbraio 1936”, il fallito colpo di stato da parte di alcuni “giovani ufficiali” ultranazionalisti della Prima Divisione Gemma dell’Esercito Imperiale a favore della fazione Kōdōha (giovani ufficiali che gli parleranno dall’aldilà nel racconto “La Voce degli Spiriti Eroici”), ed è di uno stilizzato erotico realismo e per molti versi di una meditata terribile aderenza all’epilogo del 25 novembre 1970 da fare impressione (dopo la morte del marito la signora Mishima ne impedirà la diffusione fino all’ultimo dei suoi giorni). L’infinito che si annulla e si risolve in un solo momento, il primo e l’ultimo reale, non più in parole e pellicola: ora. “Sgorga il sangue, l’esistenza è distrutta, e grazie alla sensazione di annientamento essa viene per la prima volta concepita come un tutto, si colma la breccia assurda che esisteva tra il vedere e l’esistere… Questa è la morte”, aveva scritto in quel saggio sulla vitalità, il vigore e la morte intitolato “Sole e Acciaio”. Il 25 novembre del 1970 è la data scelta per dimostrare la fedeltà all’Imperatore, a un esercito ancora da venire e a loro stessi, poveri stupidi orgogliosi segreti amanti, è il giorno dell’insurrezione e del più bello degli atti, è il giorno della sublime scelta, il giorno del sorgere di un nuovo sole: è la data del colpo di stato.
Ogni cosa è stata calcolata. L’azione dovrà essere veloce e precisa. Mishima ha avvisato la stampa e la tv. «Non posso anticiparvi niente. Ma sarà un evento da non perdere». Aveva fatto consegnare alla rivista “Shinchō”, che lo stava pubblicando a puntate, l’ultimo capitolo del romanzo “La Decomposizione dell’Angelo”, il volume conclusivo – dove la decadenza della carne, il disfacimento, la putrefazione di qualsiasi illusione impregnano le pagine – della tetralogia “Il Mare della Fertilità”; terminato tre mesi prima ma che doveva riportare la data di quel giorno come ulteriore testimonianza della sua fine poetica. Non aspettare la decomposizione dell’angelo, che i fiori dai colori proibiti scolorino e appassiscano in un persistente fetore. Si parla di reincarnazione, in questi quattro libri. Nel secondo, “Cavalli in Fuga”, un personaggio, il campione di kendō e studente di estrema destra dell’università di Tōkyō Kokugakuin Isao Linuma, si toglierà la vita dopo aver visto sventato il suo piano di eliminare alcuni alti rappresentanti della politica e della finanza giapponesi, essere finito in carcere e una volta uscito aver assassinato uno degli industriali tra i suoi bersagli iniziali, con l’alba all’orizzonte sopra il mare nell’istante in cui la lama gli apre lo stomaco. Arriveranno su una Toyota Corona bianca. Hanno un appuntamento con il comandante della base, il Comandante in Capo dell’Armata Orientale, lo Jieitai, generale Kanetoshi Mashita. Mishima conosce i vertici delle Forze di Autodifesa, gli appoggi che aveva si stanno sgretolando, ma è ancora ben inserito, lo Jieitai aveva addestrato la Tatenokai (forse qualche alto ufficiale aveva in parte finanziato l’organizzazione paramilitare dello scrittore, anche se lui ha sempre smentito seccamente – si parlava di personalità molto vicine all’Imperatore Hirohito, che Mishima adorava come entità spirituale, un imperatore ideale simbolo dell’Assoluto che non c’era più, e disprezzava come uomo e politico proprio per aver rinunciato alla sua natura divina dichiarando la natura umana dell’imperatore). Può avere un appuntamento con chiunque. Anche solo per presentare i suoi uomini più valorosi ed esibire una spada di grande pregio come quella che ha con sé all’ingresso della caserma, una katana del 1600 forgiata dal maestro Seki No Magoroku. Il commando è composto da Yukio Mishima e quattro fedelissimi della Società degli Scudi: Hiroyasu Koga, detto Furu-Koga, Masayoshi Koga, soprannominato Chibi-Koga, Masahiro Ogawa, oltre a Masakatsu Morita. Solo Mishima e Morita dovranno morire, gli altri hanno il compito di tutelare l’incolumità del generale Mashita preso in ostaggio e di guidare il resto della Tatenokai al comando delle Forze di Autodifesa e alla presa del ministero da cui dipendono per il ripristino degli antichi ideali, primo tra tutti, la divinità dell’Imperatore. Il sacrificio di Mishima e del suo fedele discepolo servirà a risvegliare nel Jieitai il suo spirito autentico e spingerà il Governo a un nuovo emendamento della Costituzione che cancelli l’articolo 9 imposto dai vincitori della Seconda Guerra Mondiale che obbliga il Giappone al disarmo permanente di tutte le “forze di terra, di mare, di aria e di qualsiasi altra forza potenzialmente militare” rinunciando così “alla guerra come diritto sovrano della nazione e alla minaccia o all’uso della forza come mezzo per risolvere le controversie internazionali ”, e a una revisione del ruolo delle suddette Forze istituite nel 1954 di fatto subito depotenziate e umiliate e le ponga invece al centro della vita della Nazione, perché «lo Jieitai assuma il ruolo di nucleo su cui costruire un autentico Esercito Nazionale». Per quanto tempo avevano sperato di affiancare le Forze di Autodifesa nella repressione delle proteste degli studenti di estrema sinistra, Zengakuren, Zenkyōtō e chiunque fosse nella mischia, fianco a fianco con i militari nella lotta più cruenta, sparando con fucili e pistole, tirando colpi di spada e manganello, rompere arti e teste, farsi spaccare la faccia, corpo a corpo con i giovani incoscienti nemici, tra odore di sudore e adrenalina, il fumo dei lacrimogeni e slogan gridati, in un’esaltazione mai provata prima, mostrare sul campo di battaglia, le strade, le università, i ministeri, il loro ardimento e la necessità dell’esercito in certe faccende, e poi curarsi le ferite a vicenda, nettarsi il sangue l’uno con l’altro, tolta la mimetica, le protezioni, nudi e ancora eccitati dallo scontro, i membri eretti, venire improvvisamente sotto le docce, sui corpi dei propri compagni di combattimento affaticati e felici, ridere, festeggiare e abbracciarsi, i sessi a contatto, una mano stringe un gluteo ipertrofico, la mano separa le natiche, baciarsi, masturbarsi per scaricare la tensione residua, incularsi e assaporare lo sperma di un altro eroe simile a se stessi, con lo stesso proprio sapore di soddisfazione, sarebbe stato di una gioia incontenibile, ma non era mai accaduto nulla e la sua milizia privata restava inerte ad assistere gli interventi della polizia. La polizia che sedando la sommossa del 21 ottobre del 1969 aveva evidenziato una volta per tutte l’inutilità di ogni riforma costituzionale a favore dello Jieitai. L’esercito non serve più a niente. «Stampatevi in testa questa data! 21 ottobre 1969. Fu il giorno in cui vennero tradite definitivamente le speranze delle Forze di Autodifesa che avevano atteso per anni l’emendamento della Costituzione, sempre eluso dai programmi politici». Non rimaneva che un’azione di forza eclatante. «Se in questo regime parlamentare non è più possibile emendare la Costituzione, la nascita di un movimento che riporti ordine e sicurezza è l’unica possibilità rimasta. Noi intendiamo offrire la vita per diventare l’avanguardia di questa mobilitazione, ci proponiamo di diventare una piccola pietra su cui fondare l’Esercito Nazionale. È dovere dell’esercito proteggere la Nazione, alla polizia spetta la difesa della struttura politica», aveva scritto nel proclama e ora lo urlava. E aveva urlato tra gli insulti e i fischi la denuncia della corruzione e degli interessi privati della politica che aveva fatto delle Forze di Autodifesa l’espressione della sua degenerazione morale. Un esercito che continua a portare la croce di una nazione sconfitta e mai vendicata. «Quando giunge il momento in cui le forze di polizia non riescono più a difendere la politica, la Nazione si sente protetta dall’azione delle forze armate e queste in tal modo riacquistano il loro valore originario. Il principio fondamentale dell’esercito consiste esclusivamente nel difendere la storia, la cultura e le tradizioni del Giappone fondate sull’Imperatore».
«C’hai stancato! Quando la finisci?».
«Se siete uomini, come può il vostro orgoglio virile tollerare tutto questo? Quando, tollerato l’intollerabile, viene oltrepassata l’ultima linea da difendere, un uomo, un guerriero deve ergersi risolutamente. Siamo rimasti ansiosamente in ascolto. Ma dalle Forze di Autodifesa non si è levata nessuna voce virile contro l’ordine umiliante di accettare e difendere questa Costituzione che di fatto ne nega l’esistenza».
Continuano a levarsi gli urli e le risa ai quali si aggiunge la sopravvenuta noia di molti: è un’esibizione inutile. Quando finirà?
«Si è forse corrotto irrimediabilmente lo spirito dello Jieitai, che si è lasciato sedurre dalle lusinghe dei politici e percorre un sentiero che lo conduce all’autoinganno e all’autoprofanazione più profondi? Dov’è finito lo spirito dei samurai? Qual è il significato di questo esercito diventato ormai un enorme arsenale privo di anima? Dove vuole andare?».
Porsi così, loro, questi fanatici giovani uomini, a difesa della Nazione minacciata giorno dopo giorno dalle forze comuniste radicali (malgrado Mishima avesse in gran simpatia quegli infervorati studenti: «Sarei stato pronto a mettermi dalla vostra parte, dissi al comitato di lotta Zenkyōtō, e a occupare con voi l’aula magna Yasuda, per scuotere questo Paese. Se solo voi aveste gridato “Viva l’Imperatore!”. Ma non lo avete fatto e non lo farete mai, lo so»), non rimaneva che questo. Gli scontri tra polizia e studenti comunisti si fanno sempre più violenti. Il 68 giapponese e i suoi strascichi. Barricate, occupazioni interminabili, facoltà in fiamme, molotov, nella nuova sinistra si fa spazio la Sekigunha, la Fazione dell’Armata Rossa che tenta un assalto alla residenza del Primo Ministro. Oltre cinquanta dei suoi membri vengono arrestati dalla polizia. Il 31 marzo del 1970 dirotta il volo 351 Tōkyō-Fukuoka della Japan Airlines. I nove dirottatori, armati di katane e bombe a mano, rilasciano i centoventidue passeggeri all’aeroporto Gimpo di Seul e i sette componenti del personale di bordo del Boeing 727 all’aeroporto militare Mirim di Pyongyang nella Corea del Nord, che accoglie la richiesta di asilo politico dei terroristi. La polizia continua a fare arresti. Entro la fine del 1970 il gruppo vede in cella oltre duecento dei suoi membri. I superstiti formeranno le più agguerrite organizzazioni terroristiche Esercito Rosso Unito, il Rengō Sekigun, e la Nihon Sekigun, l’Armata Rossa Giapponese. Mentre il Tatenokai continua a restare a guardare. Il governo è privo di dignità. Reprime, effettua arresti e cerca la normalizzazione. La Nazione è allo sbando. Senza identità. Senza Forze Armate. Il Partito Liberaldemocratico e il Partito Comunista fanno accordi tra di loro e si spartiscono il potere. «Per me il Partito Comunista e quello Liberaldemocratico sono la stessa cosa. Sono il simbolo della medesima ipocrisia». L’alzata di testa nazionalista è ormai un sogno irrealizzabile. Il Paese sarà in mano all’eversione rossa che vuole abbattere la monarchia, o resterà tutto uguale, asserviti agli americani e con un Imperatore che è come se non ci fosse, questo si dibatte all’interno della Società degli Scudi, che non protegge nessuno. Gli scudi sono di cartone. Che scemenze le parate con la divisa del sarto del Generale de Gaulle e la bandiera con il kabuto rosso su sfondo bianco. «La Tatenokai è un esercito pronto a intervenire in ogni momento. È impossibile prevedere quando entrerà in azione. Forse mai. Forse domani». Nessuno li prende sul serio. Quello della Tatenokai è un piano destinato al fallimento. Per un paradossale disguido, il resto della Società degli Scudi, circa un centinaio di ragazzi reclutati due anni prima nell’organizzazione studentesca di estrema destra riconducibile al foglio universitario “Ronso Journal”, non è stato avvisato dell’azione. O meglio, la richiesta di presentarsi al comando delle Forze di Autodifesa e di unirsi ai militari della caserma, come da condizioni di Mishima, era stata inoltrata, ma veniva da un delegato dello Jieitai che non fu creduto dai ragazzi in divisa marrone dai riflessi giallo-bruni convocati senza alcuna direttiva in un edificio dell’Armata situato a circa un chilometro di distanza dalla base di Ichigaya. Idioti. C’era da ridere. E ridono e schiamazzano i soldati radunati nel cortile per volere di Mishima, continuano a ridere e ad annoiarsi. Lo show è durato anche troppo. Gli elicotteri non la smettono di sorvolare la zona. Gli altoparlanti avevano ordinato l’adunata ed eccoli ancora lì ad assistere alle battute finali di quello spettacolo. L’annuncio diffuso dagli altoparlanti aveva dato inizio alla confusione sotto il balcone. Nessun membro della Tatenokai ha potuto convincere i militari a seguire il proclama del loro comandante, nessuno di loro può scuotere questo reggimento debosciato e ridanciano, nessuno di loro può guidare l’assalto alla caserma e persuadere gli alti ufficiali a unirsi alla ribellione: perché lì non c’è nessuno dei fedeli di Yukio Mishima. È un golpe da farsa perpetrato da un esercito da operetta armato solo di spade.
«Se entro due anni lo Jieitai non riacquisterà la propria autonomia, rimarrà per sempre, come afferma la sinistra, una congrega di mercenari al soldo dell’America. Abbiamo aspettato quattro anni. L’ultimo anno con particolare ansia. Non possiamo attendere ancora! Non c’è più motivo di aspettare qualcuno che continua a rinnegare se stesso. Tuttavia attenderemo altri trenta minuti. Gli ultimi trenta minuti! Insorgeremo insieme e insieme moriremo per la giusta causa» seguita a urlare Mishima ripetendo a memoria il suo gekibun, il proclama. Alla sua destra, sulla balaustra del balcone, sono stati fatti calare da Morita e Ogawa due lunghi rotoli di tessuto bianco con scritte le condizioni per il rilascio del generale Mashita e le parti principali del proclama. Su dei volantini c’è stampato il discorso con i punti di rivendicazione: punto per punto. Mishima li ha lanciati alla folla. Pochi li hanno raccolti, nessuno li legge. Ridono, denigrano, sbeffeggiano e non leggono.
«Ammazzati e falla finita! Non ne possiamo più!».
Il fallimento è totale. I quattro giovani del commando sono sconvolti e sconfitti, non immaginavano che sarebbe finita così. Tutto è stato sbagliato. La situazione è tragica e comica, patetica e sublime. L’eroe che si dimostra tale solo nel ridicolo e nella sconfitta è lì, nella stanza 201. Sono grotteschi e meravigliosi. Il gesto esemplare per la riscossa di Mishima si trasforma in un suicidio per la vergogna e per tutelare l’onore rimasto. Per la bellezza.
I superstiti, condotti dalla polizia fuori dalla caserma circondati da macchine fotografiche, telecamere, giornalisti e militari che continuano con quella confusione, saranno condannati a quattro anni di prigione per l’occupazione della base e lesioni personali. Usciranno prima del tempo per buona condotta. Hiroyasu Koga non verrà neanche incriminato per aver fatto da kaishakunin nel duplice seppuku – l’ultimo kaishakunin del Giappone. Le spese legali saranno sostenute da Mishima con un lascito di denaro a loro favore previsto nel caso le cose si fossero messe male. In tribunale, i ragazzi porteranno avanti le istanze e l’ideologia della Tatenokai. Senza più troppa convinzione. Tutto qui. La Società degli Scudi sarà ufficialmente sciolta il 28 febbraio 1971. La questione verrà liquidata come “L’incidente Mishima”. Uno dei tanti della martoriata storia di quella nazione. Uno “strano caso” che il Giappone vuole rimuovere dalla sua memoria.
«Dobbiamo morire per restituire al Giappone il suo vero volto! Avete così cara la vita da lasciare perire lo spirito? Che esercito è mai questo che non riconosce valore più nobile della vita? Ora testimonieremo a tutti voi l’esistenza di un valore più alto dell’attaccamento alla vita. Questo valore non è la libertà! Non è la democrazia! È il Giappone! Il Giappone, il Paese della nostra amata storia e delle nostre tradizioni. Il Giappone! Non c’è nessuno tra voi che desideri morire per scagliarsi contro la Costituzione che ha disossato la nostra Patria? Se c’è, che sorga e muoia con noi! Abbiamo intrapreso questa azione nell’ardente speranza che voi tutti, a cui è stato dato in dono uno spirito purissimo, possiate tornare a essere veri uomini, veri samurai!». Mishima aveva concluso la sua arringa. Nessuno lo aveva ascoltato. Gli “spiriti purissimi” ridono e lanciano a quella bizzarra figurina che muove la bocca e si agita su un balcone gli insulti rimasti. Figuriamoci se hanno voglia di seguirlo. Hanno la vita comoda e i ventri molli pieni di hot dog, gonfi di bibite gassate e la testa rincretinita da film americani e televisione. Lui li guarda affannato.
«E vattene! Te ne vuoi andare!» gli gridano. Fischiano. «Vattene, non fai neanche più ridere».
Sì, è il momento di voltargli le spalle e rientrare nella stanza 201.
«Lunga vita all’Imperatore!» aggiunge Mishima urlando per tre volte «Tennō Heika banzai!», alla quarta si unisce Morita, che lo aveva seguito in disparte per tutto il comizio. «Tennō Heika banzai!» urla anche lui. Mishima e Morita rientrano. “Se uno muore dopo aver fallito, la sua è morte da fanatico, vana morte. Non però disonorevole. Tale morte è, in effetti, la Via del samurai”. Mishima si sfila i guanti e gli stivali e si inginocchia a terra. Si sbottona la giubba. Se la toglie. Rimane a torso nudo. Il suo corpo nella tragedia è ancora più bello e traboccante di vitalità. Si apre i calzoni. Prende lo yoroidōshi.
«No, non lo faccia!», urla il Generale Mashita, legato alla sedia dietro la sua scrivania. «La imploro, non c’è motivo».
Mishima non lo ascolta: è ormai chiuso nella sua azione. L’affilato pugnale risplende al sole autunnale che entra dal vetro della finestra ora richiusa per avere un po’ di silenzio, sarebbe bastato solo un po’ di silenzio, e lo poggia al lato dello stomaco, più teso del solito. La scena è quella di “Patriottismo”. Non c’è molto da aggiungere. Il rito mortale si chiama seppuku (lo sventramento dei samurai). Morita deve porre fine al suo supplizio con il kaishaku, il taglio della testa. Ma è spaventato e inesperto, in fondo non è un vero militare, nessuno di loro lo è, neanche Mishima, che fu riformato alla visita di leva e mandato alla Mobilitazione per il Lavoro e non poté morire in guerra come desiderava. Il “kamikaze per la bellezza” che agonizza con gli intestini scivolati fuori dal ventre fa segno al suo amore in lacrime di calare la katana. La spada lo colpisce alla spalla, gli apre uno squarcio, poi va a vuoto, la schiena, un altro taglio, infine prende il collo dello scrittore, non riesce a mozzarlo né a tagliare la testa senza staccarla uccidendolo secondo il tradizionale rituale. Il capo penzola appena come quello di un manichino dei grandi magazzini di Tōkyō spogliato e rotto, come quello di una marionetta del bunraku sfasciata. Interviene Hiroyasu Koga, l’unico vero esperto, oltre a Mishima, di kendō e di iaidō, il solo che sa maneggiare con abilità e freddezza una spada, e pone fine all’agonia del suo comandante staccandogli la testa di netto. “Quando si è presa la decisione di uccidere una persona, anche se sarà assai difficile riuscire seguendo un percorso rettilineo, indugiare in lunghi accerchiamenti non avrà alcuna efficacia. La regola del samurai impone l’immediatezza. Dunque è meglio attaccare frontalmente”.
Mishima, prima che Morita sferrasse il suo colpo della pietà e della dignità, gli aveva fatto segno di non seguirlo – almeno così pareva dall’espressione del viso trasformato dal dolore. Di non seguirlo più. Risparmia la tua vita, mio dolce e piccolo amico. Per ricordare. Ricorda l’odore dei nostri giorni d’amore e non questo tanfo di intestini, sangue, paura, coraggio, eroismo, onore e disperazione. Ricorda il profumo dei mandorli in fiore fuori dalla finestra. Non so se ho mai creduto fino in fondo a questa faccenda – forse a forza di scriverla vi ho creduto. Ho creduto nella morte. Nell’amore che si sarebbe sublimato solo nella morte. Ho creduto in te, in noi. Nel nostro Assoluto che si insinuava nei gesti d’amore, che sarebbe sbocciato in un atto di morte comune tanto bramato. Certo, l’ho pensato davvero, l’ho detto, nei nostri corpi avvinghiati, l’ho sussurrato, ma tu adesso non morire. Non morire in questa che ora si rivela una follia e io non lo so, non lo so più.
“Quando penso ai miei ultimi venticinque anni mi meraviglio di quanto siano stati vuoti. Non posso dire di avere realmente vissuto. Sono soltanto passato oltre turandomi il naso. In questi venticinque anni ho perso una ad una tutte le mie speranze, e ora che mi sembra di scorgere la fine del mio viaggio, sono stupito dall’immenso sperpero di energie che ho dedicato a speranze del tutto vuote e volgari”, aveva scritto nelle pagine conclusive delle “Lezioni Spirituali per Giovani Samurai”.
Ricorda, mio tenero e forte amico, mio uomo e ragazzo, l’odore dei nostri corpi umidi dopo il bagno. Nudi e bellissimi. Della mia bocca calda sul tuo sesso turgido e voglioso. Tra venti anni tu avrai l’età che ho io ora, sarai al massimo della forma fisica grazie al sole e all’acciaio, ai miei insegnamenti che tu non dimenticherai, ma io sarei un vecchio privo della forza e della bellezza di adesso, non ho voluto diventare come Kawabata, non mi importa niente del Nobel, non voglio che tu assista al mio declino fisico, la bellezza dura il tempo del battito d’ali di una farfalla, e presto le mie ali non avrebbero battuto più. Non farlo. Ti prego, mio delizioso amico. Tutto è perduto, e tu non devi farlo.
Ma Morita, il cui nome, Masakatsu Morita, vuol dire Sempre Vittorioso, ripete, goffamente, incapace, il rito del suo maestro – portato a conclusione di nuovo con l’aiuto di Furu-Koga: perché se l’erano giurati in un patto di sangue durante uno di quei pomeriggi di estasi, lo shinjū, il suicidio di due amanti maledetti che adesso si doveva compiere, e per il disonore di non essere stato capace di porre fine alle sofferenze del suo uomo; per continuare a stare con lui in un luogo che non sa dove sia. Ma sa che c’è. C’è di sicuro. «Quel giorno saremo lì, tu e io».
Lo sperma di Mishima scende nella gola di Morita. Poi è quello di Morita a dissetare il suo maestro. Alcune gocce gli colano dalle labbra sul mento. Su quella sottile riga di peli sul torace. C’è silenzio. Il sole è calato. Ci sono i loro sospiri del piacere che va sopendosi. Il respiro del ricordo che ancora è nei corpi. E c’è silenzio.
Le ultime parole di Mishima, rientrato dal balcone esausto e amareggiato, rivolte ai suoi giovani adepti, sono state: «Non hanno sentito niente», disse accennando un contratto sorriso di sconforto. «Penso che non abbiano sentito niente».
“La vita umana è breve, ma io vorrei vivere per sempre.
Yukio Mishima. 25 novembre 1970”.
“La brezza che attraversa il campo sa del mio cuore tenuto nascosto fino a oggi.
Masakatsu Morita. 25 novembre 1970”.
[1] Pubblicato su “Verde” del 20 novembre 2017.
 Giulfin, Sparire
Giulfin, Sparire
Ascenseur pour l’échafaud è la nuova rubrica mensile di Sergio Gilles Lacavalla. La seconda puntata è la lunga e appassionante narrazione attorno a Yukio Mishima, a quarantasette anni dal Proclama del 25 novembre 1970 e dal seppuku rituale.
L’illustrazione è di Giulfin. Buon inizio di settimana.
View original post 5.957 altre parole
Ascenseur pour l’échafaud # 1: Zdzisław Beksiński[1]
«Zdzisław, avevi dipinto noi, vero? La tua famiglia».
«No, che dici? È solo un’immagine alla quale non ho attribuito nessun significato, ormai dovresti saperlo, Zofią. E poi ne è passato di tempo, su».
«È che quella croce, la donna sulla croce, l’uomo che la trascina, il bambino sopra… siamo noi, Zdzisław. L’ho sempre pensato. Non ho mai smesso di pensarlo. Non ti dicevo niente ma lo pensavo. Lo penso soprattutto adesso che io… Ormai siamo diventati un peso per te, Tomasz e io. Lo siamo sempre stati. Da quando Tomasz era piccolo e già si vedeva che… be’, che era strano, tarato, Zdzisław».
«Non dire così».
«Un peso diventato adesso troppo gravoso. Sei stanco. Siamo tutti stanchi. Un peso. Come lo sono state le nostre madri. Un peso anche loro. Un fardello da sopportare cristianamente. Così vecchie e malate. Il respiro della morte nelle loro stanze. Lo ricordi quel respiro? E l’odore. Medicinali, vecchiaia e morte. Il corpo che si decomponeva lentamente. Fai che quando sarà il momento io non abbia quell’odore. Anche nostro figlio è malato. Anche lui, a modo suo, nella sua musica, tra tutti quei dischi stranieri, e tutti quegli antidepressivi, Dio quante pillole, si sta decomponendo».
«Tomasz non è malato. È soltanto un ragazzo troppo sensibile: quello che per noi è solo un fastidio, un leggero malessere, per lui è fonte di sofferenze infinite. Ma non è malato. E la sua musica, quei dischi che ascolta di continuo e fa ascoltare, lo tengono in vita e gli faranno bene. Vedrai, prima o poi gli passerà».
«Sì, alle donne fa sentire i dischi, prende tempo: perché quando lo baciano, quando sono nude davanti a lui e lo toccano, lo abbracciano, lui vorrebbe fuggire. Non ce la fa. E loro se ne vanno, lasciandolo più solo di prima con la sua musica che le segue fino alle scale. Pensi che la prossima volta ci riuscirà. No, non intendo con una ragazza, no, voglio dire, a… sì, a uccidersi? Guarda come ne è uscito l’ultima volta. Sembrava proprio una creatura dei tuoi lavori. Non voglio neanche pensarci».
«Non pensarci».
«Non pensarci, già, non pensarci. Tu basta che ci riprendi con la tua telecamera e non fai niente. Se non ricordarcelo in ogni momento. Ogni parete di questa casa ce lo ricorda. I tuoi quadri ci ricordano che siamo tutti malati. E che stiamo soffrendo».
«Non sono che quadri. Solo dipinti a cui non attribuisco nessun significato. Come te lo devo dire? Ci permettono di vivere, e bene. Sono fotografie dei sogni».
«La tua solita frase per le interviste. Sono fotografie degli incubi. La nostra vita è un incubo. Io sto morendo, Zdzisław, lo ha detto il medico. E spegni quella telecamera, ti prego. Spegnila, Zdzisław, e lasciaci in pace».
Zdzisław Beksiński era divorato dallo squallore di una vita normale. L’inferno è la famiglia in un palazzo di Varsavia. Dove non succede niente. Tutto va bene. Perché nella vita di chiunque tutto va così. Il clamore delle mostre del più importante pittore polacco contemporaneo, “il miglior artista dei primi trent’anni della Repubblica Popolare Polacca”, come fu definito dalla critica nel 1975, in quell’ordinario condominio non entra. C’è soltanto la musica classica che avvolge il suo studio, da lì copre la cucina e invade tutte le stanze, a volte sono i dischi rock che suo figlio baratta dall’Inghilterra con i quadri del padre (i musicisti di Beksiński sono mostri che soffiano in una tromba, stridono con l’archetto le corde di un violino), la musica che non cessa mai quando lavora e soffoca i muti lamenti dei suoi familiari. A ognuno di loro ha donato una decina di dipinti, li chiama “il fondo pensione”. A ognuno di loro ha trasmesso la sua insoddisfazione mascherata dalla serenità del buon padre di famiglia. Sorride. Tomasz tenta l’ennesimo suicidio, dopo le pillole il gas. Un botto tremendo. I vicini, spaventati dall’inetta impresa di quel giovane pazzo, chiamano i pompieri e si riversano per le scale come si trovano sul momento. Mormorano, parlano di quella famiglia famosa e del loro figlio strambo. Ustioni sparse sul suo corpo. Schegge di vetro conficcate nella pelle. Niente di grave. Lui lo trascina svenuto sul pianerottolo.
Aveva dovuto abbattere la porta della stanza dove si era rinchiuso il ragazzo dopo aver ingurgitato un’intera scatola di ipnotici.
«Ma perché fai così? Sei un dj e un giornalista di successo. Il tuo programma di musica rock alla radio è il più ascoltato del paese. Anche le tue serate quando metti i dischi mi sembra che piacciano molto. Piene di ragazzi. Sempre pieno. Potresti avere tutte le donne che vuoi. Divertirti. Invece no, te ne stai qui rinchiuso a morire giorno dopo giorno. Poi ci provi con i farmaci, col gas, e ancora i sonniferi e sei da capo. Ogni volta è peggio. Che dobbiamo fare? Non lo sappiamo più, davvero non sappiamo più cosa fare. Cos’hai? Parlane, con me o con la mamma. O alla radio, ecco, potresti parlarne in trasmissione, che ne dici?»
«È inutile, tu non capisci. Nessuno può capire. Né alla radio né altrove. Neanche io capisco, sai? Non è solo per il fatto delle ragazze. Le difficoltà che ho con loro sono solamente un sintomo, una conseguenza di… non lo so. Non Lo So. Basta! No, tu non puoi capire. Mi regali i tuoi quadri e non capisci. Non capisci niente. Toglimi quella telecamera dalla faccia. Ho detto: Togli Quella Telecamera!».
A volte, dopo certe discussioni, sempre uguali, la stanza di Tomasz, la cucina dei suoi genitori, sembravano uno di quei quadri di suo padre. Una scena di distruzione e morte. A casa Beksiński si moriva ogni giorno.
Zdzisław Beksiński registrò con la sua telecamera l’agonia dell’anziana madre, della suocera. Le camere erano stanze d’ospedale, reparti di rianimazione con le flebo e l’ossigeno. La versione realista dei suoi quadri surrealisti.
I due amanti ridotti quasi a scheletri che si abbracciano seduti a terra, una terra sterile in un’atmosfera contaminata, nel crepuscolo atomico di un dipinto del 1984, sono suo figlio e la sua ragazza del momento? Sono lui, Zdzisław, il grande pittore, e la sua fedele e paziente moglie, Zofią Heleną Stankiewicz, sposata nel 1951 quando erano ragazzi e lei era bella? I corpi si stringono, forse lui la sta penetrando, ma non c’è sensualità, non c’è futuro: solamente disperazione in un abbraccio tra due esseri che muoiono insieme. Il quadro, senza titolo, come quasi tutte le sue opere – perché che titolo dare alla putrefazione, alle cose che vanno verso l’annientamento, che sopravvivono solo per aspettare la fine, la loro fine, la fine di tutto? – più che orrore e raccapriccio suggerisce una sconfinata melanconia. Altri due amanti si abbracciano su una panchina. Sono due, tre, forse di più, più braccia e gambe e piedi si intrecciano, più teschi, non sono teste ma teschi, non si capisce bene quanti siano. Di certo, di evidente, c’è che sono abbracci di una quotidianità esausta. Già morta ma che si ostina ad aggrapparsi all’altrui sofferenza per mitigare la propria – o per riconoscersi in essa. Due umanoidi scarnificati scopavano sulla neve, tra animali mutati che li osservavano in mezzo alle macerie di una città abbandonata; fottono come possono. Un uomo, più scheletro che uomo, era sopra una donna: erano nudi e lei era anoressica. Sono spogliati e sdraiati su due tavole di legno messe a croce coperte da un lenzuolo che fa da sudario a uno stentato amplesso.
Inadeguati a ogni relazione.
Il regime comunista e poi la sua caduta, il tonfo che sbatté lontano l’Unione Sovietica, Mosca, la cortina di ferro che si liquefa, il Patto di Varsavia si scioglie e la guerra fredda depone (o quasi) le armi, il freddo non si tempera mai, poi Solidarność al governo e l’affannata democrazia, il passaggio dall’economia centralizzata a quella di mercato, insomma, i grandi eventi storici, non sono niente davanti alle minime ed enormi storie di un interno, alla vita e al fallimento di una coppia, alla sconfitta della famiglia. Ognuno ha i propri drammi e la storia di ognuno è solo la storia tra le mura domestiche. Quanto può essere affliggente un legame familiare. Non ci si accorge neanche di cosa avviene fuori.
«Questa è la mia ultima trasmissione del 1999, cari ascoltatori. Ci sarà il 2000? Intanto, buone feste».
Le strade di Varsavia sono colorate dalle luminarie.
L’abitazione di Tomasz, proprio di fronte a quella dei suoi genitori, ha le luci fosche del tentativo di un rapporto sadomaso: latex, sottomissione, parole sconce, un frustino e «leccami le suole degli stivali, avanti piccolo schiavo impotente», dice la sua ex fidanzata tornata per gli auguri. Sta al gioco, cerca di divertirsi, ma che idiozia, è proprio un’idiozia, una tragica patetica farsa che si risolve con lei che ridendo lo abbandona di nuovo al suo pianto e alla sua sconfitta. Anche lei, al contatto con la fredda aria natalizia, avrebbe voglia di piangere.
Quando Zdzisław Beksiński, alla vigilia di Natale buttò giù la porta dell’appartamento del figlio, privo di addobbi festivi, e lo trovò finalmente riappacificato con quella quotidianità di dolore, finalmente vittorioso nel ripetuto scontro-incontro con la morte, finalmente cadavere pieno di psicofarmaci che giace con la bocca irrigidita e liberato sul pavimento, niente più rapporti deludenti con nessuna donna, con nessuno al mondo, non poté far altro che accendere la sua telecamera e riprenderlo: fermare la morte su nastro, come aveva fatto tutte quelle volte sui fogli con le matite, sulle tavole di legno con i colori a olio per la gioia di galleristi, collezionisti e direttori di musei e l’angoscia del pubblico reso inquieto da quelle disturbanti visioni. E prima ancora nelle foto. Una donna in guêpière è sdraiata sulle rotaie e aspetta il treno che la investa e la decapiti. Staccare via quella maledetta testa. Fine di ogni pensiero. Di ogni relazione come pensiero. Come cruccio esistenziale. È la solita storia. I più sensibili la capiscono. Sguardi di uomini e donne persi nella paura di stare al mondo. Una donna urla coprendosi gli occhi con il polso e la mano aperta. Una donna nuda, la pancia un po’ gonfia, si tiene con le mani il capo rivolto al cielo, il cielo è bianco, dietro di lei un albero dal tronco e i rami secchi. La fotografia del volto di donna bucato da un baratro nero: una femmina senza faccia. Il male di sopravvivere ed essere già morti non ha volto. Tutti i personaggi del suo tragico teatrino pittorico non avranno quasi mai volto. A volte sono bendati. Altre il viso è celato dai capelli. Sono rare le volte in cui la faccia appare con tutti i suoi connotati – e più che altro sono grotteschi. Tanto non c’è più niente di vivo ed edificante da guardare. Gli occhi è meglio bendarli, cucirli, non averli più. Se provate a guardarvi intorno non vedrete che rovine di corpi e di costruzioni e la luce è come quella dopo un’esplosione nucleare. Anche il buio. Se osservate bene nel vostro appartamento, oltre i muri, nella strada sotto casa spostando le tendine delle finestre del salotto e della cucina, dalla strada il palazzo dove abitate, non vedrete che ruderi. Paesaggi apocalittici. Dai colori irreali. Se guardate bene non vedrete che questo. Meglio cacciarsi gli occhi. Sì, è meglio. Aveva ragione lui. Anche se scherzava, anche se rideva, «ma c’è pure ironia, non la vedete?», aveva ragione lui. Le nostre case ci assomigliano. I mezzi con cui ci spostiamo per la città, un autobus (Beksiński aveva disegnato le carrozzerie di alcuni modelli di pullman turistici per la fabbrica fondata da suo nonno, la Autosan della natia Sanok), un’automobile, sono carcasse bruciacchiate che non camminano più. In panne su una strada desertificata. Senza conducente. Solo su una motocicletta c’è qualcuno: ma la moto è bloccata dal cavalletto.
Il corpo nudo di una donna inquadrato di schiena dall’obiettivo e stretto in un corpetto di fili, il “Gorset Sadysty” fotografato ed esposto nel 1957, quando Beksiński andava affermandosi come uno dei protagonisti dell’avanguardia fotografica polacca, mostra forme deturpate da questa ragnatela, la leggera cellulite sul sedere già spugnoso della giovane modella anticipa il disfacimento che arriverà con l’età e la prolungata vita di coppia. La modella è sua moglie. La sua musa fotografica. La bellissima moglie diventerà vecchia e non più attraente. Il desiderio sessuale mortificato dall’abitudine. Cadente il marito. L’intelligenza dei discorsi abbassata all’idiozia della ripetizione. La meschinità della vita altera i corpi. Li sforma, li rinsecchisce. Li rende mostruosi e incomprensibili. E tutto questo è presente fin dall’inizio. Forse aveva fatto bene Tomasz a farla finita in quel modo, prima che le sue braccia stringessero un corpo in sfacelo come i pensieri che si porta dietro. Forse vedeva quel deterioramento della carne e dell’essenza psichica nelle ragazze che frequentava. Sarebbero diventate così. La sua ragazza sarebbe diventata così. Così sarebbe diventato lui, che intanto aveva perso i capelli. Non avrebbe atteso come suo padre. Il suicidio è una bella possibilità. Da non mancare. Zdzisław ritardò la chiamata degli inutili soccorsi per rimanere a lungo seduto in cucina, in silenzio, senza pensieri, con una rassegnazione priva di ragionamenti e la macchina da presa fissa su quel corpo. L’anno prima, il 22 settembre, aveva trovato, più o meno nella stessa posizione, sua moglie sul pavimento della cucina. Il previsto aneurisma aortico l’aveva sbattuta al suolo: un rivolo di sangue le usciva dalla bocca e sporcava il pavimento. L’ultima inaspettata traccia di colore della morte. Riprese anche lei, fissando lo sguardo sulla macchia di sangue. Non c’era mai sangue nei quadri di Beksiński: le sue creature erano già dissanguate. Da tempo Zofią e Zdzisław dormivano in letti separati. La distanza tra due letti può essere di chilometri.
La donna ride, è nuda, ancora giovane, bei seni, tra le cosce ha la testa di qualcuno, o di qualcosa. Ma ride da una croce: è un’opera del 1966. L’anno successivo, un’altra donna riderà beffarda a un ragazzino che si tiene alle sue gambe, il viso ancora rivolto sul suo pube scoperto. Le calze arrivano a metà coscia. Nel 1973 la donna nuda tiene il crocifisso in mano. I capelli le coprono il volto. Avanza cieca, nell’altra mano impugna qualcosa di difficilmente identificabile. Una ballerina in tutù aveva il corpo coperto di cicatrici, punti di sutura ovunque come labbra cucite, cucita era la bocca, la danzatrice non ha seno, forse le è stato asportato chirurgicamente, è un quadro del 1969. Una donna spinge una carrozzina infantile, come una Madre Coraggio brechtiana che procede verso la morte con il suo carretto di putride mercanzie. Ogni figlio è mandato a morire nella guerra della vita. La cicatrice più evidente della ballerina tagliava in due, orizzontalmente, la sua pancia. Sembrava un ghigno. L’orrenda cicatrice di un maldestro taglio cesareo fuori misura. Poi sulla croce ci sarà la famiglia con il marito e padre a trainarla mediante una fune legata al suo pesante altare, la schiena dell’uomo piegata dalla fatica. Il bambino si aggrappa all’albero maestro della struttura, terrorizzato. Bianco come un piccolo fantasma. Quella croce. 1974, quando il bambino era un adolescente. L’uomo e la donna, persone mature, di mezza età. Ora il bambino è diventato un uomo; e poi un cadavere. L’uomo e la donna, due vecchi. Alla fine le croci saranno vuote e svettanti sul nulla.
«Tutte quelle croci, Zdzisław. Sempre quelle croci. Sembra che tu non aspetti altro che io me ne vada. I tuoi cimiteri, i tuoi ossari. Ma stai tranquillo, sarà in silenzio. Come abbiamo sempre vissuto. In religioso silenzio».
«Non è così, Zofią. Non è così, io ti amo e tu resterai con me. E poi di che silenzio parli? Ma è inutile che ti dia ancora spiegazioni».
«Già. Però mi riprendi con la tua telecamera. Invece di abbracciarmi».
Se ne stai lì, adesso, Zdzisław Beksiński, ad aspettare la sua di morte. La casa è vuota. Ormai sempre vuota. Malgrado il successo e i galleristi e i musei che lo reclamano, lui se ne sta lì, a trafficare con la sua ultima scoperta, l’arte digitale; ha ripreso a lavorare sulle foto, con il computer fa fotomontaggi. In uno c’è un uomo di spalle, sulle spalle ha poggiato un impermeabile sgualcito, la postura è curva, stanca, guarda la luna che filtra dalla finestra di un rudere. Vorrebbe essere su quel satellite. La luna è enorme e luminosa. Una nostalgia infinita lo cattura.
Passa intere giornate a fissare lo squallore della sua casa con gli spettri della famiglia inghiottita proprio dalla desolazione. Prova a parlarci. Nessuno risponde. Le uniche parole che ottengono risposta le scambia con la famiglia Kupiec (quelle al telefono con i galleristi non contano), che settimanalmente viene a riordinargli l’appartamento e a portargli la spesa, fanno piccoli lavori di manutenzione: la moglie, il marito e i due figli, fratello e sorella.
Sta lì e attende di andarsene.
E poi eccolo il momento di partire e lasciare tutto. Era ora. Ma non arriva come si aspettava. Proprio no. Non c’è una malattia a divorarlo. Nemmeno lo sfinimento dell’idea del suicidio fino alla sua attuazione. Neppure la vecchiaia. C’è solo un ragazzo di diciannove anni che lui conosce bene, si chiama Robert ed è il figlio dei coniugi Kupiec. È lui che di solito gli porta su la spesa. Quella sera però non ha nessuna busta piena di generi alimentari con sé né tantomeno è venuto per rassettargli la casa. Troppo tardi per tutto ciò. Zdzisław apre lo stesso la porta: perché non dovrebbe aprire? Ci sono ancora delle riparazioni da fare in cucina. Il rubinetto perde. Il ragazzo è quasi un amico.
«Non ti aspettavo a quest’ora. Cosa c’è?»
«Mio padre è giù, mi ha detto nel frattempo di chiudere l’acqua, sa il rubinetto, era preoccupato che gli allagasse casa mentre dormiva. Papà arriva subito».
«Va bene. C’è rimasta una Coca Cola nel frigorifero, se vuoi bevila. Dovrebbe esserci anche una fetta di dolce».
Ma il giovane non controlla il rubinetto, non chiude l’acqua, si prende la bibita, ne beve una lunga sorsata, la bocca era secca, non mangia il dolce, indugia, è nervoso. Torna nel corridoio dove è seduto Zdzisław Beksiński. In strada non c’è suo padre, non c’è neanche sua madre né sua sorella. C’è solo suo cugino Łukasz di sedici anni, che attende impaziente e spaventato una sua chiamata e la conclusione di quella fredda notte.
È il 21 febbraio del 2005, tre giorni prima del settantaseiesimo compleanno dell’artista, e Robert Kupiec gli regala diciassette coltellate all’addome e al volto. Due saranno mortali. Gli aveva chiesto dei soldi, era tornato di là e gli aveva chiesto dei soldi, li aveva pretesi, insisteva, sui trecento złoty, una miseria, che Beksiński gli ha rifiutato, minacciandolo di raccontare la cosa al padre: una miserabile scusa per estorcergli del denaro. Robert non si ferma più. Colpisce con rabbia e “inaudita violenza” (come sosterrà il giudice del tribunale del distretto di Varsavia Marek Walczak che lo condannerà a venticinque anni di carcere). Corre a chiamare suo cugino, mentre l’anziano pittore muore sul pavimento tra l’ingresso e lo studio. La polizia lo trova in mutande e canottiera sul balcone del terzo piano di Via Sonaty 6; spostato lì dai due ragazzi per depistare le indagini. La casa è riscaldata. Là fuori c’è il gelo. Ancora con l’aiuto del cugino (che si prenderà cinque anni per complicità), l’omicida ha cercato di cancellare le rimanenti tracce del delitto. Saranno arrestati due giorni dopo. Robert confesserà quando ormai è evidente che è stato lui. Łukasz reclamerà sempre la sua estraneità all’assassinio.
Finisce così, con un ragazzino che si accanisce su un corpo disfatto dagli anni e dalle morti tra quelle mura e gli ruba due videocamere e alcuni cd. Per l’ennesima volta a Beksiński tutto appare chiaro. E non ha nessuna importanza che la fine arrivi in quel modo. Pure se non se l’aspettava così, doveva però riconoscere che quella era una maniera come un’altra. La famiglia si riunisce. Non c’è scampo da un’ordinaria vita familiare. A saperlo avrebbe tenuto accesa la telecamera.
La luna sopra il balcone è bellissima.
[1] Pubblicato su “Verde” del 23 ottobre 2017.
Ciao, c’è una nuova rubrica criminale diSergio Gilles Lacavalla, si intitola Ascenseur pour l’échafaud e la leggeremo una volta al mese su Verde (so long, Rock Criminal). Prima puntata:Zdzisław Beksiński, il grande pittore. L’illustrazione è diFederico Bressani. Buon inizio di settimana.
View original post 3.340 altre parole
Place Jeanne d’Arc[1] (racconto di una cantante, una ballerina e i libri rubati)
“I can love.
But I need his heart.
I am strong even on my own.
But from him I never want to part”.(“Gabriel”, Lamb)
Il sistema ormai lo conosce alla perfezione. Facile come bere un bicchier d’acqua. Basta che la commessa alla cassa si allontani un attimo. Solo un momento. O anche una semplice distrazione. E il gioco è fatto. Davvero come bere un bicchier d’acqua, mica scherzi. Gilbert, che fa il prestigiatore proprio di fronte a lei, nella stessa Place Jeanne d’Arc davanti alla chiesa dedicata alla santa guerriera, martire e vergine (anche se lei ha sempre sospettato chissà quale amplesso ci fosse stato tra la pulzella e Gilles De Rais, magari anale, per non rovinare la sua castità che tanto piaceva alla chiesa, sodomizzata tra frecce infuocate, ossa e denti rotti, armature sfondate da mazze chiodate, affilate spade che trafiggevano ventri, gole tagliate con pugnali ricamati, teste staccate di netto per mezzo di grosse asce, olio bollente e un bacio insanguinato, sospiri di piacere soffocati dalle urla della battaglia; l’Arcangelo Michele, Santa Caterina e Santa Margherita a benedire quell’unione sotto lo stendardo bianco con le icone, i gigli d’oro, la scritta Jhesus-Maria come un marchio di moda, soffiato dal vento della guerra), Gilbert, dicevamo, un giorno glielo aveva insegnato. Certo, lui lo farebbe sparire nel nulla per farlo, dal nulla, ricomparire, e lei non è così brava, ma sa il fatto suo, comunque, e non sbaglia mai. Neanche stavolta. Avril sfoglia il libro, una bellissima copia di “Crash” di J. G. Ballard (tra parentesi, Avril ama molto lo scrittore britannico e, in particolar modo, quel libro, o meglio, sa del romanzo poiché aveva visto il film di Cronenberg, e ora vuole leggerlo perché anche a lei piace fare l’amore in automobile, cioè, le piaceva, era da tanto che non scopava nell’abitacolo di una macchina; col suo ragazzo facevano l’amore nelle auto che lui rubava, prima di rivendersele, lo facevano col brivido di poter essere scoperti, nelle stesse posizioni di Deborah Unger e James Spader, di James Spader e Holly Hunter, di Deborah Unger con Elias Koteas, di Rosanna Arquette con Holly Hunter, Rosanna Arquette e James Spader, James Spader e Elias Koteas, per finire di nuovo con Deborah Unger e James Spader, insomma, lei ricordava una cosa del genere, a volte lo facevano lanciati sulla strada, si masturbavano più che altro, lui con una mano teneva lo sterzo e con l’altra l’accarezzava tra le cosce, sotto le mutandine che ci mettevano un attimo a bagnarsi, così Avril se le doveva togliere, poi faceva lo stesso col membro teso di lui cacciato fuori dai pantaloni, lo strofinava forte stringendolo nel pugno, glielo prendeva in bocca, lui veniva accelerando, sperma nella sua gola, sulle sue labbra, sulla chiave d’accensione, sul parabrezza, sul contachilometri che sembrava scoppiasse come il cazzo turgido del suo uomo; una volta l’avevano fatto in una vettura accidentata e abbandonata sul marciapiede col muso spiaccicato addosso a un muro; poi era finito tutto, allora le piaceva anche farsi l’amore con pezzi di metallo o materiale plastico, tipo la manopola del cambio di una berlina schiantata al muro trovata qualche giorno, o forse mese, dopo che si erano lasciati ripassando nel luogo di quell’incidente: non era la stessa auto, ma quella strada non era mai sicura, potevi stare certo che ci trovavi sempre il rottame di una macchina, tutto stava passarci ed era lì, in una strada talmente fuori mano che prima che venisse un carroattrezzi a rimuoverlo ne passava di tempo. Aveva raccolto la manopola sul lato opposto della carreggiata, dov’era volata in seguito all’urto, e, senza neanche lavarla, olio asciutto ma ancora scivoloso – l’olio non si asciuga mai davvero – nella parte inferiore e, sopra, sull’impugnatura, qualche traccia di sangue rappreso, se l’era portata a casa e se l’era subito infilata nel sesso, venendo immediatamente ricordando il suo ragazzo quando la penetrava – ma una leva del cambio era senza problemi, e pure più dura, diciamolo, per non parlare della resistenza. Senza nessuna complicazione anche sporca. Avril non credeva alle malattie infettive. A nessuna malattia infettiva: invenzione dei medici, delle industrie farmaceutiche e dei preti. E poi, che gliene fregava. Comunque alla fine, a forza di umori così liquidi e abbondanti che sembrava urinasse, la leva si era pulita e adesso era quasi sterilizzata; se la metteva nella vagina e nell’ano, muovendola in prima e in retromarcia, in assoluta sicurezza).
Gira le pagine del libro guardando, senza essere osservata, di sottecchi da sopra i fogli, la cassiera: una bella ragazza col tailleur, il nome sul cartellino attaccato alla giacca (Louise – proprio come la sua amica ballerina) e gli occhiali alla moda Versace: quello ammazzato con un colpo di pistola sui gradini della sua mega villa di Miami Beach da un serial killer dedito alla prostituzione omosessuale e alla droga, per qualcuno amante dello stilista, poi rinvenuto morto suicida su una casa galleggiante ormeggiata nella baia, oppure fatto fuori in uno scontro a fuoco con l’FBI, o da un sicario della criminalità organizzata calabrese in Florida che a sua volta aveva commissionato al gigolò l’omicidio di Versace per loschi rapporti d’affari, o una cosa del tipo – così aveva letto da qualche parte; oppure: boh! La commessa si allontana un istante dalla cassa, per meglio dire, dalla macchina dei soldi, senza lasciare la sua postazione per prendere la bustina da confezione regalo dietro di lei (verde col marchio del negozio e il fiocchetto adesivo, di quelli già pronti; da bambina, quando Avril era bambina, ma pure quando lo era la commessa, devono avere più o meno la stessa età, invece, li facevano loro, le commesse dei magazzini del centro, i fiocchetti, arricciandoli alle estremità con le forbici, e anche i pacchetti, con grandi fogli di carta che tagliavano a seconda della grandezza del volume, se lo ricorda bene; «mi raccomando, un bel pacchettino», le aveva chiesto la signora, e capirai, sai che ci vuole così). Avril si avvicina, sempre facendo finta di leggere. La commessa torna, non ha fatto caso a lei che si è avvicinata, l’avrebbe notata, se fosse rimasta ferma alla cassa, se la cliente non avesse chiesto il pacchettino regalo prima di darle il libro, ma così no, e ora la commessa prende il libro: “Il Miracolo della Rosa” di Jean Genet (detto ancora tra parentesi, pure Genet è uno scrittore che Avril adora – e poi anche lei è un po’ omosessuale, non come lui, né come lui è Santa Ladra Commediante e Martire, come direbbe Sartre, be’, un poco ladra sì, ma è mai un furto rubare un libro o uno yogurt perché si ha fame? Fame allo stomaco, fame alla testa, alla fantasia, fame all’anima, per la solitudine. Non è proprio invertita, per usare un termine alla Genet, certo, ma quando la sua amica ballerina le lecca la fica, e lei la lecca alla sua amica, allora ama solo lei ed è assolutamente lesbica; l’identità sessuale è un fatto di momenti e situazioni, no? Anche quando la vede danzare a piedi nudi è del tutto lesbica: soltanto lesbica. La ama da farsi saltare il cuore per aria e annegare la fica nel mare del suo piacere lento e poi impetuoso. Splash! tra le gambe. Quindi ristagna come una pozzanghera in una giungla estremorientale. Forse la giungla dell’Indocina ha lo stesso odore. Forse. Di fiori marci. Come quella dell’Amazzonia – l’aveva letto su un fumetto italiano delle avventure di Mister No). La commessa lo infila nella bustina, il libro con la copertina di un condannato a morte che sboccia in un fiore, un fiore che non marcirà mai, sacro, eterno di vita; la vittima si dipinge di grazia nei suoi colori essendo così redenta da ogni colpa; perché ogni colore di fiore ti redime dal male, il male è l’assenza di colore: fiori su tutte le tombe, anche su quelle degli assassini. Le tombe degli assassini saranno le più belle e maestose: monumenti a chi ha conosciuto la morte in vita e l’ha celebrata mettendola in scena nella maniera più plateale possibile. Attacca il fiocchetto adesivo, fa lo scontrino. Prende i soldi. Dà il resto e poi, come sempre quando non c’è un altro cliente in coda – e ora non c’è, lei è vicino alla cassa ma sta leggendo il libro, dunque, tecnicamente non è in fila – si mette seduta sullo sgabello girevole e si volta verso il grande locale della libreria a guardare la gente che gira tra gli scaffali. Eccolo, il momento, è un attimo: J. G. Ballard scivola sullo scanner nel punto preciso dove è situata l’infida etichetta antitaccheggio, si accende la lucetta rossa che la disattiva ma non viene emesso nessun suono perché le moderne macchine di questa libreria sono silenziosissime, legge anche il codice a barre con il raggio laser e gli specchietti incorporati nello stesso apparecchio incastonato sul tavolo della cassa (alcuni volumi non hanno la targhetta antifurto ma basta la mancata letture del codice a barre per far suonare l’allarme) e il libro è libero: libero di farsi leggere fuori da lì senza permesso né scontrino, di essere suo amico per qualche giorno e parlare con lei, e così tutti i suoi personaggi chiacchiereranno con lei e si faranno ammirare nelle loro scellerate e sconce vicende, libero di ricreare ogni incidente e ogni orgasmo, anche quelli con il suo ragazzo ladro, le sue parole perfette, gelide e sensuali saranno per lei e i suoi sensi; libero di entrare nella borsa di Avril che esce dal negozio passando con nonchalance, e una certa sfacciataggine, tra i varchi d’entrata e uscita, con le loro inutili antenne, e davanti all’addetto alla sorveglianza che guarda sempre verso le porte a vetro affacciate sulla strada; le porte si aprono in un piacevole fruscio automatico. Lo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori le ricorda che è sudata, ma tranquilla, appena il cuore accelerato. Avril si chiude il giubbotto sorridendo orgogliosa di sé. Stasera “Crash” se lo leggerà sul suo divano-letto mangiando una bella tazza di latte coi biscotti allo yogurt – anche quelli “acquistati” allo stesso modo al supermercato (adora i supermercati, colorati quasi quanto i fiori di Genet, anche se più freddi. Il suo preferito è Carrefour, è un po’ più caro dei discount, ma per quello che paga i suoi prodotti. Solamente lì trova l’Ovomaltine).
Avril è felice.
“Rebel rebel, you’ve torn your dress. Rebel rebel, your face is a mess”. Avril fa un sorriso a chi le mette qualche moneta nel bicchiere di McDonald (ecco, McDonald, invece, non lo sopporta, le fa schifo e la inorridisce, un obitorio, McDonald non è altro che un obitorio di poveri animali frequentato da ragazzini ignoranti, stupidi e chiassosi, ma quei bicchieroni, come quelli della Coca Cola, d’altronde, sono l’ideale per le monete – ma anche per le banconote, casomai qualcuno fosse così buono e generoso da lasciargliene una; una mattina un tale le lasciò cinquanta euro, neanche fosse Nicola Sirkis con tutti gli Indochine, e se ne andò via barcollando, lei rimase interdetta, non riuscì neanche a ringraziarlo: restò a bocca aperta a guardare il tipo che per poco non cadeva, attraversata la piazza, scomparve girando l’angolo di Rue Lahire. Non lo rivide più. Ma ancora spera che ripassi di lì, prima o poi. Si augura, comunque, che stia bene) e va avanti con la canzone di David Bowie: “Rebel rebel, how could they know? Hot tramp, I love you so! Don’t ya?” Poi lancia uno sguardo alla sua amica ballerina che sta facendo il proprio numero con le scarpette che le ha “comprato” lei – ci siamo capiti (il sistema qui è un po’ diverso, ma magari lo spiegheremo un’altra volta): un numero che è una cosa tra il balletto, la rigorosa tecnica Cunningham e cose inventate: soprattutto cose inventate. Il prestigiatore fa comparire dalle dita della sua mano un fiore colorato di blu, bianco e rosso e lo infila tra le dita del piede di Louise, dopo averle tolto a sorpresa una scarpetta da punta mentre lei si tiene in equilibrio sull’altro piede teso, oscilla ma non cade e sorride mostrando la macchinetta ai denti. Gilbert gliela lecca, quasi in un bacio esagerato e lei chiude la bocca imbronciata. Si volta verso Avril che le fa segno «non ci far caso» e le apre un bel sorriso. Si toglie anche l’altra scarpa da punta. Danza scalza, come fa spesso.
Dividono come sempre i soldi nel bicchiere. Avril dà un piccolo bacio sulla bocca a Louise e le dice che le vuole bene perché ha sempre paura di dirle ti amo: è cresciuta senza mai sentire pronunciare quella parola dai suoi genitori, capaci solo di insultarsi, per questo non sa dirla. Louise guarda il libro di J. G. Ballard che esce dalla borsa della sua amica segnato verso pagina 50, 60 o giù di lì, fa: «Cc… rash!» e ride.
«Hai un po’ di pancia» si dice Avril guardandosi nuda allo specchio che la inquadra a figura intera e prende quasi tutta la parete del bagno così piccolo che non c’è spazio per la vasca, le mattonelle sul pavimento sono una diversa dall’altra, il muro ha l’intonaco scrostato in più punti. «Troppi biscotti… e poi, non ti muovi più. Dovresti fare come Louise, lei sì che ha una bella pancia… però sei bella lo stesso, ma sì dai, quando me lo dice Louise, ci credo». Avril continua a guardarsi: è bella, non è vero che ha la pancia, non è magrissima né ha gli addominali scoperti come la sua amica, ma la pancia proprio no, è semplicemente morbida e femminile, molto sexy; è bella, proprio bella, e lo sa, sì, a volte, dicevamo. A volte si piace e allora, quando si piace, si sente meno sola nel suo monolocale sopra la città. Nel condominio dicono che è un po’ matta, per via del suo aspetto punk. Ma non è matta: è solo punk. E un sacco carina, proprio così, malgrado qualcuno la trovi brutta «conciata in quel modo»: che cazzo vuol dire «conciata in quel modo»?! Stanotte vorrebbe terminare “Crash”, poi si masturberà, però solo con le dita [Chissà dove l’ha messa la leva? Sono giorni che non riesce a trovarla, eppure la casa è tutta lì e non c’è niente. Masturbandosi penserà di nuovo al suo ragazzo col quale non rubava solo automobili ma scriveva anche canzoni, che poi l’ha abbandonata a cantare per strada, senza nemmeno un addio come si deve, dunque sarebbe più corretto chiamarlo il suo ex ragazzo; per fortuna che una mattina ha incontrato Louise. Quindi finirà per farsi il ditalino pensando alla sua amica della malasorte. Louise è una ragazza così diversa da lei: una borghese andata via di casa perché i suoi dicevano che faceva schifo con quel trucco che le «impiastricciava» la faccia: le sopracciglia sono disegnate con la matita nera come quelle dell’ex cantante dei Dresden Dolls Amanda Palmer, la matita le colora anche il contorno degli occhi, tanta matita, i suoi occhi, occhi grandi e chiari, così sembrano quelli di una diva della Hollwood degli anni Venti, quando ancora la città del cinema si chiamava Hollywoodland, le ciglia sono cariche di mascara, sempre nero, il volto, il suo bel viso, è imbiancato da mimo e il rossetto è sbavato, il labbro superiore lo colora in maniera differente da quello inferiore, le tonalità sono il rosso fragola e l’albicocca – per questo Avril le canta sempre “Rebel Rebel” che dice anche: “You’ve got your mother in a whirl. She’s not sure if you’re a boy or a girl. Hey babe, your hair’s alright. Hey babe, let’s go out tonight… Oh, your face is a mess!” Poi le ripetevano che era una troietta lesbica e nel ricco palazzo dove abitava tutti parlavano male di lei e aveva anche difficoltà a leggere, non riusciva a tenere le righe, le saltava, la pagina diventava incomprensibile e a scuola erano convinti che fosse dislessica, la dislessia allora le era passata anche al linguaggio parlato, sì una cosa del tipo, il logopedista non poté fare molto, pure per colpa di quell’apparecchietto sui denti – tutte le borghesi, prima o poi, si mettono la macchinetta ai denti – (macchinetta che Avril, tra parentesi, non aveva mai portato, perché lei era una figlia del proletariato, non ne avrebbe comunque avuto bisogno, guardate che bei denti!). La torturavano a casa, a Louise, perché andava male a scuola, perché la trovavano a baciarsi vicino all’ascensore con qualche altra ragazza, la mano infilata negli slip dell’amante di turno, e allora, col suo trucco da “faccia incasinata”, che invece Avril ama tantissimo, “Ehi, calda puttanella, mi piaci come sei”, i suoi abiti in stile dark cabaret (quando danza indossa un tutù nero, ormai strappato in più punti, culotte e reggiseno di pizzo rossi e una camicia aperta merlettata bianca o una giacca oppure un giubbotto neri, o anche una maglietta, in questo caso niente reggiseno: tanto ha il seno molto piccolo, le sue magliette preferite sono quella con la croce degli Indochine e quella con la Madonna con le pistole degli Spiritual Front), Louise un giorno se n’è andata. Meglio così, sembra abbia detto suo padre, che si vergognava sempre più di lei. La madre ha taciuto. Dopo tante urla e insulti, quel giorno non ha pronunciato una parola. Avril a volte le dice «chi te l’ha fatto fare, avessi avuto io una famiglia come la tua, cioè, i loro soldi e quella casa». Un pomeriggio Louise l’aveva portata a vederla, da sotto, ovviamente, be’ era quella che si dice un’abitazione di lusso, con i balconi in pietra antica tutti decorati fine Ottocento, o giù di lì, le grandi finestre alte almeno otto metri con le tende di seta e in pieno 8e arrondissement, sugli Champs-Élysées, non so se avete presente, dove anche i poliziotti sono più gentili. Ormai non sono neanche più poliziotti quanto addetti alla sicurezza dei residenti. Ma Louise quella casa la odiava, preferisce la stanzetta che si è trovata non lontana dalla chiesa di Santa Giovanna d’Arco – che, per essere precisi, si chiama Notre-Dame de la Gare, e, dunque, con Giovanna d’Arco non c’entra niente, ma per lei e Avril è lo stesso la chiesa della santa combattente: la piazza le dà il nome, punto. Potrebbero spostarsi a Place des Pyramides, dove c’è realmente un’opera a lei dedicata: il monumento equestre in bronzo dorato alla santa che ha dato il colore a un pezzo della bandiera nazionale e che considerano la loro protettrice (l’avevano eletta a loro protettrice dopo aver visto uno spettacolo teatrale al Rond-Point, a due passi da dove abitava Louise: era una storia moderna di omicidi compiuti da una donna che aveva lo stesso nome della santa e si sentiva, in qualche modo, incaricata dal Re del Cielo a compiere giustizia contro uomini cattivi, prepotenti e assassini. L’attrice in scena portava sempre una pistola nella fondina ed era spesso nuda. Avril e Louise si baciarono per la prima volta proprio sulle poltrone di quel teatro, guardando l’attrice recitare nuda con il revolver nella fondina sotto l’ascella. Mentre si baciavano, l’attrice diceva: “Io sono un angelo con le ali imbrattate di sangue che vola contro il cielo a velocità supersonica. Nessun sole potrà mai bruciarmi. Il sole non esiste più. Oscurato dagli elicotteri e dal soffitto di questo appartamento”. Pensarono che baciarsi su quel periodo pieno di violenza, passione e orgoglio fosse bellissimo. Tornarono a vedere lo spettacolo tre volte – riuscivano a intrufolarsi nella sala sempre senza pagare. La terza volta, mentre l’attrice recitava la parte della pièce segnata da quelle parole che davano loro i brividi, proprio in quell’emozionante momento, si masturbarono a vicenda nell’elegante bagno del teatro al 2bis di Avenue Franklin D. Roosevelt, con la voce della protagonista del dramma che si confondeva lontana ai loro sospiri vicini e al rumore delle dita che sfregavano nei rispettivi sessi. Louise leccò la fica di Avril facendola mettere seduta sul lavandino e, inginocchiata tra le sue gambe spalancate, trovò che quell’azione fosse una preghiera. Dal buon odore. Dal buon sapore. Piena di luce e di grazia. Una preghiera dolcissima nello spazio infinito del bagno di un teatro sospeso tra la strada e il cielo. Giovanna d’Arco era diventata la loro santa dell’amore e della sopravvivenza, per tutto il tempo dell’eternità. Amen. Uscite dal teatro, Avril rubò, nel bookshop adiacente al foyer, due libri: uno sulla Societas Raffaello Sanzio di Romeo Castellucci e un altro sui Motus di Daniela Nicolò e Enrico Casagrande). Certo, potrebbero esibirsi sotto quella grande statua, qualche volta c’hanno anche pensato, ma si trova nel 1er arrondissement, troppo vicino al quartiere da cui Louise è fuggita senza rimpianti. È un monolocale privo di acqua calda e riscaldamento, quello in cui vive nel 13e arrondissement, non c’è neppure l’angolo cottura, così Louise deve cucinarsi con un fornellino elettrico e un microonde, però là nessuno la prende in giro. Qualche volta va a dormire da Avril, allora fanno l’amore, ma stasera vuole starsene da sola, poi c’è poco spazio da Avril (come da lei, d’altronde) e deve dormire sul pavimento – sempre però tenendo una mano sul piede nudo che la sua amante lascia penzolare giù. Può farlo ogni tanto ma, per una ballerina, non fa bene. Avril le offre di dormire sul suo letto, lei si sarebbe arrangiata a terra, ma Louise rifiuta sempre, «Non ci pensare neanche» le dice. Una volta che hanno dormito attaccate sul divano-letto, la mattina dopo erano tutto un dolore. Avril avrebbe voglia di fare l’amore stanotte con la sua amica, sentire il suo corpo muscoloso e caldo, il suo alito, i suoi odori di piacere e sudore, ma fa niente: come abbiamo detto, le piace pure masturbarsi, e, quando riesce a non pensare al suo ex ragazzo, quando riesce a non pensare a nessuno, a parte le immagini lievi e sfuggenti di Louise e dei suoi piedi scalzi che danzano, viene anche meglio ed è più contenta. Questa volta sarà una di quelle?] Due dita strofinano la clitoride, penetrano a fondo nella vagina fradicia, palpita. Eiacula languida, qualche schizzo. Si addormenta piano. Quieta.
Avril apre il libro seduta nuda sul divano che le fa da letto. «Cc… rash!» dice e ride anche lei. Il lenzuolo che le sfiora l’ano è piacevole, le dà un senso di completo abbandono, di essere indifesa, ma non in pericolo, nella sua solitaria libera nudità, Avril è al sicuro. Una tenera sensazione d’intimità con se stessa.
Il fiore blu, bianco e rosso stavolta è per lei. Avril sorride quando lo vede comparire tra i lacci aperti dei suoi anfibi. Gilbert le dà un piccolo bacio sulle labbra, Avril sbatte le ciglia come un’attrice del cinema muto e ricambia il bacio, carezzando con la sua lingua quella del prestigiatore, mentre qualcuno le lascia una moneta nel bicchiere. Avril fa un inchino.
Poi comincia a piovere, senza preavviso, allora prende in fretta i soldi e si mette a correre con la chitarra sulla schiena verso le tettoie dei negozi dei palazzi di fronte alla chiesa. Louise la segue.
«Che c’hai, tesoro?» Louise non risponde, si toglie le scarpette, se le mette sotto la maglietta e si allontana da quel riparo correndo nella pioggia sempre più forte. Avril scrolla le spalle e inizia a contare i soldi.
«Aspetta, Louise, la tua parte», le urla dietro.
Comincia a correre anche lei sotto l’acqua.
Con tutta quella pioggia, il fiore si è scolorito. Avril lo osserva sul divano-letto davanti ai suoi piedi nudi e bagnati. Se lo infila tra le dita, mentre guarda fuori della finestra il tramonto grigio e maltrattato dal temporale sopra la città. Non è neanche un tramonto: solo un malinconico cambio di luce. Si lascia andare giù e fissa il soffitto con le ombre dei palazzi e la sua. Tira su il piede col fiore e lo ruota sulla caviglia. Una lacrima le scende sulla guancia e le va a finire in bocca. Lascia andare giù il piede. Il fiore si sfila dalle dita. Con un debole calcio lo butta a terra.
A volte a Avril capita di svegliarsi di cattivo umore, sempre quando piove, quando piove forte, intendiamo, allora se ne sta a casa: che ci va a fare in piazza con tutta quell’acqua? Come fa a suonare? Come potrebbe Louise danzare. Se poi anche potesse suonare, se Louise riuscisse a danzare, mettiamo che fosse possibile, qualcuno forse si fermerebbe a dare loro qualcosa? Ma andiamo! Meglio starsene lì a leggere, mangiare i biscotti e a masturbarsi. Poi a suonare qualcosa soltanto per sé. O viceversa. Accenna “Gabriel” dei Lamb, le piace la cantante, Lou Rhodes, le piace il suo sguardo leggermente strabico. Quindi passa a “Creep” dei Radiohead. Le piace pure Thom Yorke, anche di lui le piace il suo occhio deviato, e le piacciono, di quella canzone, soprattutto le schitarrate elettriche che le danno un fremito ogni volta che le esegue, anche con la chitarra acustica. Nei momenti più tristi accenna “No Surprises”. La sa suonare e cantare molto bene. Una volta vide uno spettacolo teatrale in cui questo brano faceva da sottofondo a un monologo. Ricordava il nome della compagnia, si chiamava Le Soldat Perdu (lesse sul programma di sala che quel nome era stato preso da una scena del film “Apocalypse Now Redux” di Francis Ford Coppola), ma non ricordava il titolo della pièce né dove l’aveva vista. Forse era ancora al Rond-Point. Sì, doveva essere lì. Ricordava però bene quello che recitava l’attrice, non a memoria, ma diceva una cosa del genere: “Mi mancano le lacrime, sai. Erano lacrime buone. Era sciogliersi in qualcosa di forte, intenso. Tutto ciò che era stato intrappolato nei giorni precedenti, ora si liberava, lì. Gli facevo sentire la musica e lui l’aveva fatta sentire a me. Gli tiravo indietro i capelli, ero alle sue spalle. Poi giù, il resto del corpo. Lo sentii fortissimo quando lo portai sul mio seno. Ne ebbi quasi paura. Paura di quello che provavo. Perché era commovente. Le lacrime sarebbero arrivate presto. E sapevo che non potevo fare niente per fermarle. Ma neanche lo volevo. Volevo quel pianto. Superando la paura. Quando lui mi toccava, mi diceva Sono qui, la senti la musica? Sì, la sento. E tu la mia? Segui il mio corpo come io farò con il tuo. Gli feci sentire la mia musica tenendo le lacrime a stento. Non temere, sono qui. Quando riaprirai gli occhi, io sarò ancora qui. Adesso lasciati andare alla musica, perché mi troverai qui, davanti a te. Fu quando lui mi fissò che cominciai a piangere. Fu irrefrenabile. Finalmente piangevo. Non volevo altro che quel pianto. In quell’istante, in quel preciso momento. Tutto, proprio tutto, era in quel momento”. Un pomeriggio recitò questo monologo a Louise accompagnandosi con la chitarra. Louise a un certo punto cominciò a piangere. Aspettarono il tramonto poggiate una sull’altra, senza parlare. Solo baci ogni tanto. E le carezze di Avril sul corpo nudo di Louise come a dirle: «E tu la senti la musica? La mia musica?» Avril si masturba strofinandosi il manico della chitarra sulla clitoride, tra i peli. Ha i peli neri. Quelli di Louise sono castano chiaro virati al biondo. Dischiude le labbra, il legno si inumidisce, quindi si bagna. L’unica cosa che le è rimasta del suo ex ragazzo è quella chitarra. A parte i ricordi, ma va be’ (il cambio, è inutile, non lo trova più, e poi non era neanche quello della macchina accidentata dove avevano scopato). Ma quando piove non vuole masturbarsi pensando a lui. Quando piove lui è cancellato, non è mai esistito. Quando piove vorrebbe solo Louise. Pure col broncio, ma lei. «Sono qui, la senti la musica? La mia musica? Non temere, quando riaprirai gli occhi mi troverai qui, accanto a te. Ora lasciati andare alla musica».
Ha finito di venire, per la terza o quarta volta, i suoi umori sono anche sulle corde. Il suo piacere è cessato come è cessata la pioggia. «Basto io» si dice, scoppia a ridere. «Che scema!» Ride con le lacrime. Siamo sicuri che stia ridendo? Guardatela bene.
«Tieni, li ho lasciati qui, sulla sedia». Louise neanche li guarda i soldi che le porta il padre ogni tanto. Fino a che lui è lì, non li guarda mai.
«E metti un po’ d’ordine, qua dentro! Come fai a viverci? È un buco sporco e disordinato: fa schifo e puzza!»
«Sssì ffa ssempre tu… ttutto sschi… fo per te cciò ccch… e mi rigg… guarda e ripp… prenditi i tuoi sssoldi, no… non lli vvo.. gli… glio, e cchi ti ha de… de… tto di vvenire».
«Fai come ti pare, Louise» dice lui, mentre se ne va dal piccolo appartamento senza salutarla. Louise non lo guarda uscire. Resta a lungo seduta sul letto, la testa bassa, si stuzzica un piede nudo, quindi si alza, prende i soldi, li conta e le viene da piangere, ma si trattiene.
«Sss… tronzo!» dice. «Grazz… zie» sussurra.
Ora tocca a Sylvia Plath. Il libro che raccoglie la sua opera omnia è bellissimo: rilegato, con custodia, edizioni Gallimard (dico: edizioni Gallimard, non so se mi spiego). Aveva già preso in passato un suo volume, “Ariel”, ma questo è inarrivabile. Il solito giochetto, et voilà, il libro è suo. Per sempre. All’esterno dalla libreria, un vago sole è uscito tra le nuvole.
«Guarda… e guarda, Louise!» Avril mostra il libro di Sylvia Plath alla sua amica, lei gli lancia appena un’occhiata e si volta dall’altra parte.
«Perché ce l’hai con me, eh?» Louise non le risponde e si allontana, mentre Avril riprende a suonare, dopo aver rimesso il prezioso volume nella borsa.
La pioggia, tornata a scendere, è prima indecisa, quindi diventa fitta e sicura, implacabile al punto di non risparmiare niente e nessuno, neanche Sylvia Plath. Louise si toglie le scarpette e, per correre a ripararsi, scivola sull’acciottolato della piazza, Avril fa per aiutarla a rialzarsi, ma lei le toglie la mano stizzita, si rialza e fugge via in direzione di Rue Jeanne d’Arc. Non si ferma sotto la tettoia del parrucchiere o del fioraio sulla piazza, né sotto quella dell’ufficio postale o di un negozio a Rue Lahire. Corre verso casa. Avril resta per qualche secondo immobile a prendersi tutta quell’acqua guardandola nella sua corsa, poi si mette a correre pure lei. Il respiro affannato è nebbia solcata dalla pioggia. Gilbert ha materializzato un ombrello, si apre in un attimo come se fiorisse. «Ehi ragazze…», gli urla, ormai però le sue colleghe sono lontane e fradicie. Inutile corrergli dietro.
Arrivata a casa, Avril si leva i vestiti bagnati, si asciuga senza tanta cura col lenzuolo, lo lascia, scurito della pioggia sulla sua pelle, in fondo al divano-letto e si poggia seduta sul cuscino che le finisce di asciugare il sedere morbido e un po’ il sesso con la peluria umida.
Apre la borsa tra le gambe, accorgendosi solo adesso che il libro di Sylvia Plath si è bagnato tutto. «Nooo!» Prova ad asciugarlo, ma è inutile, la carta è piena di macchie, inzuppata e ondulata e pure la copertina e la sovraccoperta e la custodia di cartone è quasi macerata: un disastro. «Noo, cazzo! No! No!» Avril non ce la fa a trattenere le lacrime e si lascia andare con la schiena alla parete fredda piangendo come non le succedeva da tempo. Singhiozza.
«Perché non vuoi parlarmi, eh?»
Louise non risponde e si scosta da Avril.
«Io lo so perché non mi parli».
Louise continua a non dire niente allontanandosi ancora di più dalla sua amica, che le si avvicina di nuovo.
«Se è per quel bacio di Gilbert dell’altro giorno, be’, allora sei proprio tutta scema».
Louise scuote le spalle.
«Ma no, non è per quello, lo so, figurati».
«Llassc..iami stare, Avril!» Louise la fissa con rabbia e le volta la schiena.
«Ma sì che ti lascio stare… non è per niente divertente ascoltarti parlare… tu non mi parli perché balbetti, balbetti sempre di più, ecco perché, per quello stupido apparecchio che ti rende cattiva e brutta. Sei invidiosa di me».
Louise si gira di scatto verso Avril, ha gli occhi pieni di lacrime, si sfila le scarpette da punta con gesti violenti e le mani che le tremano.
«Pppuuoi… rri… riprr… enderte… le le tue sstupi… de scarrppette… non lle voglio, ppper qquanto le hai ppa… ppagate! laa… dra… sei ssolo una lla…dra e una pezz… zente!» le dice, le butta le scarpette addosso e se ne va via di corsa a piedi nudi continuando a piangere.
«Aspetta, Louise!»
Avril s’inchina a raccogliere le sue scarpe.
«Aspetta, dai».
«Scusami, non mi ricordo più le parole».
«Non preoccuparti, anch’io a volte le dimentico».
«E come fai?»
«Le invento».
«Ti ho visto a teatro, sai? Ma quelle non erano inventate».
«Anch’io ti ho vista cantare».
«Sì, me ne sono accorta. Giorni fa. Ma non ti sei avvicinato. Perché?»
«Non lo so».
«Non dovevi mica per forza lasciarmi un’offerta. Mi avrebbe fatto piacere cantare un pezzo per te. Questo pezzo. E invece oggi non ne ricordo le parole. Volevo prendere il tuo libro al bookshop del Rond-Point, dopo lo spettacolo, però non c’era. Lì c’erano tutte le tue parole. Dovrei scrivermele, le parole di certe canzoni. Così potrei leggerle. Come fai tu nei tuoi reading».
«Era una canzone di Nick Cave, ho riconosciuto la musica».
«Be’, certo che l’hai riconosciuta, era in quel tuo spettacolo. Era nel monologo finale di lei. Per questo volevo cantartela. Ma mi dispiace, non me le ricordo proprio le parole. La musica sì, ma il testo, niente da fare».
«Oh, non lo ricordo neanch’io. Non ricordo neppure quello che diceva lei».
«Non è vero. Lo ricordi benissimo. Certe cose non si dimenticano».
«Già, la volevi cantare per me… e per chi ami, vero?»
«Sì, come hai fatto tu con la tua scrittura, no? Ma lei se ne è andata. Comunque dai, è inutile, non mi ricordo le parole. Poi mi sa che tra un po’ tornerà a piovere».
«Meglio muoverci».
«Sì, meglio andare. Mi lasci qualcosa? E magari anche qualche parola di quella canzone. O di quel monologo. Lo so che te le ricordi».
I piedi sporchi della strada: Avril non fa che pensare ai piedi della sua amica sporchi sotto la pianta, tenendo le scarpette strette tra le mani, col loro umido odore di danza. Il libro di Sylvia Plath sul lenzuolo vicino alle cosce nude. Rovinato da quella maledetta pioggia. Il mondo è lacerato dalla pioggia.
Deve riaverlo: deve riaverlo nuovo, non così macchiato, non con le pagine dure come quei giorni. Deve riaverlo, con le pagine bianche e lisce. Avril si avvicina al volume esposto sullo scaffale della libreria. Lo toglie dalla custodia e comincia a sfogliarlo guardando furtiva la commessa. Oggi la commessa ha un tailleur elegantissimo e firmato, di certo firmato da qualche stilista mafioso; un profumo da far girare la testa. Lei l’unico profumo buono che può permettersi è quello che si spruzza sui polsi ai grandi magazzini facendo finta di provarlo. A volte dietro le orecchie. Rubare quelle boccette è impossibile: il reparto dei cosmetici è pieno di commesse, quelle alla cassa non si distraggono mai, ed è controllatissimo da energumeni in abito grigio e spalle larghe due metri. Le sue fragranze preferite sono Jean-Paul Gaultier Classique, con la bottiglia rosa a forma di un busto femminile in guêpière confezionata in un barattolo di latta, e Kenzo Flower (la bottiglietta di Kenzo Flower sembra fatta apposta per masturbarsi, curvata al punto giusto, col fiore di papavero sul tappo e lo stelo lungo il flacone; per via del tappo dovrebbe fare un po’ di attenzione, ma sarebbe un peccato toglierlo). Il profumo della ragazza l’aveva sentito appena le era passata vicino.
Come al solito, la commessa si gira dalla cassa dopo aver dato il resto a un cliente. Anzi, aspetta, questa volta se ne va proprio lasciando la postazione incustodita. Non torna. Meglio, sarà più facile. Avril si avvicina e passa il libro sulla macchinetta, il raggio rosso e nessun suono. Lo lascia cadere nella borsa. Fa per uscire, tutto bene. Le antenne restano mute. Cieche. La porta a vetri si apre, ma non fa in tempo ad accennare un sorriso e a sentire l’aria di fuori che una mano forte e senza riguardo la ferma.
«Apra la borsa, signorina».
Avril si volta. L’addetto alla sicurezza le ripete di aprire la borsa. «Apra la borsa». Vicino a lui, la commessa, l’abito è firmato, forse è di una coppia di stilisti italiani, ridicoli e antipatici, il suo profumo è buonissimo, il suo sguardo sotto gli occhiali di marca, stavolta dovrebbero essere Armani, è tranquillo. Anche l’addetto alla sorveglianza è tranquillo, con fermezza strappa la borsa dalla mano di Avril, che non riesce a trattenerla perché all’improvviso si sente indebolita e incapace di qualsiasi reazione, non riesce a dire niente, non riesce più a parlare, la bocca è secca, nessuna parola, solo la testa le dice un sacco di cose, le dice che vuole molto bene a Louise, che la ama più di ogni cosa e che deve trovare il coraggio di dirglielo, le dice che è carina quando parla balbettando, le dice che il profumo della commessa è proprio buonissimo, floreale e fruttato, le dice che Louise era bella e struggente quando scappava via dalle sue offese a piedi nudi, le dice che le dispiace tanto, «mi dispiace, Louise, credimi, mi dispiace, non le pensavo quelle brutte cose, scusa», le dice che non è vero, che non può accadere questo, le dice che amava il suo ragazzo e lui se n’è andato, le dice che il profumo è troppo buono e la commessa è così elegante e si chiama come la sua amica, lo legge sul cartellino, Louise, le dice che invece lei puzza di sudore e i suoi abiti sono di poco valore, le dice che lei è sporca e non vuole stare lì, le dice che vuole essere, in questo momento, a casa sua col latte, l’Ovomaltine e i biscotti allo yogurt e poi a masturbarsi, oppure, meglio, a fare l’amore con Louise, deve dirle che la ama, «ti amo, Louise, ti amo tanto, come non ho mai amato nessuno», e poi avrebbero dormito vicino, per una volta si può anche fare, pure se lei è una ballerina e non fa bene a una ballerina, soprattutto alla sua schiena, è bellissima la schiena dritta, ampia e muscolosa di Louise, meravigliosi i suoi glutei duri e perfetti. E adesso non le dice più niente, quando la guardia giurata in borghese le tira fuori il libro dalla borsa e la conduce, tenendola per un braccio, stringendo forte, nell’ufficio sulla sinistra della libreria, con la porta rossa di plastica e dall’arredamento minimale e moderno. Entrano solo loro due, la commessa è tornata al proprio posto, l’ufficio è vuoto, non c’è il direttore, un impiegato, nessuno. L’addetto alla sicurezza le fa capire, senza tante parole, che potrebbe non denunciarla, potrebbe non chiamare il direttore né la polizia, potrebbe essere buono con lei: Avril puzza di sudore, è sporca, a stare sempre per strada ci si sporca, ma è pure molto carina, lo sappiamo e l’ha notato anche il tipo della sorveglianza.
L’ufficio diventa gelido sul suo sedere scoperto dalle mutande abbassate. C’è tutta la disperazione del mondo in quel freddo. La disperazione è il freddo. L’infelicità è il freddo.
Avril cerca di sistemare le pagine del libro di Sylvia Plath, seduta sul suo divano-letto, il lenzuolo ai suoi piedi: cerca di sistemarle stendendole con la mano. Fatica sprecata: sono rovinate per sempre.
Louise, dopo essersi lavata e rivestita con abiti puliti e costosi, entra nel salone. Era da tanto che non si vestiva così, da tanto che non vedeva quella casa. Le sembra ancora più grande di quando l’aveva lasciata. Le pareti sono di dieci metri di altezza. Più spaziosa, più elegante. Più accogliente. Più estranea. Più fredda. Più insopportabile. Su una parete c’è un quadro di grande valore di un pittore che fece la fame in vita. Suo padre le dà un bacio sulla fronte.
«Non stai meglio pulita e vestita come si deve?»
Louise non dice niente e guarda dalla finestra il viale con gli alberi e i negozi pieni di griffe. Pensa a Avril.
Che si asciuga il viso col lenzuolo e morde un biscotto. Non le va proprio giù. Lo lascia umido di saliva e lacrime tra le briciole sul letto. Guarda dalla finestra la città colorarsi del tramonto che filtra tra le nuvole ferrose.
Sussurra “No Surprises” dei Radiohead che dice: “This is my final fit. My final bellyache. With no alarms and no surprises. No alarms and no surprises”.
Vista dall’ultimo piano, seduta sul davanzale della finestra, la città le ricorda un film di Wenders. Solo senza angeli. “No alarms and no surprises, please”. Avril oscilla.
[1] Pubblicato su “Verde” del 25 settembre 2017.
Andò così: estate 2011, leggemmo questo libro (aggiungetelo alla lista) e ne rimanemmo folgorati. Un anno dopo nacque Verde e pensammo subito che avremmo voluto che Sergio Gilles Lacavalla si unisse a noi. Così fu, già nel numero 1 con Escuadron de la muerte, e poi dal 2al5 con Rock Criminal, la rubrica che dopo una lunga pausa è tornata sulle nostre pagine due anni fa. Da allora Sergio ha raccontato, senza mai saltare un mese, tutte o quasi le storie più nere del rock e dintorni, con l’obiettivo, sempre raggiunto, di non ripetersi mai. Per questo siamo convinti che sia il momento giusto (siamo a settembre, ecc ecc) per fermarsi e ricominciare. Da ottobre ci sarà una nuova rubrica che allargherà il campo delle storie criminali e che si alternerà agli atti unici e ai racconti di Sergio che leggeremo…
View original post 6.893 altre parole
American dream[1]
Al 45 della 139th Strada Ovest, il sangue non si asciuga mai. Scorre fino all’incrocio del Lenox Avenue ed entra nel parco giochi Fred Samuel tra la West 139th e la West 140th Street, imbratta gli scivoli, le altalene e il campo da basket, ragazzi senza le scarpe giuste ma con mani grandi sognano la NBA, le aree dove si fanno le competizioni di freestyle, con certi adolescenti dagli abiti larghi che sono già dei fenomeni, e in un’onda è ancora sui marciapiedi e nella via di transito delle macchine, “il battito cardiaco di Harlem”, come è soprannominata la grande strada a doppio senso di marcia che costeggia l’isolato, è illuminato dalle sirene delle pattuglie della polizia e dagli elicotteri, i passi concitati di chi fugge, attutiti dalle aiuole intorno ai palazzi di sedici piani e mattoni rossi del complesso residenziale del Savoy Park, li segue per le scale, e di nuovo giù, verso la metropolitana, qualche stazione, poi si torna indietro, è inevitabile, è un richiamo, è il tuo territorio, il sangue continua a spandersi per finire ad assorbirsi sotto l’asfalto di Central Harlem, dove ristagna, con il suo odore persistente; si assorbe ma non si asciuga. È un monito. Un debito da pagare prima o poi. Il sangue sta lì e aspetta di rigurgitare. Sempre nello stesso punto. La 139th che incrocia il Malcolm X Boulevard delimita quella che è chiamata “la zona pericolosa”, “dove nessuno può resistere” a lungo. Meglio sarebbe chiamarla, “la zona della morte”. Il sangue ha memoria. In due fratelli tra i fratelli afroamericani e di malavita, scorre lo stesso sangue. È la loro memoria indelebile. Del loro assassino, macchia ogni azione, fino a quando, quel sangue maledetto, non lo uccide. Si apre un buco in testa e si svuota il cranio. Il sangue torna a inzuppare il suolo. Si infiltra nel terreno, forma dei grumi con la sporcizia, intasa le fognature di un angolo di scarico di New York, si diluisce mischiandosi all’acqua e ad altro sangue che fluisce. Sul Lenox Avenue. E tornerà a ripetere il ciclo, statene certi. Continuando a non asciugarsi mai e poi mai. È la solita storia di faide su una colonna sonora di musica rap. “Scoppia il cervello degli assalitori […] Facciamo questi soldi, è il sogno americano. Dalla East Coast alla West Coast, sai cosa intendo, che si tratti di Uptown o Downtown”. Che si tratti del sangue chiuso dietro le sbarre di una prigione, una delle tappe obbligate prima della fossa. O che si tratti proprio del tuo, quello ancora in libertà. In ogni caso sangue continuamente alimentato a crack e soldi sporchi. Basterebbe attendere. Ma sai cosa intendo, devi pagare i tuoi debiti e subito. Tu non puoi? Bene, per ora mi basta lo stesso sangue in diversa carne, è colpevole anche lui. O forse sei proprio tu. In ogni caso, bang! bang! bang! … Per nove volte. Una macchina arriva, rallenta, si affianca e sei morto. Il sangue è una pioggia rossa, schizza ovunque, sui cancelli, sugli alberi, sulle automobili parcheggiate, sembra arrivi fino ai piani alti degli edifici, fino al cielo, che per un istante si fa scarlatto, come la luna, quindi diventa un lago non appena cadi a terra. È un tonfo che pare fare più rumore dei colpi di pistola esplosi. Gran parte dei proiettili sono alla testa. Un paio al torace. Buona mira anche in movimento. Poi l’automobile accelera e scompare lungo il Malcolm X Blvd. Lamont Coleman, in arte Big L, la stella nascente del rap della East Coast, il gelido 15 febbraio del 1999 è lì, sulla strada a nutrire l’asfalto del 45 della West 139th Street. Circondato dal proprio sangue e dai cioccolatini che aveva comprato per San Valentino – con un giorno di ritardo, perché si sa, gli affari tolgono tempo e attenzioni agli affetti – come dolce regalo al suo più grande amore: sua madre, che abitava a due passi di distanza. Cioccolatini e sangue. Tutti dissero che quel sangue versato non avrebbe dovuto essere il suo. Non aveva mai fatto male a nessuno, ripetevano increduli gli abitanti del quartiere, malgrado facesse rime, le migliori del circondario, su stupefacenti, troie, Glock e morte, Big L non era un delinquente. Big L era buono. Un piccolo rapper, a dispetto del nome (ma quel nome era ironia sul suo fisico mingherlino), senza precedenti penali. “Lifestylez ov da Poor & Dangerous”, il suo unico album uscito in vita, era un capolavoro horrorcore e gangsta rap, quasi un documentario su esperienze di strada. Le più estreme. Le più allucinate. E allo stesso modo apparivano tutte quelle canzoni pubblicate postume, tantissimi fotogrammi sul vivere più marcio e pericoloso. “Big L è un tossico del denaro […] ho incastrato la mia pistola nel suo cervello, così quell’idiota è stato ammazzato”, cantava. Era per darsi un’aria da duro e sopravvivere in quell’inferno, dicevano i più smaliziati, quelli con qualche cicatrice da pallottole a segnare il corpo come medaglie del crimine. Altro che tatuaggi. Ma non c’è niente da fare quando in circolo hai il sangue di chi è nato e cresciuto nella “danger zone”. Quando le tue canzoni sono più forti della tua realtà e si sostituiscono a essa. Sostenevano tutti. Quel bravo ragazzo, che c’entrava? C’è però il tuo sangue in un carcere federale, non scordarlo. Scorre nelle vene e nelle azioni che hanno portato tuo fratello a scontare una condanna per rapina e spaccio di stupefacenti. Dovevi saperlo che quel fratello maggiore e scriteriato ti avrebbe messo in mezzo ai guai: che il suo sangue avrebbe fottuto il tuo. Certo, Leroy Phinazee, questo è il suo nome, ha solo metà del sangue di Big L, essendo figlio del primo marito della madre di entrambi, Gilda Terry (c’è anche un terzo fratello, Donald), ma basta e avanza per condannare a morte un innocente. Perché nessuno è innocente sul Lenox Avenue. Forse neanche Big L. Forse anche lui ha fatto parte del giro di spaccio del fratello. Forse anche lui ha fatto uno sgarro a degli spacciatori derubandoli dei soldi guadagnati dalla vendita di un carico di droga. Probabilmente era solo colui che aveva detto a suo fratello e al suo complice quando e dove sarebbe stata compiuta la trattativa, effettuata da alcuni suoi amici che mai avrebbero sospettato di lui. Non ci vuole niente, i soldi sono lì, passano da una mano all’altra, come la droga, e sono tanti. Basta individuare il momento giusto. Eccolo. Le ipotesi su come siano andate le cose adesso prendono due direzioni contrastanti. Leroy Phinazee è in carcere con Gerard Woodley, amico di famiglia e d’infanzia dei fratelli (compariva anche fotografato sul retro della copertina di “Lifestylez ov da Poor & Dangerous”), un tipaccio con vari arresti e detenzioni alle spalle nonché complice dei loro traffici (sempre ipotizzando che Big L ne facesse parte). In prigione deve essere successo qualcosa, forse il fratello di Big L non vuole dargli quello che gli spetta del furto, quanto pattuito, erano d’accordo, ma io ti ammazzo, hai capito, ti ammazzo, sì, sembra sia andata proprio così. Anche perché è lui, Leroy, quello condannato a stare dentro altri tre anni, mica Woodley che, accusato per gli stessi reati in associazione con Phinazee, viene scarcerato poiché non ci sono prove a suo carico. Neanche Big L gli darà un centesimo, può starne certo, e poi l’esile rapper nell’affare ha avuto un compito marginale. Magari neanche sa dove stanno nascosti i soldi. Leroy Phinazee è avido, non gliene frega niente di nessuno. Nemmeno del sangue del suo sangue. Pieno di rancore e in credito, Gerard Woodley vorrebbe ammazzarlo a Leroy Phinazee, ma non può aspettare che esca. Lì nessuno può attendere: non sai se ci sarai ancora il giorno dopo a passeggiare sul Lenox Avenue. Te la devi godere subito. Basta il piccolo fratello, ma sì, invece anche lui ha fatto la sua bella parte. Altroché. E ogni giorno che passa quel ruolo nel colpo gli appare più grande. Già, i due fratelli sono d’accordo sul non dargli i suoi sacrosanti soldi. Giorno dopo giorno le due figure si sovrappongono. Ora i due fratelli sono la stessa persona, che gira tranquilla per Harlem. Gerard vuole fargliela pagare a quegli stronzi che lo hanno fregato, a lui, il loro amico da quando erano bambini, quante ne avevano fatte insieme, amico soprattutto del rapper che si fa chiamare Big L ed è un microbo che si sta arricchendo mentre lui non sa dove sbattere la testa per alzare un po’ di dollari, come sarebbe giusto, e che diamine! Pensa che ucciderà quel piccolo grande MC che per il momento è anche suo fratello. Lo farà. Non pensa ad altro. Ha deciso. Poi si vedrà. Quando, tre mesi dopo, la polizia lo va a prendere per riportarlo in carcere accusato dell’omicidio del ventiquattrenne Lamont Coleman, Gerard Woodley si dichiara innocente. Nessuna prova contro di lui. Nessun testimone. Ci risiamo. Presto viene rilasciato. Il procuratore distrettuale di Manhattan, pur essendo convinto della sua colpevolezza, non può fare altrimenti. Per molti del quartiere lui non c’entra niente con quella brutta faccenda e l’arresto si è dimostrato subito l’errore che era: Big L portava gli stessi gioielli di Leroy ai polsi e al collo, gli somigliava, e qualcuno, mai identificato, qualcuno degli spacciatori a cui i due fratelli avevano fatto il torto irreparabile, qualcuno che aveva capito, ma che pensava che il furto fosse opera solo di Leroy, e non sapeva che questi fosse in prigione, nel buio della sera invernale, tra le ombre degli alti palazzi, illuminato fino ad accecarsi da tutto quell’oro, deve averlo scambiato per il suo obiettivo. Un regolamento di conti sull’uomo sbagliato. Oppure su quello giusto, perché gli spacciatori non c’avevano messo molto a realizzare che il giovane rapper loro amico era un traditore. Succede nella “zona del pericolo”. Non ti puoi fidare di nessuno. E mica sono tutti scemi. Anzi. C’è bisogno di sangue e in fretta per tenere fertile il terreno dei fiori del male. La notizia della morte di Big L sconvolge Leroy e fa guadagnare cifre mai viste prima all’altro fratello, che nel giro di qualche anno, in collaborazione con il manager dell’artista, Rich King, pubblica ogni inedito possibile in quattro album. Nel 2002, Leroy Phinazee è finalmente fuori dal carcere, ma non fa in tempo a godersi la libertà che viene freddato allo stesso indirizzo in cui trovò la morte Big L: 45 West 139th Street, dove il sangue non si asciuga. È stato ancora l’amico d’infanzia che ha portato a compimento la sua vendetta, con la stessa modalità con la quale aveva già avuto successo? Quel tratto di strada evidentemente gli portava bene e da lì doveva passare il nemico per andare a trovare la mai consolata madre. Sono stati gli spacciatori che non hanno dimenticato? Ci fu chi disse che il fatto che l’omicidio fosse stato perpetrato nello stesso luogo fosse un messaggio degli spacciatori rivolto a chi avesse avuto ancora la sciagurata intenzione di derubarli: quella strada è il posto delle esecuzioni. Il sangue, lì, non si asciuga mai, lo sappiamo. Forse, invece, Leroy e Gerard si erano dati appuntamento nella via vicino al parco davanti al cui ingresso era stato dipinto su un muro il ritratto in memoria di Big L (c’è lui con gli occhiali con le lenti tonde, l’aria seria, una catena con una grande croce d’oro al collo, un diamante al lobo dell’orecchio sinistro e una mano messa a pistola puntata, gli anni di nascita e morte, 1974-1999, e la scritta Big L. Street struck. The Big L story), quel Fred Samuel Playground dove il rapper vinceva le sue prime gare di freestyle, per risolvere la questione una volta per tutte. Faccia a faccia. Vediamo chi ha ragione. Leroy non ha avuto ragione. Come in un duello del vecchio west, non è stato veloce abbastanza. Ma pure Gerard avrà torto. Sempre lì, nella “danger zone”, il 24 giugno del 2016, dopo quattro anni di carcere per traffico d’armi, al 106 West 139th Street sul Lenox Avenue, Gerard Woodley sarà ucciso con un colpo di pistola alla testa. Il sangue si assorbe ma non si asciuga.
[1] Pubblicato su “Verde” del 24 luglio 2017.
 Foglietta, Cocoon
Foglietta, Cocoon
Lamont Coleman, la stella nascente del rap della East Coast, il gelido 15 febbraio del 1999 è lì, sulla strada a nutrire l’asfalto del 45 della West 139th Street. Non aveva mai fatto male a nessuno, ripetevano increduli gli abitanti del quartiere, malgrado facesse rime, le migliori del circondario, su stupefacenti, troie, Glock e morte. Non era un delinquente. Era un piccolo rapper buono, a dispetto del nome. Ma forse nessuno è innocente sul Lenox Avenue, neanche Big L.
VenticinquesimaRock Criminal, la rubrica di Sergio Gilles Lacavalla dedicata alle storie nere del rock e dintorni. L’illustrazione è di Foglietta (Cocoon).
View original post 2.029 altre parole
Il signore della truffa[1]
Cosa non era quell’immenso cartellone a Times Square. Prendeva un intero isolato. Dalla 45th alla 46th Strada di Broadway. Comparso all’improvviso la mattina di domenica 14 giugno del 1970, si ergeva imponente per sessanta piedi d’altezza e duecentosessanta di lunghezza sopra gli Astor-Victoria Theaters e il Museo delle Cere di Ripley. Era costato, tra costruzione e affitto dello spazio, centomila dollari e pubblicizzava, attraverso i primi piani dei tre componenti della band, il terzo disco dei Grand Funk Railroad, “Closer To Home”, in uscita il giorno dopo. Il traffico si bloccava, la gente si fermava e tutti a tenere lo sguardo alzato verso l’insegna che aveva superato per dimensioni e attenzione anche l’enorme display da venticinque piedi per cinquanta frontali e venticinque per venticinque laterali all’angolo sud-est tra la 7th Avenue e la 43th Strada voluto da John Lennon e Yoko Ono per augurare ai newyorkesi il buon Natale del 1969 con lo slogan contro la guerra in Vietnam “War is over! If you want it”. Sul cartellone sotto i ritratti di Mel Schacher, Don Brewer e Mark Farner, invece c’era scritto: “Three faces among the countless who belong to the New Culture setting forth on its final voyage through a dying world… searching to find a way to bring us all closer to home”.
Ah, le manie di grandezza di Terry Knight. Il produttore e manager dei Grand Funk Railroad che aveva messo su quell’operazione. Si disse che in realtà l’appariscente insegna non fosse costata proprio la somma che aveva dichiarato lui alla stampa, ma solo sessantamila dollari, che, comunque, non erano mica uno scherzo (quella di John & Yoko ne era costati venticinquemila). E che l’investimento fosse stato a carico dell’etichetta discografica della band, la Capitol Records. In ogni caso, il merito esclusivo se lo attribuì lui. Il disco, ovviamente, si prese subito le prime posizioni delle classifiche, dischi multioro e riconoscimenti del genere che tanto piacciono all’industria dello spettacolo, e spinse in avanti anche “Survival”, l’album dell’anno successivo. Il cartellone fu rimosso nel novembre del 1970, ma nel 1971 c’erano ancora molti newyorkesi che dicevano di averlo visto, sempre lì, svettante e grandioso sopra il complesso immobiliare di proprietà della Artkraft Strauss Sign Corporation, a ricordare loro la data della band annunciata in città per il 9 luglio. Quando i biglietti furono messi in vendita, bastarono settantadue ore per sparire dai botteghini. File lunghissime giorno e notte. Il concerto si tenne al William A. Shea Municipal Stadium, lo stadio del baseball dei New York Mets che aveva assistito prima di quel giorno glorioso a un solo tutto esaurito per un evento musicale: il 15 agosto del 1965, sessantacinquemila esagitati spettatori si strapparono i capelli e urlarono fino a coprire la musica per i Beatles. I Beatles, però, ci impiegarono due settimane per veder staccati i tagliandi per ogni ordine di posto. Come i Beatles, i Grand Funk Railroad arrivarono allo stadio del Queens da Manhattan in elicottero. Fecero il loro ingresso nella struttura in limousine nera con i vetri oscurati. E furono acclamati, secondo qualcuno, più della formazione di Liverpool in piena beatlemania. Suonando hard rock. Erano la band di maggior successo in America all’inizio degli anni Settanta.
Sotto il grande manifesto di Time Square, per un certo periodo, ci fu un’altra insegna, più piccola, molto più piccola: quella del cinema che aveva in programmazione il film su “Let It Be” dei Beatles. “An intimate experience on film The Beatles Let It Be”, diceva la frase di presentazione.
Terry Knight e i Beatles: ormai a nessuno poteva più sfuggire l’associazione tra loro. L’aveva fatto apposta il produttore americano a far mettere quel cartellone proprio lì. Era l’ultimo atto della personale vendetta su Paul McCartney.
Nel 1968, Knight era a Londra per rilanciarsi dopo i fallimenti come cantante solista e dei Terry Knight and the Pack (con due di loro avrebbe poi formato i Grand Funk Railroad), che comunque avevano aperto per i Rolling Stones a Cleveland, Detroit e Chicago, e lo si poteva incontrare negli studi della neonata Apple Records durante le registrazioni del cosiddetto “White Album” per rimediare un contratto con l’etichetta dei Beatles. Là assistette a delle animate discussioni tra i quattro e all’abbandono di un giorno di Ringo Starr che facevano presagire la fine della band. Lui stesso ebbe un diverbio con Paul McCartney, che non ne voleva sapere di prenderlo nella sua scuderia. Quel burrascoso soggiorno gli servì però per ottenere un contratto con la Capitol Records, distributrice dei Beatles negli USA, e gli suggerì l’idea per il primo singolo a suo nome con l’etichetta statunitense: “Saint Paul”. Terry Knight, ammettiamolo, era un genio della pubblicità e degli intrighi. “Saint Paul” era una canzone che alludeva a una malinconica perdita su citazioni di canzoni dei Beatles come “Strawberry Fields Forever”, “Hey Jude”, “Lucy In The Sky With Diamonds” e “She Loves You”, cantate soprattutto da bambini, e raccontava la delusione del suo rapporto con McCartney. Diceva: “Qualcosa era andato storto. Non potevo ascoltare la tua canzone così triste nell’aria. Mentre loro gridavano fai attenzione […] Hanno detto che ti sei iscritto per pagare oggi […] Lascia che ti porti giù, giù, giù… […] Penso ci sia qualcosa che non va […] Ehi Paul”. Il senso di fine presente in queste parole pare anticipare quella stramba teoria chiamata PID (Paul Is Dead). La Maclean Music, divisione americana della Northern Songs Ltd inglese, l’editrice musicale dei Beatles, prima bloccò il brano per quelle citazioni del suo catalogo. Poi stranamente acconsentì alla pubblicazione. Terry Knight sorrise.
Paul is dead.
«Ho capito male o hai detto che Paul McCartney è morto?» chiese il DJ della radio di Detroit WKNR-FM Russ Gibb il 12 ottobre 1969 a un tipo che, presentandosi come Tom, gli buttò lì la notizia.
(Ma guarda un po’, proprio un’emittente del Michigan, lo stato di Knight, ex conduttore di programmi musicali per WLQV di Detroit, WTAC di Flint e CKLW di Windsor, Ontario, sulle rive del fiume Detroit).
«Hai capito bene, Paul è morto: mercoledì 9 novembre 1966 alle cinque del mattino. E quello che c’è adesso è un sosia».
«E come sarebbe successo?»
«Era uscito dagli studi di Abbey Road dopo aver litigato con gli altri Beatles ed è salito sulla sua Aston Martin DB5. Si è fermato per caricare un’autostoppista, ed è ripartito con lei. So che la ragazza si chiamava Rita, che era incinta ma voleva abortire e allora era scappata dal fidanzato che non voleva. Non si è accorta subito che Paul era un Beatle, parlava e parlava e quando ha capito con chi era in macchina, gli è saltata letteralmente addosso. Paul non ha visto il semaforo rosso né il camion che gli tagliava la strada, lei lo stringeva, lo toccava ovunque, lo baciava, tutti quei capelli… e sono morti entrambi».
«Tu che ne sai?»
«L’hai vista la copertina di “Abbey Road”? E chiama questo numero: 5371438». Poi attaccò. Senza farsi più risentire.
Il 26 settembre 1969 era uscito “Abbey Road”. L’8 agosto, nell’omonima strada, i Beatles avevano fotografato la copertina del disco. La prima traccia suggerita da Tom che Gibb, diffusa la notizia per radio – perché Tom lo aveva chiamato fuori onda –, seguì. I Beatles nell’agosto del ‘67 erano stati a Bangor dal Maharishi Mahesh Yogi e da lì avevano portato alcuni insegnamenti, come quello che vuole i morti sepolti a piedi nudi. Paul sulla foto della cover è l’unico scalzo e davanti a lui camminano Ringo Starr in abito scuro e John Lennon in bianco; dietro c’è George Harrison in jeans. L’interpretazione dell’immagine sarebbe che Paul è il morto, Ringo il becchino e John il prete per il funerale – in alcuni paesi orientali il bianco è il colore del lutto; George è colui incaricato di seppellire la bara. Lo scavafosse. Camminano sulle strisce, Paul è fuori passo e sulla sua linea si allontana un’auto. Un’altra invece è parcheggiata, una Volkswagen Beetle targata LMW 28IF. La macchina passata simboleggerebbe l’incidente, la targa del Maggiolino direbbe che se fosse vivo Paul avrebbe 28 anni. C’è anche un furgone della polizia sulla destra: lo stesso in servizio quella notte nella zona del sinistro. Paul, che è mancino, tiene una sigaretta con la destra. Non tutto quadra, Paul avrebbe avuto 27 anni e non 28 (secondo alcune religioni orientali però si conta la nascita dal concepimento), ma le tracce aprono tante speculazioni sulla vicenda.
Restava il numero. Da dove veniva? Russ, prima di chiamarlo, si mise a studiare gli altri dischi della band dopo la presunta morte di Paul convinto che non ci fossero segni solo in “Abbey Road”, e trovò, infatti, nel “Magical Mistery Tour” proprio quel numero, bastava capovolgere la copertina e leggere la parola Beatles così. Chiamò ma rispose un signore che disse di chiamarsi James e che non sapeva chi fossero i Beatles, aggiungendo però di richiamarlo due giorni dopo alle nove del mattino. Nove come il giorno della morte. James è il primo nome di Paul McCartney. Russ richiamò, ma non rispose più nessuno. Ormai la caccia all’indizio era diventata l’ossessione del DJ e dei fan. “Magical Mistery Tour”, il disco e il film di cui l’album era la colonna sonora, suggerirono altre congetture. La scritta sulla scrivania dove sta seduto Paul McCartney, con dietro le bandiere britanniche piegate a lutto, nella pellicola dice “I was”. Quindi, se io ero, ora non sono più: lui fu, o è un altro. Quella sulla batteria di Ringo dichiara “Love the 3 Beatles”, non 4, e Lennon alla fine di “Strawberry Fields Forever”, sussurrando “Cranberry sauce”, pare dire “I buried Paul”. C’è morte anche al fondo di “I Am The Walrus” col Re Lear di Shakespeare registrato che dice “Oh morte inopportuna!”, e prima ancora una voce ascoltata al contrario in sottofondo diceva “Ha ha, Paul is dead” e un’altra frase faceva “Oh is really dead”. Ma sarà “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band” a convincere Gibb che mettendo uno specchietto al centro della grancassa in copertina sulle parole “LONELY HEARTS” ottenne “I ONE IX HE DIE”: ovvero la data dell’incidente e la morte di Paul. La statuina di Shiva, divinità indiana di distruzione (anche Hara: colui che porta via) posta davanti alla scritta floreale Beatles, la conferma. Come il basso Hofner mancino senza una corda fatto di fiori gialli che sembrano crisantemi e una bambola con una macchinetta modello Aston Martin sopra la gonnellina, dall’altra parte c’è un guanto da guida, pare insanguinato, e anche l’oboe nero di Paul e la mano sopra il suo capo in segno di benedizione ai morti attesterebbero il decesso. La scena della cover sembra così un funerale coi nuovi Beatles in uniforme da banda e i vecchi di lato ridotti a statue da museo delle cere (non era forse stato posizionato proprio sopra il museo delle cere di New York il cartellone dei Grand Funk Railroad). E tante personalità convenute. All’interno dell’album, inoltre, Paul è seduto a gambe incrociate, come i celti seppellivano i defunti, e sulla divisa ha un distintivo con la sigla “OPD” usata dalla polizia inglese per dire “Officially Pronounced Dead”. “Good Morning, Good Morning” comincia con “Niente da fare per salvargli la vita”. E il disco si chiude con “A Day In The Life” che, malgrado la prima parte, per dichiarazione di Lennon, fosse ispirata alla notizia da lui letta sul Daily Mail del 17 gennaio 1967 riguardante la morte in un incidente automobilistico dell’amico di Paul Tara Browne della ricca famiglia Guinness, non è difficile leggervi anche una relazione a quella di McCartney nella strofa che fa così: “Si è fatto saltare il cervello in un’automobile. Non si era accorto che il semaforo era cambiato. Una folla di persone stava in piedi e fissava. Avevano già visto la sua faccia”. E se la “Lovely Rita” del brano omonimo fosse proprio lei, l’autostoppista in fuga?
Lo scontro tremendo scaraventò Paul fuori dall’abitacolo devastandogli la testa. Lo schianto e una voce che pare chiedere aiuto segue alla frase “turn me on dead man”: è il “number nine” ripetuto più volte ascoltato all’inverso, almeno così sembra, e poi si odono suoni tipo di sirene e grida e risa e sospiri sofferti, la folla e pianti e applausi, urti, schianti, esplosioni, forse, nella cacofonia di “Revolution 9” del “White Album” con parti registrate al contrario che messe nel verso giusto rivelano la terribile vicenda. Alla fine di “I’m So Tired”, del medesimo disco, allo stesso modo inverso si sente “Paul ora è morto, ci manca”, e l’ultima strofa di “Don’t Pass Me By”, ancora dell’“Album Bianco”, dice: “Eri in un incidente di macchina e hai perso i capelli”. Macabri giochi surrealisti dei Beatles e pubblicità tirata fuori dalla casa discografica quando la band era alla fine, con la complicità proprio di Knight, nonché di alcuni studenti universitari americani che nel giornale della facoltà, tipo il Northern Star dell’Illinois e il Michigan Daily, scrissero articoli su questa teoria – Tim Harper, della Drake University di Des Moines nello Iowa, ci guadagnò anche dei bei soldi andando in giro per emittenti televisive a mostrare gli elementi a favore della tesi nei talk show – oppure era tutto vero? (Ma andiamo!). Nessuna di queste tre ultime canzoni comunque è stata scritta da Paul: la prima è di Lennon con la collaborazione di Yoko Ono, la seconda del solo Lennon mentre “Don’t Pass Me By” è di Ringo. In seguito, su “Let It Be”, Russ Gibb, ascoltando al contrario il ritornello del brano omonimo, avrebbe sentito la frase “He is dead”, e, con lo stesso procedimento, in “Get Back” si ascolta “Help me, help me, I need some wheels”.
È difficile però credere che un tale identificato come William Sheppard, ex poliziotto canadese (per qualcuno era un attore scozzese fallito di nome William Stuart Campbell, ma i nomi e i ruoli si possono tranquillamente invertire) reclutato a un concorso per sosia di Paul indetto dalla EMI che non proclamò mai il vincitore, potesse sostituirsi così bene al vero, cantando anche uguale. C’è chi dice che la scelta di non fare più concerti dopo quello del 29 agosto 1966 al Candlestick Park di San Francisco fosse dovuta proprio alla perdita di Paul e che il finto McCartney riuscì a esibirsi con gli altri, dopo un lungo periodo di rodaggio, soltanto nell’addio dei Beatles sul tetto della Apple il 30 gennaio del ’69. Con una barba nera a camuffare il viso ritoccato dalla chirurgia plastica. E lì su, in alto. E poi, come faceva quel Tom a sapere come erano andate le cose? Possibile che la polizia non si sia accorta di niente? E se Tom fosse proprio un agente intervenuto sul luogo dell’incidente o il camionista o magari il fidanzato della ragazza? Oppure Tom era stato un semplice testimone dell’incidente e aveva ricostruito gli eventi precedenti lo schianto ipotizzando. Qualcuno pensò che Brian Epstein, insieme alla EMI, avesse comprato il silenzio della polizia e di chiunque sapesse e che quando in un ripensamento mostrò l’intenzione di rendere pubblica la cosa, fu tolto di mezzo, il 26 agosto 1967 simulando un’overdose di barbiturici. Tom non voleva fare la stessa fine, però non riusciva a tenersi il segreto e così…
Insomma, era impossibile trovare una teoria più sconclusionata. Ma quando a Knight chiedevano se ne sapesse di più riguardo la strana vicenda, lui scrollava le spalle e faceva il solito sorrisetto di chi sa tutto ma non dice niente. Lo abbiamo detto, era un genio del marketing. E il signore della truffa. Con i Grand Funk Railroad ci fu una lunga disputa legale perché la band lo accusava di avergli, in pratica, fregato tutti i soldi nella sua gestione che terminò nel 1972 con la sua cacciata con ignominia sia dalla band sia dalla Capitol (anche se il tribunale gli accordò una cospicua buonuscita e il cinquanta per cento delle royalty sul materiale pubblicato fino ad allora dal gruppo, mica male). Iniziò a questo punto il declino del genio dello show-biz. Annaspava, faceva di tutto per rimanere a galla. Fondò una propria etichetta discografica, la Brown Bag Records, e mise sotto contratto una buona serie di fallimenti. Gli proposero di occuparsi dei nascenti Kiss, ma rifiutò sostenendo che quei tipi conciati in quel modo non sarebbero andati da nessuna parte. Provò a farsi un po’ di pubblicità riprendendo la frequentazione, iniziata nel periodo londinese, con la modella e attrice inglese Twiggy. Lei presto lo lasciò – se mai erano stati insieme. Si fece vedere negli autodromi dove correva l’attore Paul Newman. Fece qualche gara. Le foto insieme, in tuta da corsa, bottiglia di champagne, sorridenti. Intorno belle donne. Non se lo filava più nessuno. A parte gli spacciatori. Per aver deposto in tribunale contro alcuni di questi che lo rifornivano di cocaina, deciso a smettere, fu messo per un periodo sotto un programma di protezione testimoni e disintossicazione dell’FBI in una località segreta dell’Arizona. Intanto aveva speso tutti i soldi in macchine, stupefacenti e un jet personale. Alla fine si arrese, era stanco e malato di diabete e al fegato. Let it be. Si rinchiuse nella sua nuova casa di Temple nella Contea di Bell in Texas a sessanta miglia a nord di Austin mettendo su una piccola agenzia di raccolta pubblicitaria per qualche giornale locale sulle cui pagine le sue cronache e i successi non comparivano più. Viveva con la figlia Danielle, il fidanzato di questa, Donald Alan Fair, e tanta droga, consumata soprattutto dal ragazzo. Fu in questa desolata fase della sua vita persa nell’isolamento del complesso delle Chappell Hills che il primo novembre del 2004 arrivò la tragedia. Nel giorno dei santi che si sarebbe riversato su quello dei morti.
Terry is dead.
Le urla. Iniziò con le urla di Danielle. Proseguì con le botte di Donald sul suo esile corpo da adolescente. Lei aveva diciassette anni, lui ventisei. Stavano insieme da quando lei era quattordicenne e abitava con il padre, che ne aveva ottenuto l’affidamento dopo il divorzio, a Yuma, in Texas. Donald lavorava al locale Wendy’s restaurant, poi Terry gli aveva trovato un posto in un autolavaggio, e quando genitore e figlia si trasferirono a Temple, lui li aveva seguiti. Sembrava non potesse staccarsi da quella ragazzina. Erano entrambi strafatti di metanfetamine – per queste stavano litigando. Lui di più. Molto di più. Sembrava che la droga non bastasse mai. Non bastavano mai i soldi che gli passava lei. Non bastavano quelli che gli passava Terry Knight. Donald non faceva niente dalla mattina alla sera. Donald sfruttava quei due. Donald è più forte e arrabbiato. Dall’altra stanza Terry Knight sente le grida della figlia. Il rumore sordo delle percosse. Accorre in sua difesa. Si scaglia sul giovane e lo colpisce al volto con un pugno e poi un altro. Finiscono a terra. Lottano confusamente. Donald ha con sé un coltello da caccia di sei pollici. Lo conficca nel corpo del padre della sua fidanzata. Una volta, con rabbia, una seconda, con ancora più furia e violenza. Ora non capisce niente e continua a infilare la lama: nei polmoni, nei reni, nella milza, ovunque nell’addome e infine penetra nel cuore. Sfinito si lascia andare sul pavimento. L’autopsia avrebbe contato diciassette pugnalate. Danielle è corsa dai vicini a chiedere aiuto. I soccorsi del 911 trovano Richard Terrance Knapp, in arte Terry Knight, coperto di sangue e in fin di vita. Donald Alan Fair aspetta la polizia seduto sull’uscio di casa al 3009 di Ira Young Drive. Con il coltello in tasca. Danielle andrà a vivere dalla madre nella non distante Copperas Cove. I giornali non diedero grande risalto alla notizia. Che cosa misera erano quelle pagine rispetto all’immenso cartellone su Times Square. Forse fu l’ultima cosa che Terry Knight vide mentre la vita lo abbandonava. Vide anche lo Shea Stadium sorvolato in elicottero. Però, che giorni! Un ultimo sorriso strozzato gli si deve essere accennato sul volto trasformato dalla sofferenza ripensando alla burla del PID. Ma ora non era uno scherzo. Adesso era tutto vero. Paul era vivo, lui era morto.
Uno strano evento intanto era accaduto anni prima. Il 5 gennaio 1976, a Los Angeles, Mal Evans, ex assistente personale dei Beatles, fu ucciso da sei colpi di pistola sparati dalla polizia che aveva fatto irruzione nel suo alloggio al 8122 W della Quarta Strada. Gli agenti erano stati chiamati dai vicini per le urla di una lite tra lui e la sua ragazza. Evans aveva un fucile e i poliziotti non gli diedero il tempo di usarlo. Ma l’arma era solo ad aria compressa. Evans custodiva una valigetta con vecchio materiale dei Beatles che sparì dagli oggetti sequestrati dagli agenti. Sembra avesse posato sul retro della copertina di “Stg Pepper’s”: era colui che interpretava McCartney di spalle – perché Paul quel giorno non poteva partecipare alla session fotografica. Vicino alla sua nuca c’era scritto “Without You”.
[1] Pubblicato su “Verde” del 20 giugno 2017.
Ieri abbiamo fatto un discreto casino (verde) quando abbiamo realizzato che non avremmo pubblicato in tempo la nuovaRock CriminaldiSergio Gilles Lacavalla. Tutta colpa del già ex redattore, ex collaboratore e prossimo ex-curatore della nostra rivista, pronto a lasciare (“In Fuga” alludono i bene informati) anche la gestione del blog (non tutti sanno che da più di un anno la testata di Verde è in vendita a 20 euro. Per info).
Il 1 giugno 1967, cinquant’anni fa, usciva Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Paul McCartney era già morto o il macabro scherzo era ormai sfuggito di mano (ci ricorda qualcosa)?Terry Knightera un genio del marketing, il signore della truffa e uno che la sapeva lunga su PID Hoax.
L’illustrazione è di DeadTamag0tchi.
View original post 3.482 altre parole
Atti di Vita e Malavita. Jeanne e Gilles[1]
Dramma in un atto
Nota dell’autore. “Jeanne e Gilles” è uno degli atti di “Atti di Vita e Malavita”, dramma in nove atti unici, o in tre trittici. Ha, come tutti gli altri atti, una sua autonomia, quindi, si può mettere in scena da solo.
Alcune scene sono sessualmente esplicite. Il corpo nudo è necessario sia per il realismo della scena, perché la scena lo prevede, sia perché il corpo nudo è di per sé un elemento di drammaturgia, non solo di regia: il corpo nudo è linguaggio, una frase, un discorso. Disse la drammaturga inglese Sarah Kane, che recitò il ruolo di Grace in alcune repliche del suo “Purificati”: «“Purificati” richiedeva una semplicità estrema, cosa molto difficile da ottenere quando ti ritrovi completamente nuda davanti a centinaia di persone… Il primo istinto è quello di scappare via, ma in realtà quello che ti viene richiesto è molto semplice. Che cosa voglio? Che cosa provo? E come arrivo a provare questo?»
Tutto ciò che avviene qui, è già avvenuto. Quando Jeanne racconta i momenti di sesso, sono solo ricordi. Eppure, avvengono. Dunque, in scena, i personaggi, in questi momenti d’amore, possono fare cose diverse da quelle descritte: sono seduti sul letto, si spogliano, non si guardano, si osservano, si mettono giù. Si sfiorano i corpi nudi, la pelle ha un brivido di nostalgia, si appoggiano l’una sull’altro. La testa sulla spalla. Si baciano le bocche, si leccano i sessi. Solo alcune azioni avvengono come descritte. Mai si concludono. Si avverte sempre qualcosa di perduto. Questo è un testo sul rimpianto. Sul momento temo di non avere altri temi.
La pièce, oltre che in teatro, può essere rappresentata in un hotel vero. Penso a “Splendid’s” di Jean Genet messo in scena dai Motus – che non c’entrano niente con questa scrittura, se non per l’ambientazione.
“Stai scrivendo?”
“No, ti stavo solo pensando.”
(“Betty Blue”, Jean-Jacques Beineix / Philippe Djian)
SCENA I
Davanti a un Hotel abbandonato sul mare. Jeanne Pleiade e Gilles Dutronc.
JEANNE (Ha le scarpe in mano, una borsa sulla spalla). “Dal momento che la vita scorre nel corso del tempo senza bisogno di creare storie, le storie esistono solo nelle storie”. Non è così? E nelle storie, tutto è al posto giusto, tutto è necessario. Ogni parola. Ogni gesto. Solo nelle storie.
L’hotel di Wenders. (Guarda l’entrata dell’albergo. Poi si rivolge a Gilles).
Qual è il tuo stato delle cose, Dutronc?
GILLES Scrittore e drammaturgo senza un libro pubblicato da cinque anni, forse è passato di più da un dramma rappresentato, a parte qualche reading, col sogno di fare il concorrente a Fort Boyard.
JEANNE Lo fanno ancora?
GILLES Fort Boyard? Sì, penso di sì… o forse no… non lo so, non l’ho più visto. Non so perché… mi piaceva… insomma…
JEANNE Un intellettuale che guarda Fort Boyard. Mmm, non c’avevo mai pensato a Fort Boyard. Arrampicarsi sui muri della fortezza e gettarsi nel vuoto sopra il mare legati alle funi, risolvere gli indovinelli, restare imprigionati in una cella… sempre fradici… audaci e ridicoli. Perché no? E Les enfants du rock?
GILLES No, quello non lo fanno più, sicuro. Era roba di quando eravamo bambini. Io un po’ meno, ma tu eri proprio una bambina.
JEANNE Peccato. Ci saremmo stati bene noi due a Les enfants du rock. Intervistati da Thierry Ardisson e con la sigla di Iggy Pop, Nightclubbing. (Accenna la canzone). “Nightclubbing, we’re nightclubbing. We’re what’s happening. Nightclubbing, we’re nightclubbing. We’re an ice machine…”
GILLES (La interrompe). No, quello era Lunettes noires pour nuits blanches, il programma con Ardisson. Mi sembra, non ricordo bene neanch’io.
JEANNE Ah è vero! Oh che memoria!
GILLES Eri troppo piccola. Comunque non fanno più neanche quello; sì peccato, ci saremmo stati bene a Les enfants du rock e a Lunettes noires pour nuits blanches. L’intervista verità. E il tuo, Pleiade? Il tuo stato delle cose.
(Lei non risponde).
Chi è? Cosa fa? (Le chiede guardandola. Lei abbassa lo sguardo protetto dagli occhiali da sole. Ora sono entrambi seri).
JEANNE Entriamo, Dutronc.
SCENA II
Nella sala d’ingresso dell’hotel abbandonato.
JEANNE La storia qui fu interrotta, parlava di una storia interrotta, dall’esterno, il film di Wenders.
GILLES Come la nostra.
JEANNE (Scontrosa). No, senti Gilles, la nostra, se proprio la vogliamo chiamare storia, che poi non lo è mai stata davvero, la nostra, Gilles, l’abbiamo interrotta noi, soltanto noi, o forse solo tu, non lo so, ma nessuno ha colpa se non noi, con chi vuoi prendertela?
(Adesso Jeanne addolcisce la voce e sorride a Gilles).
Dai, lasciamo stare.
(Passa le dita su una poltrona della hall, se le guarda e gliele mostra sporche di polvere e sabbia. La mano è fasciata sul palmo e sul dorso).
È rossa.
GILLES È polvere mista a sabbia. Viene dal deserto.
(Le pulisce le dita con le sue. Le tiene la mano. Jeanne si guarda anche la pianta di un piede, polvere e sabbia rosse anche lì. Le scarpe poggiate a terra).
È dietro di noi, il deserto, lo senti il vento?
(Jeanne fa no scuotendo la testa).
JEANNE O forse viene da un altro pianeta, come questa luce, la luce di un altro pianeta, o dopo un’esplosione nucleare.
(Si toglie gli occhiali scuri. Li butta su una poltrona).
“Guarda: senza gli occhiali da sole, senza i guanti di plastica, siamo noi i veri sopravvissuti”.
GILLES Sopravvissuti a cosa?
JEANNE Non lo so… forse a noi… forse agli altri.
GILLES (Guardandola negli occhi). Hai gli occhi verdi.
JEANNE Sono le lenti: i miei sono sempre castani.
(Si toglie una lente a contatto. La tiene sul dito).
Vedi? Gli occhi di bosco.
(La mette nel suo contenitore preso dalla borsa, lasciando la mano di Gilles).
GILLES Già. Gli occhi di storie.
(Le riprende la mano e l’accarezza sopra la fasciatura, fa una lieve pressione, Jeanne ha una leggera smorfia di dolore e gli toglie la mano dalla sua).
Sempre la mano… sempre nel sonno, oppure quando…
(Jeanne lo guarda per qualche secondo in silenzio, poi scrolla le spalle, riprende le scarpe e le poggia insieme alla borsa su un tavolinetto davanti a una finestra che dà sulla spiaggia e il mare di uno strano grigio come il cielo. Si mette seduta sul tavolino. Porta un piede su).
Come te la sei fatta questa?
(Gilles prende la caviglia della gamba di Jeanne sollevata sul tavolino e le tocca delicatamente una piccola cicatrice).
JEANNE La conosci da sempre e me lo chiedi solo adesso.
(Pausa).
Nuotando, tanto tempo fa, ormai. Avevo poco più di vent’anni, stavo uscendo dall’acqua della piscina, dopo aver fatto alcune vasche, poche per la verità, e avevo il fiato spezzato come non mi era mai successo prima, ma era da tanto che non mi allenavo. Sulla scaletta di ferro, mi sentivo senza più nessuna forza, davvero niente, niente e… sono scivolata come una stupida, ferendomi qui. (Si tocca sulla cicatrice spostando appena le dita di Gilles, che ora le accarezza il piede. A volte glielo bacia).
L’acqua era tutta rossa, sembrava chissà che, e io stavo lì fissa a guardare il mio sangue che si apriva lento e quasi morbido e mi veniva da piangere. Poi, infatti, ho pianto. Il dottore mi medicava e io piangevo, non è niente, mi diceva, stai calma che non è niente, non piangere, mi ripeteva, ma lui non capiva, io non piangevo per il dolore e il taglio, no, piangevo per quel gesto scomposto sulla scaletta, per il fiato corto. Piangevo perché all’improvviso mi ero accorta che stavo cambiando e io non volevo cambiare. Il fiato corto mi diceva che se alle cose non stai dietro, se le lasci andare così, cambiano, e tu con loro, tutto qui. No, io non volevo cambiare… ma, come si fa… e non volevo che le cose finissero, non l’ho mai voluto. Non lo accetto. Anche se una cosa non mi piace, non voglio che finisca.
(Guarda fisso Gilles e gli toglie piano la mano dalla sua caviglia, che lui ha ripreso ad accarezzare. Poi dirige lo sguardo verso la sala bar poco più in là. La indica).
Lì c’è il bar.
SCENA III
Nel bar.
JEANNE (È dietro il bancone. Passa in rassegna le bottiglie di alcolici). C’è ancora del liquore.
(Ne prende una, la posa. Un’altra. La mostra a Gilles).
Martini bianco?
GILLES (Dall’altra parte del bancone). Va bene.
JEANNE Ricordavo che ti piace la vaniglia. E poi, va bene, poco alcolico.
(Guarda i bicchieri allineati, coperti di polvere e sabbia).
I bicchieri… sono pieni di polvere anche loro.
(Apre il rubinetto per lavarne due, ma non c’è acqua).
Non c’è l’acqua. Mannaggia. Va be’, dai. (Esce dal bancone con la bottiglia in mano e va a mettersi seduta su una sedia davanti a un tavolino. Gilles la segue e si siede anche lui, davanti a lei. Jeanne apre la bottiglia, assaggia il liquore).
È ancora buono. “Martini girl. Oh yeah”. (Accenna la canzone di Macelleria Mobile di Mezzanotte. Manda giù un sorso più lungo di liquore. Passa la bottiglia a Gilles. Anche Gilles ne beve una lunga sorsata. Poggia la bottiglia sul tavolo mentre Jeanne allunga un braccio verso di lui lasciandosi andare giù fino a toccare con la tempia, lo zigomo e la guancia il tavolino. Gilles le prende la mano. Gliela bacia. Jeanne chiude gli occhi). Martini girl.
(Anche Gilles si abbassa sul tavolo portando il viso vicino a quello di Jeanne. Jeanne apre gli occhi, lo guarda).
(Gli soffio leggermente sulla faccia).
Martini girl, alito di vaniglia e alcol.
(Gli do un lieve bacio sulle labbra, stringendo di più la sua mano).
Bacio al Martini.
SCENA IV
Una stanza. In fondo al corridoio.
JEANNE (Ha lasciato le scarpe nella hall, la bottiglia sul tavolo del bar, ha con sé la borsa). Tante stanze e tutte vuote. Tutte aperte. Tutte abbandonate, come se fosse successo qualcosa all’improvviso e sono scappati tutti.
(Si siede sul letto, poggia la borsa a terra e prende un libro dimenticato sul comodino: un volume che parla della dissoluzione del rock’n’roll, dalla copertina nera come la notte dei crimini dell’anima. Con quattro segnaletiche. Pieno di storie d’amore finite male. Fa caso alla data di edizione).
Guarda, Gilles, qualcuno deve essere stato qui poco tempo fa, questo libro è recente.
(Lo apre dove c’è un segnalibro, lo porge a Gilles, che si è seduto anche lui, vicino a lei. Gli fa segno di leggere. Gilles comincia a leggere, ogni tanto lei sbircia tra le pagine, osserva Gilles, la sua bocca che pronuncia le parole, le sue espressioni da attore, legge con lui sottovoce, guarda la stanza).
GILLES “«Dai, è facile. Guarda». Gainsbarre si puntò la pistola alla tempia e premette il grilletto. Clic! «Così», e scoppiò in una risata. «Scusa scusa… ecco, adesso sono serio». Si era calmato, aveva cessato quella stupida risata, anche se ancora gli rimaneva tracciata nello sguardo strafottente, e quindi caricò il revolver porgendolo a Gainsbourg. «Su. È un attimo e non ci pensi più». Serge prese in mano l’arma e la fissò per un po’. Buttò giù un altro sorso di whisky, posò il bicchiere e poi, di scatto, pieno di rabbia e sudando freddo, aprì il caricatore e gettò contro il muro tutti i proiettili. «No! No!», urlò. «No», sussurrò piangendo. Gainsbarre scosse la testa. «Serge Serge, io te l’avevo data una possibilità. Ma tu… be’ ti rimangono sempre questi. Prendi». Serge Gainsbourg prese di nuovo il bicchiere, mentre Gainsbarre gli accendeva una sigaretta e gliela metteva tra le labbra tremanti e spaccate dalla notte insonne. Il sole dell’alba che cominciava a filtrare nell’appartamento di Rue de Verneuil carezzava Jane: fissata nel bronzo senza arti né testa. Così, almeno così, non poteva più fuggire da lui.”
(Jeanne si tira appena le ciglia dell’occhio dove ha ancora la lente e smette di leggere insieme a Gilles).
JEANNE Mi bruciano gli occhi e non ci vedo bene. (Si strofina l’occhio senza lente. Gilles posa il volume sul letto).
Lui c’è stato a Les enfants du rock. E anche a Lunettes noires pour nuits blanches. Così provocatore e seducente. Lo sai che non accettava di fare trasmissioni registrate? Temeva che poi avrebbero tagliato alcune cose che aveva detto, quelle più scandalose, ovviamente. Dirette televisive. Solo dirette. Lo adoravo da ragazzina.
(Pausa).
A Lunettes noires c’è stato anche Andrzej Żuławski; no forse era un altro programma, in ogni caso litigò con Ardisson che gli chiedeva di Sophie Marceau, riguardo il suo film del momento, La fidélité. La metteva sul personale: quanto c’è di autobiografico nella pellicola? L’ha tradita? E cose di questo tipo, detestabile… L’hai visto?
GILLES No.
JEANNE Żuławski chiuse la discussione andandosene. Anche se una volta lo sentii parlare male della sua ex moglie, di Sophie Marceau.
GILLES Non erano sposati.
JEANNE Ne sei sicuro?
GILLES No. Non lo conoscevo poi così bene.
JEANNE Va be’, è uguale. Diceva che era un’ignorante, che quando l’aveva conosciuta era davvero un’ignorante, non aveva mai letto un libro in vita sua, disse. Ed era maleducata, volgare, non si lavava. Sai, lui il grand’uomo che veniva da una famiglia di letterati. Così civilizzato e colto. Ma il suo era solo rancore. Era evidente: ormai era invecchiato e stava morendo. Poi fece un gran sorriso.
(Pausa).
Eppure mi è dispiaciuto quando è morto. Tu lo hai più visto?
GILLES Un paio di volte. L’ultima era a Parigi per il montaggio di Cosmos. Gli regalai un mio libro. Gli scrissi una dedica e lui si commosse.
JEANNE Cosa ci avevi scritto?
GILLES Qualcosa che riguardava il suo essere stato un po’ un maestro per me, lo sai, almeno un tempo deve essere stato così, una cosa del genere. Forse sembrava un addio. Sì, anch’io lo trovai invecchiato. E debole. Indifeso. Malato.
JEANNE Che fine malinconica: senza più la donna della sua vita, pieno di rabbia ma pure di rassegnazione. L’uomo sicuro di un tempo ora rideva sperduto. Con un ultimo film che per lui era stato un errore. Fatto con pochi soldi e tanti compromessi. Non ne voleva parlare. Ma Cosmos non è piaciuto neanche a me. A te è piaciuto?
GILLES No, nemmeno a me.
JEANNE Morto con ancora in testa le immagini della prima moglie che se ne era andata neanche due anni prima dopo una vita di follia, così diceva lui: che era pazza. Raccontava che una sera rientrò a casa e trovò suo figlio da solo, tutto sporco di marmellata, perché lei l’aveva abbandonato inseguendo un suo delirio mistico. Diceva che era ispirato a lei il personaggio di Isabelle Adjani in Possession. Ma questa storia dovresti conoscerla meglio di me. Probabilmente non era vero niente. Chissà se è andato al suo funerale. Non credo. Disprezzava sempre chi lo aveva lasciato. E mentiva. Anche lei era molto bella. Capelli biondi lunghi e lisci e grandi occhi chiari. Anche lei era un’attrice. Morire sbagliando. Sbagliando tutto.
GILLES Però L’amour braque lo riscatta da ogni errore.
JEANNE Sì, è vero. È un film bellissimo. E anche loro erano bellissimi e innamorati all’epoca.
(Pausa).
(Faccio colare dalla mia bocca un filo di saliva su due dita della mia mano e le appoggio sulle sue labbra. Gilles le lecca. Con le dita umide gli seguo il contorno della bocca, poi quello degli occhi. Lui abbassa lo sguardo).
(Jeanne toglie piano la mano dal viso di Gilles).
L’hai ascoltato il disco degli Spiritual Front?
GILLES (Rialza lo sguardo). Quello intitolato Amour braque? No…
JEANNE Mmm, già, capisco…
(Pausa).
Dovresti, è molto bello e… Una mano che serra un pugnale con un teschio sull’impugnatura, lo stringe sulla lama, intorno c’è un cuore fatto di filo spinato, la scritta Amour braque…
GILLES Non ti ho mai vista con una maglietta degli Spiritual Front, è strano, no?
JEANNE Ci sto bene, sai? La mia preferita è quella di Open wounds, con i due amanti che si baciano puntandosi i coltelli alle schiene.
(Pausa).
GILLES Ricordo una tua carezza a un loro concerto. Mi passasti vicino e mi sfiorasti con la mano il viso. Ma non credo che tu la ricordi.
JEANNE Invece sì. Perché non dovrei ricordarla? E ricordo anche che mi allontanai dall’altra parte del locale. Aspettando che tu mi cercassi tra il pubblico per restituirmela. O un bacio sulla guancia. Ma tu non ti spostati da lì.
(Pausa).
GILLES Tutto era stato catturato da quella carezza. Ricordo questo. Di quella sera ricordo la tua carezza e nient’altro. Ricordo che non sapevo che fare. Ricordo che non volevo che quell’azione finisse in un errore.
JEANNE Eri capace di affrontare chiunque, di notte, in un quartiere malfamato. E avevi paura di sbagliare una carezza. Di dirmi…
(Pausa).
“È più facile uccidere quando non riesci più ad abbracciare”. Era in un tuo libro.
(Pausa).
Io sono più coraggiosa di te.
(Pausa).
Sì, lo sono sempre stata.
(Pausa).
O forse lo ero. Comunque se non fosse stato per il mio coraggio…
GILLES E a cosa è servito?
JEANNE Ad avere dei ricordi. Ad avere dei ricordi, Gilles. Magari un po’ confusi. A tratti sbagliati. Ma ricordi. Per essere qui. Ancora qui. In questo niente. In questo tutto. Con il mare, la luce strana e la sabbia rossa.
(Pausa).
Dai, continua a leggere, per favore.
(Pausa).
GILLES Va bene. (Riprende il libro e legge. Jeanne a volte è distratta, si guarda intorno, guarda Gilles ma non ciò che sta leggendo; segue più i suoi pensieri che la storia). “Ma qualcosa cominciò presto a consumare Serge. Lei gli ripeteva che l’amava. Lui beveva e fumava sempre più e inciderà nel ’71 Histoire de Melody Nelson che racconta l’amore tra un uomo maturo e una quindicenne che finisce in tragedia e la dedica è alla sua giovane donna che da lì a breve avrebbe dato alla luce Charlotte. Andarono a vivere a Rue De Verneuil, al n° 5, come il profumo dello charme francese: la casa dipinta di nero che odorava di donne e innocente peccato. E di Gitanes, cinque pacchetti al giorno. Anzi, a notte: notti a scrivere una sigaretta dietro l’altra e l’alcol. «Ti ucciderai!» gli urlava Jane, lo implorava di darsi una calmata, lo schiaffeggiava e cominciò a fumare pure lei. «Vediamo chi muore prima». Durò invece tanto ancora Serge continuando a fumare e a bere sempre più perché gli avevano detto che l’alcol riduceva gli effetti del fumo, e a scandalizzare, come col disco di Jane Lolita go home con lei nuda in copertina e il film intitolato come il suo strepitoso successo Je t’aime, moi non plus nel ‘76. Quando la pellicola uscì, fu definita pornografica e la coppia aggredita da ogni parte. Il regista François Truffaut la difese, ma per due anni Jane Birkin non riuscì a trovare uno straccio di ruolo e con Serge si mise a fare la pubblicità. Quando Serge fece un nuovo disco, questo fu L’home à la tête de chou, un concept album noir con la protagonista che è uccisa con un estintore e il suo assassino finisce in manicomio con la testa rosicchiata dal coniglietto di Playboy come fosse un ortaggio. A rosicchiarlo a Serge continuavano a pensarci l’alcol e il suo fumo. Rientrava a casa ubriaco fradicio e mostruoso. Trasformato in Gainsbarre. «Gainsbarre, nome inventato che descriveva un completo nichilista. Gainsbarre rideva di Gainsbourg e prendeva in giro Ginsburg, ma tutti e tre erano dentro di lui, come in una matrioska», disse anni dopo Jane, che intanto non ne poteva più, litigavano sempre. «Una Gitane non ti tradisce» diceva lui quando un giorno Jane…”
JEANNE (Interrompendolo). Ma dove stai leggendo? Non era lì, hai saltato le pagine, dà qua, lasciamo stare, va, che è meglio. Dai. È troppo triste questo libro.
(Gilles sorride. Lei gli toglie, con delicatezza, il libro dalle mani e lo rimette sul comodino. Prende un pacchetto di sigarette dalla borsa e se ne accende una).
Vuoi? (Gli porge la sigaretta dopo una boccata. Gilles fa di no con la testa). Già, non fumi.
GILLES Non mi piace.
JEANNE Neanche a me. Giusto una ogni tanto. Vedi, è un pacchetto da dieci. (Fa ancora un paio di tirate e spegne la sigaretta su un posacenere sopra il comodino).
Dovremmo cercare un altro modo per morire.
(Pausa).
Eppure è una bella storia, quella tra Jane Birkin e Serge Gainsbourg.
(Pausa).
No, è orribile.
(Pausa).
Un libro interrotto e dimenticato, un letto non riordinato, e sì, sembra proprio che chi era qui sia scappato all’improvviso… erano due, come noi. Scappare – scopare. (Sorride).
Che stupido gioco di parole, eh Gilles? Ma se ci pensi, non è poi così stupido, no? Adesso abbiamo un posto dove stare: lontano da tutti. Anche da noi. Scappare – scopare.
(Si mette giù sul letto, poggiandosi sulle gambe di Gilles).
Guarda che strane ombre. (Fa osservando il soffitto).
Che ci facciamo qui? Eravamo noi due, quei due, vero? Non mi ricordo quasi più niente. Ma adesso va bene così.
(Si rimette seduta e apre la camicia di Gilles. Gli accarezza il torace).
Ti depili intorno ai capezzoli e sul petto, come una ragazza lo fa sulle gambe e sotto le ascelle, a volte sul pube, io il pube non lo depilo mai: hai la pelle liscia di una ragazza.
(Jeanne dà un piccolo bacio sul torace di Gilles aprendogli di più la camicia).
E come una ragazza, i tuoi capezzoli s’inturgidiscono. (Dice dopo avergliene leccato uno. Poi gli toglie la camicia).
Ti depili anche le ascelle. Hai sempre un bel corpo, Gilles. Continui ad allenarlo, vedo. Tiri ancora di boxe?
GILLES Sì. A volte.
JEANNE Mmm. (Pausa). Già. È importante avere un bel corpo, ti protegge un po’ dalla solitudine: ti guardi allo specchio, ti senti e… un bel corpo è sempre un corpo in attesa… è importante… ma c’è anche qualcosa di triste in questo.
(Ora Jeanne apre la sua camicia e si guarda il seno nudo; senza alcun sostegno del reggiseno).
Dovrei fare qualcosa anch’io, sto perdendo tono e sono molla sulla pancia. (Si osserva l’addome morbido con qualche piccola piega dalla posizione).
(Gilles mi accarezza il seno indugiando sui capezzoli che cominciano a ingrossarsi e indurirsi, poi la pancia).
GILLES Sei bella così.
JEANNE Molla?
GILLES Così. (Sorride. Sorride anche lei).
JEANNE (Gilles s’inginocchia, mi solleva la gonna e mi toglie gli slip bianchi. Gli poggio un piede sulla spalla e lui mi accarezza il sesso, comincia a leccarmelo mentre lo fisso. Mi tocca anche il piede).
Sei bellissimo, Gilles, quando mi lecchi.
GILLES Sei bella come un film di Bertolucci.
JEANNE (Mi dice staccando appena la bocca dalla mia fica umida tra i peli folti e alzando lo sguardo).
Antonioni, Gilles… era Michelangelo Antonioni, ora sei tu a non ricordare. Non ricordiamo niente… Philippe Garrel. I baci di soccorso. Senza quei baci, quando Nico morì, lui tentò il suicidio. Senza i baci. Senza soccorso.
(Gilles mi guarda in faccia ancora per qualche istante e riprende ad accarezzarmi il sesso. Lo bacia. Mi infila piano un dito nella vagina, la strofina in profondità e seguita a leccarmi. La clitoride. Le labbra. Continuo a guardarlo. A osservare quell’azione su di me che mi ricorda l’amore).
Non mi piace Antonioni: troppo sfacciatamente poetico. Vanno di moda gli occhi, non è ridicolo? Mi fanno male i capelli, ridicolo. E poi la poesia non esiste.
(Gilles non smette di leccarmi e di penetrarmi, ora con due dita. Una, dell’altra mano, è nell’ano. Continuo a fissarlo).
GILLES Allora sei bella come una canzone di Nick Cave. (Le dice fermandosi).
JEANNE E questa in che film era?
GILLES In nessun film. Romantiche, malinconiche, avvolgenti, umide e assassine. Le sue canzoni. Le tue poesie.
JEANNE (Gilles riporta la bocca sulla mia fica. Lascio uscire un po’ di pipì, solo un po’, poche gocce incerte, poi, piano il mio piacere. Gilles mi lecca ancora, bevendomi. Una poesia umida).
La poesia. No, non esiste… e se esiste, dà solo fastidio, è finta, inutile, un inganno. (Si lascia andare di nuovo giù, guarda ancora il soffitto. Porta un piede sul letto, vicino al pube).
Nick Cave era nel Cielo sopra Berlino. “Vi parlerò di una ragazza”. Avrei voluto essere una trapezista. Illudendomi di volare mentre cadevo dal trapezio nel vuoto.
O dall’insegna del Million dollar hotel.
GILLES Mi piace quando cammini a piedi nudi.
JEANNE (Gilles mi accarezza il piede che sfiora il mio pube, ha tolto il dito dall’ano, senza smettere di leccarmi e accarezzarmi il sesso). Le scarpe, i tacchi a spillo, che idiozia, che follia, per troppo tempo non mi hanno fatto sentire la terra dove camminavo. Camminare scalza sporcandomi i piedi della polvere di un altro pianeta.
Di questo posto nel nulla… Zabriskie Point. Bum! From here to eternity. From her to eternity. Da qui all’eternità. Da lei all’eternità.
(Riguarda Gilles tra le sue cosce).
Un’esplosione, e tutto finisce, così. Finire adesso… mentre scopiamo: scappare – scopare, vedi che ha un senso?
SCENA V
Jeanne e Gilles sono nudi sul letto.
JEANNE (Gilles sente sempre più il sapore del mio piacere sulla sua bocca. Forse non l’ha mai dimenticato, questo sapore. Quest’odore forte. Che impregna l’aria e i nostri ricordi a volte scordati apposta, altre perché così succede. Leccarmi tenendomi le labbra aperte, vuol dire ricordare. Esce languido. A volte è lattiginoso, denso. Poi più liquido e trasparente. Mi giro e mi inginocchio sul letto. Lascio scivolare le mani in avanti sulle lenzuola abbassandomi con il busto, facendo aderire i seni al letto. Siamo entrambi nudi. Gilles mi apre i glutei morbidi e mi lecca l’ano con un po’ di peli intorno, mi rimette un dito dentro il culo, che io lascio cedere. E ancora nella fica. La dischiude e la lecca strofinandomi la clitoride. Penetrandomi forte con due dita unite. Il rumore dello sfregamento sembra fortissimo: annulla il silenzio, lo amplifica. Sono inginocchiata come in una preghiera per questo amore, per questo momento che somiglia all’amore. Porto la mano dietro prendendo il membro rigido di Gilles, gli tolgo le dita bagnate e me lo metto dentro la vagina. Lui mi scopa solo qualche secondo, forse un minuto, forse alcuni minuti, non capisco, tra l’attimo e l’eterno, ed esce. Glielo riprendo e lo dirigo sul mio ano umido. Inculami, gli dico. Mettimelo nel culo. Gilles entra piano ma fino in fondo, fino all’intestino. Rimane immobile. Poi si muove, sono ancora pochi secondi, forse ancora un minuto, forse qualche minuto. Cerco di serrare l’ano per tenerlo in me. Lui esce. Mi volto, siamo inginocchiati uno di fronte all’altra, gli tengo il sesso e mi sdraio, le mie gambe aperte, la mia mano lo porta ancora nella mia fica, lui mi afferra i piedi e riprende a scoparmi, li stringe forte, i piedi, stringo la mia vagina sul suo pene, sono fradicia, il suo cazzo scivola fuori e Gilles si sdraia sul letto, allora gli riprendo il sesso, lo masturbo, e mi masturbo, lo porto nella mia bocca, ha il mio odore, il mio sapore, lo succhio, carezzandomi la clitoride, ancora non capisco se per pochi secondi, un minuto, forse di più, poi mi metto sopra di lui rinfilando il suo membro nella vagina sempre più fradicia, sempre di più, è un mare che cola sul suo cazzo, un ginocchio è sul letto, un piede sulla sua spalla, è una posizione scomoda, come il nostro amore, sembriamo un quadro di Egon Schiele, lui fa per togliermi da sé, ma lo blocco con le mani sul petto, con durezza, faccio no con la testa. No, ti prego no. Adesso no. E ripeto):
In una storia, ogni parola, ogni gesto, tutto deve essere al proprio posto, tutto necessario… (Sussurra). E questa è la nostra unica storia, gesti necessari. Solo questi gesti. Queste azioni. Belle, intime, naturali, facili, difficili, scomode.
(Pausa).
Leccami il piede.
(Gilles lo fa togliendo il mio piede dalla sua spalla, mentre continua a penetrarmi nella fica. Sono quasi immobile sopra di lui. Lo guardo incantata mentre la sua lingua mi lecca la pianta e le dita, lasciate rilassate tra le sue labbra. Non si cura della polvere. Della sabbia sul mio piede. Rimaste lì, attaccate alla pelle. Le sue labbra si macchiano di rosso, la sua saliva sulle dita. Ora contratte. Non porto lo smalto sulle unghie. La mia fica cola).
Adesso la bocca.
(Porto il piede indietro e mi abbasso su Gilles fino a baciarlo. È un bacio lungo, pieno di saliva).
I baci di soccorso.
(La saliva per medicare. Poi levo il sesso di Gilles dal mio e, voltandomi, mi porto con il sedere e la vagina sul suo viso).
69 mon amour.
(La mia bocca soffia questa frase sul suo membro, in un sorriso, e torno a succhiarlo, facendo aderire il più possibile le mie labbra al suo sesso rigidissimo, duro come l’alfabeto tedesco. Il mio culo con i glutei dischiusi si abbassa ancora un po’ sul suo volto, sulla sua bocca. Gilles mi lecca sia l’ano sia la vagina; entrambi palpitano, la fica continua a depositare sulla sua lingua liquido di piacere che si fa sempre più abbondante. Sempre di più. Gli cola ai lati della bocca. Il suo sesso sa ancora di me. Sempre di più. Mi giro di nuovo e mi rimetto sopra di lui).
Infilami ancora un dito nel culo, mentre mi scopi.
(Gilles mi penetra l’ano col dito, mentre mi muovo piano sopra di lui. Il suo pene immerso nel mio sesso. Piantato come a non voler più uscire da lì. Aumento il movimento e ora mi strappo la fascia dalla mano, me la mordo, come sempre, come sempre per riaprirmi la ferita. Il membro di Gilles sta per venire in me, lo sento. Io sto seguitando a venire su di lui, adesso con violenza. Ma Gilles, d’un tratto, mi toglie con forza da sé e, girandosi, eiacula abbondante e irrefrenabile sul lenzuolo. Cado sul letto, è un precipitare senza nessun appiglio. Lo guardo, masturbandomi seduta, con rabbia e disperata frenesia, con la mano insanguinata, per finire di venire con lui. Gli occhi lucidi, bagnati. Se è possibile, più della mia fica, adesso bagnata anche di sangue. Arrabbiata e confusa gli dico):
Perché? Eh? Ti ho chiesto perché? Volevo che mi venissi dentro… lo sai… tu non hai mai voluto niente da me, niente!
(Pausa, respira con affanno).
Oppure… ma che hai fatto in questi anni?
(Gilles non risponde).
Dio, Gilles. No, no, no Gilles.
(Jeanne comincia a piangere).
(Tu sei solo capace di abbassare la testa senza dire nemmeno una parola. Piangi con me. Una volta mi mandasti un messaggio di auguri, era il mio compleanno, e io ti scrissi che ti regalavo le mie lacrime. Erano lacrime belle, di gioia. Avevano un buon sapore. Mi rispondesti che le avresti conservate nella scatolina delle cose meravigliose – per un istante accenna un sorriso, continuando a piangere –, mischiandole alle tue. Ma non abbiamo mai pianto insieme. Se solo ne fossimo stati capaci. Se solo le tue lacrime si fossero realmente mischiate alle mie. Sulle labbra. Se solo ne avessimo assaggiato il sapore. Forse ci saremmo salvati. Piangi con me. Ma è inutile. Tieni la testa abbassata. E io piango anche per te. Perché io sono più coraggiosa).
SCENA VI
Jeanne non piange più. La mano è di nuovo fasciata. Stanno finendo di vestirsi.
JEANNE Viene dal deserto, questa polvere. Solo dal deserto. Il deserto dietro di noi.
Non mi piace più questo posto.
(Si chiude la camicia).
La luce ora è rossa come la polvere perché quello è un altro pianeta. E questo non è neanche l’hotel di Wenders.
GILLES Qual è il tuo stato delle cose, Jeanne?
JEANNE (Alza le spalle, non risponde). Questo me lo prendo. (Prende il libro, ne legge un ultimo frammento, come per distrarre Gilles da quella domanda a cui non vuole rispondere):
“Ancora un disco scritto per lei, Amour des feintes, fu l’ultimo gesto d’amore di Serge per Jane. Un giorno riuscì pure ad accompagnarla al pianoforte in un programma televisivo. Ma non la vedeva quasi più: gli piaceva ritrarla, però adesso non ci riusciva a chiuderla nell’obiettivo della sua macchina fotografica né a disegnarla con le matite facendola somigliante. Lei gli diceva che il disegno era bellissimo, ma non era vero e gli occhi le si riempivano di lacrime. E se non poteva vedere la sua bella Jane, Serge che viveva ancora a fare. E così Serge morì. Si sentivano tutte le sere, lei era a recitare in teatro, lui era sempre a casa. Sarebbe dovuto partire per New Orleans per registrare un nuovo album. Gainsbarre non glielo permise. Il primo marzo del 1991 andò alla festa di compleanno di Bambou in un locale, ma non tirò tardi come ai bei tempi. Tornò a casa e Gainsbarre gli versò da bere. Serge Gainsbourg morì per infarto la notte del 2, da solo – in quella casa nera di ricordi della felicità e del corpo nudo e androgino di Jane che vi girava, dove la sua stanza era ancora intatta.
Lo trovarono la mattina dopo. «Serge a bu trop de cigarettes», scrisse Liberation nel suo articolo in memoria. Jane continuò a cantare le canzoni di Serge, Serge Gainsbourg, l’uomo che aveva amato e che dentro di lei era ancora in vita (sotto terra c’era Gainsbarre – ne era convinta); continuò a cantare le sue canzoni con la sua voce esile mostrando lo spazio tra i denti, perché c’è sempre chi ha bisogno di quei brani per la serata giusta.
Al N° 5 di Rue De Verneuil, qualcuno ha scritto sul muro «Serge è in paradiso, e sta scopando».
Gainsbarre lasciò l’appartamento.”
(Si mette il libro nella borsa).
Sì, è proprio una storia orribile.
SCENA VII
Nella hall dell’hotel.
JEANNE Una pausa. A Parigi piove.
GILLES Solo una pausa.
JEANNE Solo una pausa.
GILLES Il tuo stato delle cose.
JEANNE Sto lì. Lo sai. (Sbatte l’occhio con la lente).
GILLES No, non lo so.
(Pausa).
Reciti ancora?
JEANNE No, non più.
(Pausa).
Non è rimasto niente di quei giorni.
(Gilles la guarda. Lei abbassa gli occhi. Dopo un lungo silenzio, rialza lo sguardo su di lui. Si fissano, per alcuni infiniti secondi).
GILLES È la prima volta che sento la tua voce.
JEANNE (Sorride). Te lo dissi dopo il primo abbraccio. Era vero, hai parlato solo dopo quell’abbraccio. Eravamo l’attrice e il drammaturgo. Ci studiavamo nei nostri movimenti. Nei nostri corpi estranei. Eravamo sudati. Eravamo lì, ma non mi ricordo più dove. Non ricordavamo i nostri nomi. Eravamo due attori. Davanti a tutti. Eravamo da soli. Eravamo insieme ad altri. Eravamo gli esclusi. Eravamo i marginali. (Sorride ancora. Sorride anche Gilles). Tu mi parlasti di Jean Genet. Ti dissi che anch’io rubavo i libri. Ti parlai di Sarah Kane. I lacci degli anfibi intorno al collo. Tutte quelle pillole. Ti parlai anche di Sylvia Plath. Il suicidio è una possibilità, ti dissi. Tu annuisti. Basta superare quel momento e si è salvi. Mi dicesti poi, guardandomi un po’ preoccupato, era come un suggerimento. A volte disegno o faccio altro, e passa, aggiunsi, abbassando lo sguardo. Forse ti sentisti sollevato. C’era un video di David Bowie. Mangiavamo in un bar per pochi soldi. Insalata di riso e Aperol. Cantava Life on Mars? Tu mi spiegasti che la fantascienza non c’entrava niente, quella canzone parlava di disagio familiare e di una trasmissione televisiva. Eravamo due disagiati. La televisione parlò di un altro attentato. Tanti morti per le strade di Parigi. E noi a fare queste cose, ti dissi. Ci pensavo spesso. Si può recitare in un teatro quando fuori si spara? Si può vivere una storia d’amore quando intorno a noi si muore? Ti domandai. Si può raccontarla? Eravamo un uomo e una donna senza risposte. Ti parlai anche di Michel Foucault e di Bernard-Marie Koltès, li leggevo di frequente in quel periodo. Ebbi un brivido. Oggi è un senso di spossatezza. Rende il pensiero languido e vago. Tu mi parlasti di Egon Schiele e di Wally Neuzil. Lui la lasciò per sposarsi. La lasciò per un ordinario matrimonio borghese. Mi raccontasti che quando lui fu incarcerato per una falsa accusa di corruzione di minorenne e per esposizione di disegni pornografici, gliene bruciarono uno in tribunale, lei non lo abbandonò un istante. E lui aveva abbandonato la sua modella preferita e la sua amante. Fummo d’accordo che fosse una cosa orribile. Decidemmo che avremmo fatto un lavoro teatrale sulla loro storia. Tu Egon e io Wally. Ma non avremmo parlato di quell’abbandono né delle loro morti precoci. Il pittore e la sua modella. Solo questo ora ci interessava. Due amanti. Eravamo scandalosi. Qualcuno se ne andò mentre recitavamo. Eravamo sfacciati. Eravamo timidi. Occupa case e ruba, c’era scritto su un muro. Concordammo che fosse giusto. Se ne avessimo avuto bisogno l’avremmo fatto. L’avevamo già fatto. A Place de la République la rivolta era finita. I poliziotti parlavano con le ragazze, fumavano, non badavano a noi. Eravamo rimasti in pochi. Sconfitti più dalla pioggia che non la smetteva da un mese che dalla repressione. Sotto le tende per non bagnarci troppo. Prima che partisse l’ultima corsa del métro la piazza si svuotò. Noi passeggiammo. Non pioveva più. Tu avevi una tua camicia che mi avevi portato per una scena che poi non facemmo. Ce la facciamo solo per noi due, che ci importa, ti dissi. Non tirasti fuori quella camicia. Serge Gainsbourg e Jane Birkin avrebbero ballato nella città deserta di notte. Forse l’avrebbero fatto anche Alain Bashung e Chloé Mons. Si innamorarono dopo un video di lui in cui lei recitava. Era ambientato di notte, in interni. Storie balorde. La loro invece fu una bella storia. Poi lui morì. E lei cantò le sue canzoni, con il grande seno e i capelli biondi. Le cantò per l’uomo che amava ancora. In fondo, pure loro erano due marginali. Anche se il telegiornale aprì l’edizione della sera con la notizia della sua morte, Alain Bashung è morto, fu il primo titolo. Tutta Parigi pianse. Piansi anch’io. La città sembrava uscita dal finale dell’Eclisse di Antonioni. I lampioni accesi, le vie vuote, i palazzi spenti. E noi. Mi piaceva ancora Antonioni. Avevo scritto una poesia. Mi dicesti che era molto bella. Era molto arrabbiata. Ero molto arrabbiata. Avrei voluto ascoltarla dalla tua voce, che ora non era più sconosciuta. Ma non te lo chiesi. E tu non tirasti fuori la camicia. Mi dicesti che era a righine. Maschile. So che mi sarebbe stata bene. Ti sarebbe piaciuto come mi stava. Solo la camicia e niente sotto. Parlavamo d’altro per non mettere fine al nostro incontro. Era troppo presto. Eravamo di nuovo soli. Eravamo io e te. Eravamo e poi non siamo stati più. Quell’abbraccio ci ha fregato. (Pausa). O che ne so. (L’occhio con la lente comincia a lacrimarle. Se lo asciuga. Sembrano le lacrime di un pianto malinconico e sommesso).
La polvere, mi sta graffiando la lente.
(Si guarda intorno nella hall. Adesso innervosita e come persa).
Le mie scarpe. Le mie scarpe, Gilles. Dove ho lasciato le mie scarpe? Aiutami a cercare le mie scarpe.
[1] Pubblicato su “Verde” del 12 giugno 2017.
 Giulia Pex, JG
Giulia Pex, JG
Sergio Gilles Lacavalla, lo sapete, è il più prolifico dei nostri collaboratori. Una volta al mese leggiamo le sue storie criminali, periodicamente i suoi attiunici:Jeanne e Gilles, che fa parte della serie Atti di vita e malavita (e contiene al suo interno una bellissima Rock Criminal bonus extra su Serge Gainsbourg), non è mai stato rappresentato in scena e debutta oggi su Verde con una illustrazione inedita della divinaGiulia Pex(inchino).
View original post 6.496 altre parole
Ascenseur pour l’échafaud [1]
New Orleans è abitata dal diavolo. Cambia spesso indirizzo e ama i luoghi occupati dai musicisti. Musicisti sconosciuti. Musicisti famosi. Glorie sul viale del tramonto e stelle emergenti. Non fa differenza. Quello che conta è il contratto che instaura con il suo inquilino. Spesso senza che l’interessato ne sia consapevole. Avviene così. Un giorno ti ritrovi coinvolto, ed è uno spasso, diciamolo, alcol, droga, sesso, a volte soldi, ore piccole e veloci, musica che sconvolge, sconvolge ogni cosa. E un altro sei morto o impazzito. Prendete Charles “Buddy” Bolden, bene, finì i suoi giorni al Louisiana State Insane Asylum di Jackson prigioniero della schizofrenia. Morì il 4 novembre del 1931 e fu seppellito all’Holt Cemetery, il cimitero dei poveri di New Orleans, con il diavolo che si giustificava dicendo che se non fosse stato per lui nessuno avrebbe, di fatto, inventato il jazz. Proprio così: merito della follia che gli aveva inoculato nel suo strumento, nota (che non sapeva leggere, ma si sa, il diavolo fa magie) dopo nota, dose dopo dose, bicchiere dopo bicchiere. Roba buona quella per i musicisti. Il jazz a New Orleans è dei posseduti. La musica è per gli invasati. È un amore intossicato, il diavolo a fare da terzo incomodo. Colui che dirige la relazione. Il rovina famiglie.
Quella del noto cantante di musica leggera italiano Al Bano Carrisi e di sua moglie, figlia della Hollywood più glamour, Romina Power, cantante anch’essa, fu incrinata dal dolore e dal vuoto, dai dubbi insopportabili per la scomparsa della primogenita Ylenia che non tornò più da un viaggio nella città della Louisiana. Appena arrivata, l’ultimo dell’anno del 1993, prese una stanza al Le Dale Hotel con un musicista di strada chiamato Alexander Masakela. Il 6 gennaio successivo, lasciò la camera e da allora nessuno l’ha più vista. A parte un testimone, Albert Cordova, guardiano notturno dell’Audubon Aquarium of the Americas all’1 di Canal St, che ha affermato di averla vista gettarsi quella sera dell’epifania, verso le undici e mezza, nel Mississippi e da lì non venire fuori. «Appartengo alle acque», sembra avesse detto Ylenia prima di lanciarsi nel fiume. Si disse ripetutamente, e lo pensò anche la polizia, che la colpa fosse di Masakela. Lui parlava con i demoni del Vudù. Non aveva bisogno della stupida bamboletta, la Dagida, su cui conficcare gli spilloni per fare un maleficio. La sua tromba evocava ogni spirito della distruzione. Sempre pieno di stupefacenti da donare alle giovani donne con cui si accompagnava. Fu denunciato da un’ex fidanzata per stupro. Aveva un’influenza negativa su chiunque. Ti manipolava. Ti soggiogava. E eri in trappola. Malgrado le brutte maniere, ti riusciva difficile stargli lontano. Il diavolo che alloggiò nell’albergo da 26 dollari a notte al 749 di St. Charles Avenue nel Quartiere Francese, si sedeva su un lato del letto e lasciava fare. Guardava. Anche Alexander Masakela sparì nel nulla di New Orleans, la città con il più alto numero di casi di scomparsi negli Stati Uniti. La sua parte l’aveva fatta. E bene. Non c’è che dire.
Il diavolo ha una predilezione per le sordide stanze d’hotel della Vieux Carré. Il 23 aprile del 1991 prese la chiave della camera numero 37 della St. Peter’s House, al 1005 dell’omonima strada, e si godé la morte del rocker Johnny Thunders, ormai ridotto a uno zombi dalla tossicodipendenza. New Orleans, in quanto a morti viventi, è il posto ideale. L’ex New York Dolls e Heartbreakers tirò le cuoia con un’overdose d’acido in vena e metadone. Lo trovarono piegato in due tra le fialette vuote di quest’ultimo sul pavimento, ore dopo che una cameriera dell’albergo dagli esterni cremisi l’aveva sentito gridare cose insensate in preda alle allucinazioni. Il diavolo non rispondeva alle urla e gli ficcava la testa nel fondo delle sue mostruose visioni. L’anticamera dell’Inferno. Sable Starr, la sua ex ragazza, luccicava con un occhio nero e un labbro spaccato, senza un dente, il sangue le colava dalla bocca. Se ne stava lì a scopare con chiunque e lui non riusciva a capire chi fossero i suoi amanti e la riempiva di lividi, lei allora fotteva ancora di più, con frenesia e divertimento ridendogli in faccia, piangendogli in faccia, venendogli in faccia e abortiva il loro bambino intanto che lui le strappava l’agenda con gli indirizzi di tutte le rockstar che si era fatta, che se l’erano fatta, una pagina alla volta e lei gli sputava sul viso il sangue diventato un fiume, gli riempiva la gola, sembrava avesse il sapore degli orgasmi della reginetta delle groupie. Sable Starr sporca e sgualcita gli diceva di leccarlo, di leccarlo ovunque, sulla bocca, sugli zigomi, dalla fronte, strabordava dalle vene aperte dei polsi e si mischiava al fiume di umori e urina, se la faceva sotto con disprezzo e senza nessun controllo, piangeva e rideva e gli urinava addosso droga e sofferenza per averla ridotta così. «Guarda come mi hai ridotta, sarai contento ora!» «Non volevo. Io ti amavo. Perdonami, Sable amore mio». Ma lei non lo ascoltava e gli distruggeva la Gibson Sunburst del ’57. Gli occhi sbrodolavano mascara nerissimo, mentre si masturbava con un pezzo della chitarra fino a lacerarsi il sesso. Il mascara stava rendendo tutto buio: c’era solo l’odore di fiume, sangue, droga, make up scaduto, profumo da quattro soldi, piacere marcio, urina e paura.
Ci fu chi parlò di suicidio. Forse l’overdose fu solo accidentale. O magari si trattò di un omicidio nel giro degli spacciatori che l’avevano ammazzato con la roba, facendogli passare l’acido sbriciolato per cocaina da farsi in vena. Non avevano altro da dargli e dovevano pur vendergli qualcosa. E lui era andato fuori di brutto e si era fatto il metadone per uscire da quello stato, tanto metadone, peggio dell’eroina, ma senza capacità di controllo nel dosaggio. Ucciso perché aveva molti soldi dietro ed era uno straniero; si disse che avesse con sé diecimila o ventimila dollari. Furono trovati sparsi nella stanza solo pochi spiccioli e qualche banconota, alcune giapponesi del suo recente per una volta fortunato tour in Estremo Oriente. Secondo Dee Dee Ramone gli avevano iniettato l’LSD per rubargli le scorte di metadone che si era portato dietro perché stava provando a disintossicarsi un’altra volta, dopo due fallimentari ricoveri nella clinica di Halzenden. Era arrivato quel giorno a New Orleans per stare lontano dal suo abituale giro di spaccio newyorkese e con l’intento di mettere su una band locale con la quale registrare un disco acustico di blues. Che ingenuo. Che stupido. Come se non sapesse che lì era domiciliato il diavolo. Willy DeVille, che abitava a pochi passi da là, appena a due vie di distanza dalla centrale Bourbon Street, fu chiamato per liberare la stanza del suo amico, dopo che la polizia e l’ufficio del coroner avevano fatto portare via il cadavere già in avanzato rigor mortis. Non si accorse del diavolo – ma probabilmente se ne era già andato, cosa ci stava a fare ancora lì?
Il diavolo che a Willy DeVille aveva tolto i denti con l’eroina e gli ucciderà l’amore. Lo inseguirà fino alle Cerrillos Hills nel New Mexico per portargli via la seconda moglie. Lisa Leggett si impiccherà nel 2001: non aveva resistito al tradimento del marito con quella che sarebbe diventata la sua terza consorte, Nina Lagerwall. Il rimorso. La corsa di Willy in macchina verso il burrone più ripido e più blu delle colline minerarie del Nuovo Messico e un camion che lo ferma in uno schianto sulla fiancata dell’automobile rompendogli un braccio e un ginocchio. Il diavolo aveva deciso che non era ancora il momento di pagare il conto. Si ricorderà di lui uccidendolo per mezzo di un cancro al pancreas la notte del 6 agosto del 2009 in un ospedale di New York. Willy ripensò fino all’ultimo ai suoi amori andati a male e gli venne in mente, in un amaro sorriso, anche quello mai realizzato di Johnny Thunders con Bebe Buell. Non se l’era mai scopata, gli confidava Thunders con malinconica rassegnazione. E lei, sul suo cadavere nella bara prima della sepoltura, alla veglia funebre, glielo rimproverava allo stesso modo di una sera di poco tempo prima al Limelight quando gli disse: «Perché non l’hai fatto con me, eh Johnny? Perché non l’abbiamo mai fatto?» E lui le rispondeva che erano sempre in tempo, no? Anche se lei lo sapeva che ormai era tardi. Ne erano coscienti entrambi. Forse Johnny era anche malato di leucemia, e della tristezza del fallito. “Be’, è proprio così che vanno le cose. Questa città è così fredda. E io sto… sto così così. Ecco perché lo so (dico hey), sono nato per perdere. Nato per perdere. Baby, io sono nato per perdere. Niente da fare. Niente da dire”, aveva cantato in “Born To Lose”. Sì, non c’era altro da dire. L’inferno è il rimpianto. Al diavolo piace farti giocare male le tue carte. Ama i perdenti e ti trova ovunque tu ti nasconda.
La mattina di sabato 21 ottobre 1995 va a trovare Shannon Hoon, che con i Blind Melon avrebbe dovuto suonare la sera stessa al Tipitina’s al 501 di Napoleon Ave. Anche lui era appena arrivato a New Orleans. Nonostante una fidanzata, Lisa Crouse, e una figlia, Nico Blue, splendide, preferì la compagnia della cocaina gentilmente offerta dal demone della Louisiana. Lui ti dà soltanto amanti da amare fino alla fine. Quella fu la fine. L’ingegnere del suono del gruppo, Lyle Eaves, lo trovò morto per overdose sul tour bus. Qualcuno ha detto di aver visto la buffa ragazzina vestita da apetta sulla cover del primo disco della band e che danzava per le strade e i prati nel video di “No Rain”, togliersi gli occhiali e sedersi sul prato a piangere. Intanto che il diavolo cercava un altro indirizzo utile.
Manicomi, stanze d’albergo, case, camper. A un certo punto serviva un intero quartiere da abitare e dal quale guardare la città. Già dagli anni Quaranta del novecento l’assessorato all’urbanistica aveva provveduto a edificare quello che sarà chiamato Magnolia Project, un capolavoro di degrado e criminalità che vedrà sul finire degli anni Novanta e i primi del Duemila il suo massimo splendore di violenza e morte. C’era da sguazzarci tra Glock, stupefacenti e musica rap. Situato su Central City nell’Uptown di New Orleans, chiuso tra Louisiana Avenue, South Claiborne Avenue, La Salle Street e Washington Avenue, il quartiere vide la discesa del suo Johnny Favorite, o, se volete, del suo Harry Angel, nelle sembianze di Garelle Smith.
“L’uomo senza testimoni ha ucciso ancora”, intitolarono i giornali al suo quarto omicidio. Il primo fu quello del più importante rapper del Magnolia, James Adarryl Tapp Jr., in arte Soulja Slim. Al diavolo piace scherzare e per la sua morte scelse il Giorno del Ringraziamento, la festa americana più sacra e timorata di Dio. È il 26 novembre del 2003 e Soulja Slim viene colpito da tre proiettili al volto e uno al torace davanti alla casa che aveva comprato alla madre, Linda Porter Tapp, e al patrigno, Phillip “Tuba Phil” Frazier della Rebirth Brass Band, una celebrità a New Orleans, al 4600 di Lafaye St. nel quartiere di Gentilly. Proprio adesso che con il rap stava facendo i soldi, ormai era un nome nell’ambiente del dirty south, e si teneva lontano dall’eroina, dalla cocaina e dai guai che gli avevano procurato cinque anni di carcere per rapina a mano armata, furto d’auto, spaccio di droga, violazione della libertà vigilata e due attentati dai quali era uscito con cicatrici al torace, alle braccia e a una gamba. Non si è mai saputo chi gli sparò. Non era di certo stato Garelle Smith. Lui aveva dalla sua il diavolo che non gli faceva sprecare un colpo. Alle cinque e quarantacinque del mattino, al ritorno da una serata in un club cittadino, Soulja Slim si ritrovò senza la propria pistola dimenticata nel SUV e con quella del sicario puntata davanti che esplose i suoi colpi. Garelle Smith se ne andò con diecimila dollari in tasca (il prezzo della commissione della quale non si saprà mai il committente) e nuovi incarichi. Un altro rapper, anche se di minore caratura, sarebbe rimasto vittima dei suoi proiettili. Spencer “Funk” Smith Jr. sarà freddato lo stesso anno con le stesse modalità. L’11 dicembre il suo corpo martoriato da numerosi colpi di arma da fuoco sarà rinvenuto accasciato sul sedile di un furgoncino sulla St. Bernard Avenue. Medesima sorte quattro anni dopo per un altro rapper – a essere precisi sarebbe meglio dire aspirante rapper – e spacciatore di professione, Mandell Duplessis, trovato trucidato il 4 agosto ancora a Gentilly, e per Terry Brock, un ventiduenne che il 2 aprile uscendo dal Duck Off Nightclub su AP Tureaud Avenue fu investito da una raffica di pallottole. Non si è mai capita la vera ragione di questi omicidi. Si parlò di rivalità nell’ambiente dell’hip-hop, ma nessuna in grado di giustificare tanta violenza. Il gangsta rap di New Orleans, almeno quello rappresentato dalle vittime, non era al livello economico e di successo di quello della West Coast e di quello della East Coast, l’astio tra le etichette del southern rap non si poteva paragonare alla faida tra la Death Row Records e la Bad Boy Records culminata con gli assassini delle due superstar Tupac Shakur e Notorious B.I.G. Voglia di emulazione di un recente passato che proprio nella morte era già diventato leggenda? Possibile. Quando canti ripetutamente di pistole e omicidi di negri e bang! bang!, puoi anche aspettartelo, dissero in molti. Rancori nel giro della criminalità da cui non ci si riusciva a sottrarre? Forse. Garelle Smith ogni volta verrà arrestato per omicidio e poi rilasciato perché su di lui il New Orleans Police Department non troverà mai nessuna prova certa né testimoni. Garelle Smith è invisibile. Si muove nella città deserta. Ha superato indenne l’uragano Katrina. Garelle Smith è colpevole, è cosa risaputa. Ma la giustizia di New Orleans riesce solamente a incriminarlo per altri reati come porto abusivo d’armi, droga e violazione di domicilio e della libertà vigilata, e anche in questi casi dovrà farlo uscire di prigione dopo breve tempo. “La polizia e il sistema giudiziario sono inetti, questo è il motivo”, accusarono molti quotidiani. Ci penserà il diavolo a mettere le cose a posto. Sabato 15 agosto 2011, gli agenti della omicidi trovano, riverso sull’asfalto di Hamburg Street, Garelle Smith ucciso da alcuni colpi di pistola sparati al viso e al petto. Proprio come Soulja Slim. Nello stesso quartiere. Voleva diventare anche lui un rapper. Nessun testimone. Il gioco del diavolo è chiaro, no?
[1] Pubblicato su “Verde” del 15 maggio 2017.
 Demonia, Pistola
Demonia, Pistola
Charles “Buddy” Bolden, Ylenia Carrisi, Alexander Masakela, Johnny Thunders, Willy DeVille, Shannon Hoon, Soulja Slim e Garrelle Smith hanno in comune New Orleans, la città del diavolo. E il gioco del diavolo è chiaro, no? Solo Demonia poteva illustrare la nuova puntata di Rock Criminal, la rubrica di Sergio Gilles Lacavalla dedicata alle storie nere del rock e dintorni.
View original post 2.428 altre parole
Amor Prohibido [1]
La donna barricata nel furgone rosso è un’assassina ed è grassa. Avrebbe voluto essere come lei, la sua vittima: vita esile, fianchi e cosce torniti, culo alto e tondo da far girare la testa e il resto della giusta misura. Invece, guarda là: bassa e sovrappeso. Nessuno si sarebbe voltato per lei, se non per deriderla. Nessuno l’avrebbe applaudita. Niente lettere d’amore. Era inutile, i fianchi non si snellivano, la pancia strabordava, le gambe erano più larghe che lunghe e il sedere, beh, il sedere non aveva proprio forma. Eppure aveva provato tante volte a mettersi a dieta, a fare un po’ di moto, insomma, a migliorare la propria condizione fisica. Fino a farne un’ossessione. Si era anche diplomata da infermiera per ottenere quelle conoscenze di medicina che l’avrebbero aiutata, magari a sposare un bel chirurgo estetico che sapesse cosa fare del suo sgraziato corpo. Ma era finita a esercitare la professione in qualche ospedale e a domicilio per i malati terminali di cancro. Sai che allegria. Non c’era stato niente da fare. La sfortuna e la genetica erano quelle che erano. Selena Quintanilla-Pérez, per i fan latinoamericani e il mercato discografico solo Selena, era sempre stata bellissima. Yolanda Saldívar non aveva mai avuto una stagione di bellezza. Selena aveva sposato Chris Pérez, l’avvenente chitarrista della sua band, i Selena y Los Dinos. La donna dentro il pick-up GMC bloccato nel parcheggio del motel Days Inn, tenuto sotto tiro dalla polizia e dalle emittenti televisive texane e messicane, è sola, non stacca la Taurus modello 85 dalla sua tempia e pensa che anche alla tv verrà bassa e grassa. Certo, era il suo momento di celebrità, sempre all’ombra della regina della musica tejano, sempre e soltanto la presidentessa del suo fan club e manager dei suoi due negozi di abbigliamento e istituti di bellezza di Corpus Christi e San Antonio, ma per questa occasione avrebbe voluto apparire un po’ meglio, almeno truccata bene, quel tanto da toglierle il sottomento, illuminarle il volto, un’espressione meno arcigna e meno rughe. Un abito che la snellisse. (Sì, come se dopo un omicidio ti danno il truccatore e lo stilista, neanche a dire che poteva portarseli dietro dalle boutique che dirigeva: dalla Selena Etc. era stata licenziata con infamia tre settimane prima, e poi, comunque, quando aveva provato qualche trattamento, non è che avesse avuto tutto questo successo). Vorrebbe che i telespettatori non vedessero chiari nel suo aspetto i motivi dell’omicidio. Poiché è consapevole che quando si arrenderà, le telecamere saranno impietose. Allora non potrà fare nulla per nascondere il fatto che ha ucciso perché è una donna invidiosa e gelosa: se non poteva avere l’avvenenza, la gloria e l’amore, l’amore incondizionato, sconfinato ed eterno di tutta la popolazione latina del Texas e del Messico, della sua mai stata sua Selena, almeno poteva rubarle i soldi e il potere sulle attività commerciali. Era un modo per possedere qualcosa della donna che più ammirava al mondo. E Selena l’aveva cacciata dalla sua splendente vita. Le avrebbe rubato pure la vita.
Piove, il 31 marzo del 1995. È venerdì santo e quella è la passione di Yolanda Saldívar, la sua Via Crucis lunga otto ore a Corpus Christi, Texas. I fan della cantante piangono, pregano e cantano le sue canzoni come un triste, disperato rosario, le radio locali e nazionali interrompono la normale programmazione per mandare la sua musica e lei urla alla SWAT e alla CNU dell’FBI, radunate dall’altra parte della strada davanti alla stazione di servizio Exxon, che si ucciderà se… Se cosa? Non lo sa nemmeno lei. Sa che non le lasceranno la via aperta sull’highway Interstate 37 che porta all’aeroporto internazionale. Sa che se tenterà di scappare, gli agenti scelti saranno capaci di piantarle un proiettile in testa al suo posto – anche se vorrebbero prenderla viva per esibire nei tg l’assassina della più grande cantante Tex-Mex della storia. Ma anche lei non vuole morire. Prolunga l’assedio perché è troppo bello e drammatico essere in diretta.
Aveva dato appuntamento a Selena nel motel su Navigation Boulevard. L’aspetta, seduta sul letto. Voleva vederla a tutti i costi.
«Ti prego», le aveva detto. «Ti prego. Un’ultima volta».
Selena accetta di incontrarla solo per risolvere le questioni finanziare rimaste in sospeso; non aveva nessuna voglia di ascoltare i suoi piagnistei, di sentire altro. Solo per questo si trova nella stanza dell’hotel sull’autostrada.
«Stai lontana da lei», l’aveva avvisata il padre, Abraham Quintanilla Jr. «Può farti del male, più di quanto te ne abbia già fatto».
L’arma nella borsetta, da usare in qualche modo. Forse Yolanda ha già deciso come. Forse no. Forse vuole usarla per convincerla a ritirare il suo licenziamento. A tenerla ancora con sé. Le racconta nei dettagli della violenza sessuale subita due giorni prima a Monterrey, perpetrata da chi non si sa. L’aveva già confessata a Ricardo Martinez, un chirurgo plastico che stava aiutando Selena ad aprire un altro negozio nella città messicana dove risiedeva e dove la Saldívar sosteneva fosse avvenuto il fatto – «Le mandava dei fiori», dirà Yolanda. «Non era solo un rapporto di lavoro». Muore di gelosia. Ne parla prima a lui pensando che possa convincere Selena a incontrarla, visto che Selena non vuole più comunicare con lei; il dottore non le dà retta e chiude bruscamente la chiamata. Non le resta che provarci direttamente. Al telefono le dice per la prima volta della violenza, singhiozza, appare turbata, confusa, ma il marito di Selena non vuole che parli più con quella donna e, soprattutto, che la incontri la sera stessa, a tarda ora, come le supplicava di fare Yolanda, né in qualunque altro momento. Non si fida. Nessuno dei due crede allo stupro. Tutta la famiglia Quintanilla è ostile nei suoi confronti. Le dice di attaccare.
«Alle sette e mezza. Ti aspetto domani mattina alle sette e mezza al Days Inn, ok?», conclude Yolanda.
«Non lo so… porta i documenti», le risponde Selena.
La notte non riesce a dormire. Alle sette e trenta, senza aver detto niente a Chris Pérez, si presenta nel luogo stabilito accompagnata dallo stilista della sua griffe Carlos Morales.
«Chiudiamo la questione economica e poi ognuna per conto suo», le dice Selena, decisa e sbrigativa.
La colazione sul tavolo. Intatta.
«Bevi almeno il caffè o un succo di frutta».
«No, grazie, non prendo niente».
Risulta lampante che la storia della violenza in territorio messicano, della quale Yolanda ha ripreso a parlare, insiste lamentosa, si mostra ancora sconvolta e accusa dolori al basso ventre, è una goffa menzogna creata per impietosirla e perdere tempo, distrarla. Yolanda non tira fuori le carte contabili. Non le restituisce la carta di credito. Non la smette di compiangersi. Selena l’accompagna al vicino ospedale per una visita e farla finita una volta per tutte con quella balla.
«Dai, vediamo davvero come stai. Adesso vieni con me».
La dottoressa che la visita non trova nessuna traccia di stupro. Solo un forte stato depressivo e un paio di lividi che poteva esserseli provocati in qualunque modo.
«Aveva ripreso a sanguinare. La mia vagina, a sanguinare per le lacerazioni», ripete la Saldívar, nonostante l’evidenza della sua bugia. La dottoressa scuote la testa e non sa che dire. Tornano all’albergo, perché adesso Selena pretende i documenti tutti e subito. Ci sono anche dei campioni di profumo da restituire, reclama pure quelli.
«Avanti».
Yolanda le dice che la sua sfiducia è ingiusta, ingiusto il suo tono, le dice che per lei aveva fatto tutto, aveva portato il suo fan club a essere il più importante che un’artista di origini messicane avesse mai avuto. Aveva contribuito come nessun altro al successo dei suoi negozi. Aveva rinunciato alla sua carriera nell’ambito medico e all’amore di un uomo per amare lei, solo lei, la sua stella brillante nel cielo del Texas e nel suo immenso cuore.
Ma no, invece no e no, non aveva fatto niente di tutto ciò, la rimprovera Selena. Aveva sottratto oltre sessantamila dollari dalla Selena Etc. e dal fan club, ne aveva le prove, alza la voce. Aveva falsificato assegni, aveva licenziato molti dei dipendenti delle boutique perché sospettavano delle sue attività illegali (dubitavano di una donna coinvolta in passato in questioni analoghe ai danni di due ospedali), o solo perché non sopportava come la guardavano, come guardavano lei, la sua padrona, il suo amore, solo suo, lo notavano tutti che Yolanda ne era innamorata, «quella lesbica schifosa», come sembra l’avesse definita Quintanilla Jr. Per l’affetto e le attenzioni che lei ricambiava, per la loro dedizione. Tutto era partito dalle indagini fatte proprio da Abraham Quintanilla Jr., manager di Selena e fondatore della prima formazione dei Los Dinos, in seguito alle proteste di molti fan che avevano pagato la quota associativa al fan club senza aver mai ricevuto i gadget che questa prevedeva, e ai racconti di Morales sul suo comportamento in negozio. Da lì a verificare i bilanci delle società fu facile. Un danno di immagine, oltre che economico. Ecco cosa aveva provocato Yolanda l’ingrata. Yolanda Saldívar era una ladra, una truffatrice, un’infedele, una bugiarda. Non meritava niente, se non di finire in prigione. Ma Selena frena la furia del padre e rinuncia a denunciarla in cambio dei documenti, dei campioni di prova di un nuovo profumo da lei sottratti e di non vederla più. Soprattutto questo. Mai più. Fu quel mai più che a Yolanda fece tirare fuori dalla borsa il revolver.
«Avevo portato la pistola perché se Selena non mi avesse creduto mi sarei ammazzata davanti ai suoi occhi. Sì, Vostro Onore, volevo farla finita. Non potevo sopportare quelle calunnie. L’odio di una ragazza alla quale avevo dato tutto e che ora mi scaricava in quel modo», dirà in tribunale. «Poi stava andando via, io l’ho pregata di rimanere, la pistola ancora in pugno, verso di lei, non so perché verso di lei, forse indicavo la porta e… è partito un colpo, non so come».
Il colpo è un proiettile calibro.38 a punta cava, che provoca danni irreparabili. Si conficca nella clavicola destra di Selena, sparato alle sue spalle mentre la cantante sta aprendo la porta rossa della camera per fuggire. Esce. Per circa centoventi metri, attraverso lo spiazzale con le aiuole dell’albergo, si trascina in una lunga scia di sangue che sembra un sinistro strascico di un abito da sposa, per raggiungere la hall. Qui cade a terra. Riesce a dire che la donna della stanza 158 le ha sparato, riferirà in tribunale la vicedirettrice del motel Rosalinda Gonzalez. Sono le undici e quarantanove del mattino. Viene soccorsa subito da Carlos Morales che l’aspettava in macchina ed era accorso sentendo le urla provenire dalla camera e lo sparo. La direttrice generale dell’hotel, Barbara Schultz, chiede alla receptionist Shawna Vela di chiamare il 911. Shawna sta per vomitare per tutto quel sangue. Il direttore alle vendite del motel Ruben DeLeon tenta con ciò che ha sotto mano di tamponare la ferita. Selena gli dice il nome della sua assassina tuffandolo nel sangue. Il sangue è un fiume in piena, travolge tutto: l’incantevole voce di Selena che ce la fa ancora a sussurrare un debole e spaventato «Aiuto, mi sparerà di nuovo, chiudete la porta», poi il suo sguardo che si fa assente, si perde lontano, oltre il momento, oltre il motel, oltre il Texas, oltre i ricordi, oltre i motivi, i suoi sensi che se ne vanno trascinati come una barchetta di carta su un affluente diretto impetuoso verso il mare, fino alla sua luminosa, al punto da accecare, bellissima e tragica vita. L’ambulanza. Un paramedico, Richard Fredrickson, sentendole il battito cardiaco sul collo, capisce subito che non c’è più niente da fare. Ci prova comunque. Le toglie il maglione verde con il quale cerca di rallentare l’emorragia, le applica un tampone di vasellina mentre un altro infermiere tenta un massaggio cardiaco, poi un’endovena, ma l’ago scivola fuori, spazzato via da tutto quel sangue che la sta svuotando rendendola una bambola floscia. Dalla spalla ai piedi. Arrivata al Corpus Christi Memorial Hospital alle dodici, per circa un’ora i medici, guidati dal dottor Louis Elkins, fanno di tutto per ripristinare il sangue perduto e riparare i danni: la clavicola è distrutta, un polmone danneggiato in maniera irreversibile e l’arteria succlavia destra è stata recisa in due. Provano anche ad agire direttamente sul muscolo cardiaco aprendole il torace, ma è un ultimo tentativo disperato. Come tutto il resto, si sapeva. Concitazione, rabbia e lacrime per quella vita di ventitré anni che se ne va dissanguata all’una e zero cinque del pomeriggio.
La donna sul furgone rosso ancora non sa che Selena è morta. A ogni minimo movimento della polizia verso di lei, si porta la pistola alla tempia, ma non si spara. I due negoziatori dell’FBI, Larry Young e Isaac Valencia, cercano di convincerla a gettare l’arma e a uscire con le mani alzate bene in vista. Fino alla sera alle otto, Yolanda Saldívar minaccia di spararsi, e non si spara.
«Perché non l’ha fatto? Perché frignava di voler morire e poi aveva paura che la polizia le sparasse?» Farà notare in tribunale il procuratore distrettuale capo Carlos Valdez. «Perché, se come dice la signora Saldívar, non voleva fare del male alla sua amica ma solo a se stessa, non l’ha prontamente soccorsa? Eppure la signora Yolanda Saldívar è un’infermiera professionista. Non ha neanche chiamato il numero d’emergenza. No, signori giurati. Non credete a questa donna bugiarda che si è inventata uno stupro. Guardate questi vestiti: sono gli abiti che l’imputata indossava il giorno della presunta violenza. Bene, i periti hanno provato che sono stati strappati intenzionalmente e non in un atto come quello raccontato dall’imputata. Sicuramente ha provveduto lei stessa a strapparli. Ma d’altronde la signora Saldívar ha anche accusato in aula il padre della vittima di aver abusato sessualmente di lei più volte e di averla minacciata, puntandole un coltello alla vagina, che l’avrebbe uccisa se fosse andata alla polizia».
La giuria guardò interdetta verso l’accusata: c’era da ridere.
«Vi ricordo che la signora Norma Marie Martinez, cameriera del motel», continuò il procuratore distrettuale, «ha testimoniato di averla vista inseguire Selena Quintanilla-Pérez dopo lo sparo, con l’intenzione di premere ancora il grilletto, la pistola puntata, poi ha desistito, accorgendosi che qualcuno la stava osservando, ed è tornata nella sua stanza. Le urlava dietro “puttana”! Questo le diceva. Le gridava “puttana” e avrebbe voluto finirla».
Yolanda sa che il processo sarà un altro momento di celebrità. Per quell’occasione si sarebbe vestita bene. Forse avrebbe perso un po’ di peso. Si sarebbe sistemata i capelli. C’è il parrucchiere in prigione? Le televisioni avrebbero messo le luci giuste. Non come in quel parcheggio allagato di pioggia con le sirene e i fari così fastidiosi. Avrebbero guardato tutti lei e non più Selena. Sarebbe stata la voce di Selena. Il sinistro ricordo della cantante stampato sulla sua brutta faccia maya. L’avrebbe posseduta per sempre.
Poi avrebbe rilasciato interviste dal carcere alle maggiori emittenti di lingua spagnola. Raccontando verità irrivelabili, come il rapporto extraconiugale tra Selena e il fascinoso chirurgo estetico consumato in sordide stanze d’hotel. False identità. Occhiali scuri e parrucca per non farsi riconoscere. L’“Amor Prohibido”. Avrebbe detto che in realtà la lite, quella disgraziata mattina, era avvenuta proprio per via di quella relazione segreta di cui lei era la sola a essere a conoscenza, per un po’ le aveva retto il gioco, ma ora la cosa si stava facendo seria e pericolosa.
«Sei sposata, figliola. Anche lui è un uomo sposato. Ma che stai facendo, Selena?».
E Selena non voleva ascoltarla. Urlava e rispondeva che era una ladra, come l’aveva convinta il padre per non perdere il controllo sulla figlia, sempre più indipendente, sempre più legata a lei, la sua unica fedele amica, un padre che la costringeva a subire chissà quali inconfessabili atrocità. Come aveva fatto a lei. Sì, avrebbe raccontato una storia del genere. Agli ispanici sono sempre piaciute le telenovela. Ogni tanto avrebbe pianto, mantenendo il controllo, non voleva apparire una squilibrata, ma solo una vittima, anche lei. E avrebbe continuato a sostenere che era stato un incidente. Nient’altro che un maledetto incidente. Il tutto sarebbe andato in onda in prima serata. In prigione c’è la tv.
Il 23 ottobre 1995, Yolanda Saldívar sarà riconosciuta, dalla giuria del tribunale della Contea di Harris a Houston composta da sette bianchi, quattro ispanici e un afro-americano e presieduta dal giudice Mike Westergren, colpevole di omicidio di primo grado e condannata all’ergastolo, senza possibilità di richiedere la libertà vigilata prima di trent’anni. Nelle carceri femminili texane di Gatesville Unit e Mountain View Unit nella contea di Coryell, sarà tenuta sempre in isolamento per timore di ritorsioni da parte della comunità carceraria ispanica e delle detenute affiliate alla mafia messicana, che ha messo una taglia sulla sua testa.
Nove giorni dopo il funerale, il governatore del Texas e futuro presidente degli Stati Uniti d’America, George W. Bush, dichiarerà il 16 aprile, giorno della nascita di Selena, il Selena Day.
Tra gli ispanoamericani del Texas, il nome Selena è stato il più usato per battezzare le bambine nate dopo la sua morte.
Il giornalista John Lannert di Billboard ha detto che con lei è morta la musica tejano.
Selena riposa in una tomba con la sua effigie al Seaside Memorial Park di Corpus Christi. In tanti vi portano ogni giorno dei fiori. Molti hanno scritto frasi d’amore e disegnato cuori per lei sulla porta rossa della stanza 158.
Nel 2002, su ordine del tribunale, il revolver usato per uccidere Selena è stato smontato in ogni parte e gettato nella Corpus Christi Bay.
In prigione, Yolanda Saldívar si è laureata in giurisprudenza per preparare la richiesta della libertà vigilata anticipata; mai accolta. Non è dimagrita.
[1] Pubblicato su “Verde” del 17 aprile 2017.
 Momusso, Se potessi eliminare qualcosa che ti rende pesante, di cosa vorresti liberarti?
Momusso, Se potessi eliminare qualcosa che ti rende pesante, di cosa vorresti liberarti?
Il 16 aprile 1971, a Lake Jackson (Brazoria, Texas), nasceva Selena Quintanilla-Pérez. Dal 1995, nello stesso giorno, si festeggia il Selena Day, per celebrare “The Tejano Madonna”, l’icona più popolare e di successo della musica latina degli anni Novanta, assassinata a soli 23 anni da Yolanda Saldívar, la Mark Chapman della Tex Mex music. Rock Criminal, la rubrica di Sergio Gilles Lacavalla dedicata alle storie nere del rock e (dei sempre più ampi) dintorni, è alla ventiduesima superba puntata.
L’illustrazione è di Momusso.
View original post 2.940 altre parole
Cuba libre[1]
«No, Chano, qui non siamo a L’Avana. Qui non contiamo nulla. Noi orisha non siamo che poveri disgraziati. Anche tu sei un povero disgraziato. La Santeria, a New York, è soltanto superstizione. E tu sei solo un negro. Come sempre».
«Ti sbagli: io sono Chano Pozo e suono con Dizzy Gillespie».
In effetti, Chano Pozo suonava con l’inventore del bebop, che l’aveva definito: «Il miglior percussionista che abbia mai ascoltato». E aveva tutti i motivi per vantarsene. Ma questo non vuol dire niente quando ti riempiono di piombo: sette colpi di pistola, così, senza tanti riguardi. Come l’ultimo dei negri, di quelli che entrano nei locali dalla porta di servizio. Che negli stati del sud sugli autobus siedono dietro. Di quelli che crepano agli angoli delle strade di Harlem, in sordidi bar. E perlopiù da parte di un gangster da quattro soldi. Un misero boss schernito con il soprannome di “El Cabito”: Eusebio Munoz, un “piccolo caporale” che tirava avanti raccogliendo scommesse clandestine e spacciando erba di pessima qualità. Come copertura, un’attività di riparatore di apparecchi radiofonici. Figuriamoci. Insomma, il più grande percussionista afrocubano sbarcato negli Stati Uniti, l’attrazione de La Conga, la grande sala da ballo di Broadway all’angolo della Cinquantunesima, colui che aveva indirizzato Gillespie verso il latin jazz e suonato alla Carnegie Hall sulla Settima Strada, dove si erano esibiti George Gershwin, Benny Goodman e Duke Ellington, per dirne alcuni, officiante dei sacri riti della Santeria, fatto fuori da una nullità di allibratore alla vigilia di Santa Barbara, sua protettrice; che ridere.
«Stai morendo. Chano, tu stai morendo. Mi senti? Quanto ti manca ancora? Eh? È questione di attimi. Fattene una ragione. Chiedi perdono dei tuoi peccati». (E ne aveva più di qualcuno da farsi perdonare: l’omicidio, anche se sembra accidentale, di un turista in patria e furti, minacce e aggressioni, ma nel quartiere povero e malfamato di El África, dove viveva in gioventù, c’era poco da andare per il sottile, dovevi sopravvivere, quello era il modo). «Torna in stato di grazia, Chano, e ci si rivede di là. Ormai io non posso farci più niente. Mi spiace».
«Aspetta un momento. Non credere di cavartela così. Mi spiace, ma certo; tutto qui?», disse Chano, ansimando. «Ricordati che tu senza di me non esisti. Ti rendi conto che se sei qui è solo grazie a me? Sono stati i miei tamburi a evocarti».
Era vero. L’orisha Changò, colui che rappresenta tutte le doti e i difetti del maschio, santo della virilità, della guerra, del fuoco e del tuono, della musica e della danza, sincretizzato con quella femmina guerriera di Santa Barbara, si era materializzato grazie ai tamburi batá di Chano, che l’aveva preso come orisha guida. Luciano “Chano” Pozo González era un maestro in queste cose e aveva conquistato una certa fama a Cuba nel giro della Regla de Ocha e nelle cerimonie dell’hacerse el santo, quando l’orisha prende possesso della tua essenza terrena. Ma al 25 di Lenox Avenue anche i santi si scordano di essere tali. Il futuro da predire è solo uno stupido gioco su una tavoletta di legno circolare.
Chano ancora sperava che il suo santo protettore lo avrebbe salvato come quella volta, anni prima, a L’Avana: alla Società degli Autori, gli spararono quattro colpi per una questione di diritti d’autore non pagati che lui reclamava; due proiettili gli si ficcarono alla base della spina dorsale. Poteva rimanere paralizzato, addirittura morire, e invece, a parte qualche doloretto quando cambiava il tempo e stava troppo in piedi e un’andatura leggermente protesa in avanti, quasi fosse sempre sul punto di attaccare, a volte intimoriva, altre era divertente, ne uscì illeso e forte come prima. Ringraziò con generose offerte e devozione eterna. Era devoto, grande e forte, Chano. Fortissimo, tanto da essere assunto dal losco uomo d’affari cubano Alfredo Suárez come guardia del corpo, autista ed esattore. Fortissimo da vincere ogni scontro nel circuito dei combattimenti più o meno legali de L’Avana. Il sole dei Caraibi attenuava qualsiasi dolore e lo rendeva invincibile. Ma a New York fa freddo a dicembre. E il freddo non aiuta. Sembra spaccarti le ossa. La schiena in certi giorni si blocca. Eppure Chano continua a sentirsi forte. Fortissimo. Anche quando prende per il bavero Eusebio Munoz e lo insulta, lo minaccia di fracassargli quella brutta faccia da cazzo che si ritrova se non gli ridà indietro i suoi soldi, buttati via per venticinque schifosissime sigarette di marijuana che “El Cabito” gli aveva venduto la sera prima al La Palma. Più che di erba sembravano fatte di origano. E a Chano mica lo freghi. Lui ha bisogno di quella roba che lenisce i dolori. Lui non si fa prendere in giro da nessuno. Quando riscuoteva i debiti per Suárez, fratturava braccia e gambe come niente fosse se non pagavi, e subito. Capitava anche se pagavi, tanto per dare l’esempio e per il disturbo. «Inutile che piagnucoli e inventi scuse: tira fuori quanto devi. Non fartelo ripetere». Questo era suppergiù il tono. Se eri fortunato, o eri un giocatore di biliardo, ti spezzava solo i pollici.
Il bar tra la Centoundicesima e la Centododicesima è pieno di gente e tutti assistono alla scenata. “Il Piccolo Capo” appare ancora più piccolo di quello che è, minuscolo, umiliato davanti a tutti. Chano lo sovrasta con la sua stazza, lo sbatacchia per bene, ottiene i suoi soldi e ride di lui, non gli rompe niente, ora è un musicista di rispetto e certe cose non le fa più, e lo manda via dal Rio Bar & Cafeteria a calci in culo ridotto a un microbo di vergogna. Ma Eusebio Munoz è un boss nel quartiere e deve difendere il suo onore, non può permettere al primo arrivato di trattarlo così, a Harlem ha la sua reputazione.
Solo le nove di sera del 3 dicembre del 1948 e “El Cabito” è tornato armato. «Ehi, Chano», lo chiama per nome. Ha un sorriso beffardo stampato in volto. Tutti restano immobili. Non trema. Ride pieno di rabbia e non trema, quando Chano si volta e lui mira al cuore facendolo esplodere scaricandogli la pistola addosso. L’orisha Changò non può fare altro che restare a guardare. Come i clienti del locale. Increduli. Lui un po’ meno. È pur sempre un santo e conosce il peccato e le miserie umane. Miguelito Valdés, il cantante e amico d’infanzia di Chano, che lo aveva convinto a raggiungerlo a New York City l’anno precedente, gli ripeteva di tenersi lontano dai guai. Per lui era facile, lui era un bianco. Lo comprendeva meglio il compositore, clarinettista e sassofonista Mario Bauzá, che lo aveva presentato a Gillespie. Entrambi però alla notizia di quanto era accaduto rimasero senza parole. Non ci volevano credere neanche loro. Allibiti e pieni di dolore anche Cab Calloway, Duke Ellington e Count Basie, il giovane Tito Puente e Dizzy Gillespie che ripeteva «non è possibile, non è possibile». El Tambor de Cuba cade lentamente a terra. Sembra che Changò lo accompagni al suolo. Può fare soltanto questo, stargli vicino negli ultimi istanti di vita terrena. Chano si aggrappa a lui con la poca forza che gli rimane. «Perché non l’avevi previsto, eh? Perché non hai chiamato il balalawo? Perché non l’hai autorizzato alla divinazione? Lui l’avrebbe saputo», gli dice. «Dov’è la tavola di Ifà? Perché non mi hai protetto?» Arriva pure Santa Barbara, ha con sé un po’ di cibo, del caffè, cioccolata, un sigaro di quelli buoni e una bottiglia di rum invecchiato bene, per quando Chano sarà un eggun, uno spirito, e ne avrà bisogno. Non è mai stata così bella. «E tu dov’eri?», le chiede Chano, sempre più debole, il battito cardiaco ridotto a un sordo rumore di fondo fuori tempo; il re del ritmo senza più ritmo. «Le tue armi, i tuoi esplosivi: niente. Domani è la tua festa, vedi, ho messo la camicia bianca e la cravatta rossa, i tuoi colori. Avrei suonato i miei tamburi per te. Solo per te. Come ogni 4 dicembre. Ti piace “Cubana Be, Cubana Bop”? Ecco, l’avrei suonata per te. E “Manteca”? Oh ti avrei dedicato anche questa. Non è vero che si riferisce alla gānjā – non sarebbe troppo ironico? È un mio omaggio a te. La senti? Sta girando sul Wurlitzer 1015. Te l’avrei suonata insieme a Dizzy. Dizzy sarebbe stato d’accordo. Lui mi vuole bene. Vuole bene anche a te, me lo ha detto. Sai, bellezza, tu sei l’unica donna che mi ha resistito. Eri gelosa? Le altre non hanno mai contato molto per me. Davvero. Te lo giuro. Era te che amavo». Ma neanche Santa Barbara può fare qualcosa, se non posare i doni vicino al suo corpo e piangere un po’: lacrime sante e inutili. Non un miracolo, lacrime vere, lacrime di donna. Cosa gliene frega a New York dei santi e dei poveri amanti. Poi Chano ha un pensiero che lo fa sorridere con amarezza e il dolore al petto si fa insopportabile: «È buffo, morire per mano di un bandito da strapazzo in terra straniera. Tanto valeva crepare a L’Avana, ammazzato da un gangster vero, da uno yankee, uno di quelli che si sono impossessati della città con la complicità del caro Fulgencio Batista; oh, lui sta lì e aspetta la rivincita, che arriverà, statene certi, arriverà. Che ne so, gente come Meyer Lansky del Sindacato Ebraico di Cosa Nostra. Lui mi piaceva: i suoi modi, la sua determinazione, la sua eleganza, col Panama Montecristi». Un vero boss, che magari l’avrebbe tolto di mezzo mentre suonava in un casinò tra giovani puttane mulatte. L’Avana era la città del turismo: tradotto in dollari, del gioco d’azzardo e della prostituzione. Meglio di New York. Luciano “Chano” Pozo González muore invece con il suo brano confuso a frammenti sfocati dei suoni del carnevale cubano di cui lui era il rumbero numero uno (vorrebbe accennare un passo di danza, era un grande ballerino, ma come fa?) e al vociare già annoiato degli avventori di uno squallido bar nel quartiere dei neri, ucciso da uno con il nome latinoamericano come il suo. L’orisha Changò e Santa Barbara gli chiudono delicatamente gli occhi, si alzano e, senza guardarsi intorno, si prendono per mano. Vanno via abbracciati, tanto stretti da diventare una sola cosa, un’unica entità. Spariscono per le strade gelide di Harlem. Forse si dirigono al porto per imbarcarsi su una nave che fa ritorno a Cuba. Al caldo. In attesa di tempi migliori.
[1] Pubblicato su “Verde” del 20 marzo 2017.
 Giulia Pex, Chano Pozo
Giulia Pex, Chano Pozo
Rock Criminal è la rubrica di Sergio Gilles Lacavalla dedicata alle storie nere del rock e dintorni. Chi era Luciano Chano Pozo González? Il più grande percussionista afrocubano degli Stati Uniti, il migliore secondo Dizzy Gillespie, ma alla fine quando ti riempiono di piombo non vuol dire più niente (che ridere).
L’illustrazione inedita è di Giulia Pex.
View original post 1.735 altre parole
Seja marginal seja herói[1]
Arrivano su automobili e motociclette veloci. Vestiti di nero. Un passamontagna a celare il viso. Nessuno conosce la loro identità. Tutti sanno chi sono. Li chiamano grupos de exterminio. Sono agenti e ufficiali della polícia militar, in servizio o in congedo, non ha importanza, che agiscono oltre la legge. Ogni volta l’azione segue lo stesso svolgimento: scendono dai mezzi, sparano e spariscono per le strade di San Paolo. Lasciando morti e feriti – più che altro morti. Se hanno il tempo, danno il colpo di grazia. Se le condizioni lo permettono, decapitano anche – è capitato. Impiccano. Di solito la polizia civile e quella federale non riescono a incriminare nessuno. C’è chi ride del loro operato. Delle commissioni d’inchiesta. Un magistrato fu ucciso per le indagini sugli squadroni della morte. Anche l’obiettivo è sempre lo stesso: gli scarti del capitalismo brasiliano. Quando non ci pensano le divise grigio-azzurre, tocca agli uomini neri ripulire la città. A volte per soldi: pagati dai commercianti che non vogliono fastidi da quegli accattoni, da quei delinquenti delle favelas, o per gli introiti del controllo delle zone di spaccio di stupefacenti nelle baraccopoli – la roba migliore te la dà la polizia, fidati. Altre per vendetta. A ogni poliziotto ucciso dalla criminalità comune corrisponde la rappresaglia. Semplice, logico e lineare. Implacabile. Scordatevi la pietà qui. Ma spesso è solo per il gusto di uccidere e l’odio sociale ereditato dalla passata dittatura. Per lo stress che rende folli.
L’uomo nero è l’incubo ricorrente dei bambini dai denti grandi delle favelas. Il rumore dei motori, i passi degli anfibi, gli spari, li svegliano dai sonni agitati. Qualcuno urla. Pochi piangono. I meninos de rua sono tra le vittime designate senza che nessuno venga a reclamare i loro piccoli e deperiti cadaveri con i polmoni e lo stomaco pieni di colla. I bambini di strada rubano. I bambini di strada spacciano. I bambini di strada sono armati. I bambini di strada crescono. I bambini di strada vorrebbero morire: una dolce morte sulla spiaggia dei ricchi e dei turisti, dopo un coloratissimo e abbondante gustoso gelato. I bambini delle favelas che invece continuano a sognare, sognano di diventare tanto grandi e cattivi da fargliela pagare agli uomini in uniforme e ai loro fantasmi bui che massacrano i compagni e i propri genitori, i fratelli maggiori, gli zii. Non c’è altra ragione per sopportare una vita da schifo e miseria. Anche se nella favela niente vive a lungo. È tutto per quel poco di vita. Le baracche hanno pareti di calce e mattoni difformi a nudo. Scheggiati. Porte di lamiera e compensato. I tetti sono di eternit. Se non ti ammazzano la polizia, la droga, la cattiva alimentazione o una gang rivale, il cancro da amianto può fare molto e bene in tempi che neanche ti immagini. Le strade sono strette. Asfalto interrotto dalla terra. Fogne a cielo aperto. Nel lungo cunicolo della favela di Canão, il sole paulista quasi non filtra. Non illumina niente. È tutto così cupo nella baraccopoli di Brooklin, Zona Sud di San Paolo, che il riflesso del metallo di una pistola può accecarti. L’odore della polvere da sparo inebriarti fino a farti sentire un uomo. Ma se hai vissuto nella miseria, muori da miserabile. È la regola. La miseria non ti dà tregua. Ti segue ovunque. Tu non puoi dimenticare. Lei, non vuole. Nella favela tutto si decompone – i denti adulti di quelli che un tempo erano i ragazzini dai denti grandi, i culi alti delle ragazze presto madri sfatte, il culo si allarga e scende come i seni, gli sguardi di donne e uomini si riempiono delle lacrime da crack, sembrano sciogliersi, l’intestino si liquefa, vomiti tutto contro un muro macchiato di sangue. La memoria, però, resiste, resiste a lungo, resiste anche al rincoglionimento da droga e stenti. La memoria è odio. La memoria è eterna. Ed è inutile che cerchi di dimenticare, che speri che si possa dimenticare. Qui nessuno dimentica. Perché, altrimenti, cosa ti resta? Da qui non se ne va nessuno.
Mauro Mateus dos Santos alla fine tentò di tenere viva la sua memoria facendo rime sulla dura vita nella favela invece che nell’odio, come se questa memoria potesse essere accettata da tutti, potesse essere una possibilità di riscatto da quell’esistenza da baracca, potesse portarlo oltre il confine della miseria; povero illuso eroe e martire del rap con il nome d’arte di Sabotage. La memoria lo colpì con quattro colpi di automatica la mattina del 24 febbraio del 2003 su una strada poco fuori dalla favela di Boqueirão nel quartiere di Ipiranga, a sud di San Paolo, al 1800 di Avenida Abraão de Morais, al bairro Saúde. Aveva preso con la famiglia un appartamento nella zona residenziale limitrofa alla favela dove era nato e cresciuto e a quella dove aveva vissuto gli ultimi tre anni, per cercare un po’ di pace. Le sue canzoni non l’avrebbero reso un rinnegato. Nessuno avrebbe pensato a una fuga. Ma, come dicevamo, la memoria non dà tregua. Ti bracca. La miseria ti soffia sul collo. Col suo pesante alito di morte. Secondo la ricostruzione della polícia civil, lo spacciatore Sirlei Menezes da Silva gli sparò alle spalle dopo che Sabotage aveva accompagnato sua moglie, Maria Dalva da Rocha Viana, al lavoro e prima che si recasse a Porto Alegre dove era atteso per il Forum Sociale Mondiale. Ormai era una celebrità. Il più importante e influente rapper del Brasile con un album cronaca e manifesto della favela di Canão intitolato “Rap é Compromisso” e una promettente carriera da attore fatta di film impegnati e premiati come “O Invasor” di Beto Brant e “Carandiru”, sulla famigerata casa di detenzione di San Paolo e la rivolta e il massacro del 1992 al Padiglione 9 di centoundici detenuti per mano della polícia militar, diretto addirittura da Héctor Babenco, quello de “Il Bacio della Donna Ragno” con William Hurt e Raul Julia. Ecco, ora l’avrebbero ascoltato anche al di fuori della sua realtà e lui avrebbe parlato delle ingiustizie nelle favelas e dei soprusi della polizia. Avrebbe raccontato le sue esperienze tra droga, crimine, morte, povertà, disperazione, sconfitta, fratellanza e speranza, come faceva in tutte le canzoni. “Nella Zona Sud di Brooklin ho imparato a vivere e a rispettare ognuno”, cantava in “No Brooklin”. “Il rap è impegno, è la mia canzone a tenermi in vita”. Già, in vita. “Un altro mondo è possibile”, era lo slogan del forum dei Movimenti. Beh, lui nonostante tutto ci credeva. Per i suoi tre figli aveva sognato un altro mondo. Ma niente è possibile quando ti porti dietro quella miseria abbracciata stretta al crimine, no? Un corpo unico che ti ha legato a sé. Non puoi lasciarla per uno straccio di successo. Ma cosa credi? Sirlei Menezes da Silva non aveva dimenticato la morte di due uomini della sua fazione nella guerra tra bande per il controllo dello spaccio di stupefacenti nella favela di Vila da Paz, dove si era trasferito Sabotage dopo aver lasciato la natia favela di Canão. Sempre secondo gli inquirenti, il capo delle gang che gestiva il mercato della droga, Euclides Mendez Pessoa, fu ucciso nel 1999 proprio dal rapper che aveva messo su un traffico concorrente: Sabotage lo fece fuori in complicità con il suo socio e amico Durval Xavier dos Santos, detto Binho, assassinato poi per ritorsione il 14 ottobre del 2002 in un’imboscata a Cadeião de Pinheiros 3. La faida era continuata il 9 gennaio del 2003 con l’assassinio di Denivaldo Alves da Silva, conosciuto come Vadão, fedelissimo di Sirlei Menezes da Silva, ormai a capo dell’organizzazione, sempre per mano di Sabotage. Quindici giorni dopo, Menezes da Silva, accompagnato dal fratello di Vadão, Demilson Alves detto Bocão, chiude i conti in sospeso. Due proiettili penetrano nella spina dorsale di Sabotage. Altri due gli perforano il cranio. Muore all’ospedale di San Paolo. Un mese dopo la sua morte, verrà ucciso anche Bocão.
Il 12 luglio del 2010, il giudice Fabíola Oliveira Silva condanna Sirlei Menezes da Silva a quattordici anni di carcere per omicidio. Non credendo alla sua dichiarazione di innocenza e alle accuse per il delitto che l’imputato rivolge alla potente organizzazione criminale Primeiro Comando da Capital. La moglie e i figli non credono invece che Mauro Mateus dos Santos sia stato ammazzato per i legami con la malavita. Sostengono che da tempo era lontano da certi giri. Anzi, smentiscono ogni suo coinvolgimento in attività illegali e gli arresti di anni prima per detenzione di arma da fuoco e spaccio di stupefacenti di cui parlarono i giornali. Tutto troppo facile: uno spacciatore in carcere e un altro morto.
Un’automobile bianca da tempo seguiva Maria Dalva da Rocha Viana. Per questo Sabotage l’accompagnava in ogni suo spostamento. Sabotage fu trovato agonizzante a terra vicino alla sua macchina. Poco più in là c’era un passamontagna nero.
In tribunale, un testimone disse di aver visto Sirlei Menezes da Silva festeggiare la morte di Sabotage. Ma qualcun altro affermò che a festeggiare fossero uomini della polícia militar. Non lo disse però in aula.
“Assassini in divisa, cerca di correre in qualsiasi modo per proteggerti”. (“Favela Sinistra”, Sabotage).
Dieci anni dopo, giusto dieci anni dopo meno qualche giorno, il 4 gennaio 2013, Laércio de Souza Grimas, DJ Lah del gruppo rap Conexão do Morro, viene ucciso insieme ad altre sei persone da uno squadrone della morte davanti a un bar a Rua Reverendo Peixoto da Silva a Jardim Rosana, ancora nella Zona Sud di San Paolo, a Campo Limbo. Da tre grandi macchine nere come i loro abiti sono scesi quattordici uomini e hanno fatto fuoco.
Altri uomini avevano sparato nella stessa zona meno di due mesi prima, il 10 novembre. C’era stato un inseguimento: due moto della polizia militare dietro a una macchina rubata con a bordo tre uomini. C’era stata una sparatoria: i malviventi avevano abbandonano l’automobile per fuggire a piedi, i militari avevano sparato colpendo a morte uno dei banditi. Un altro era riuscito a far perdere le sue tracce, per poi presentarsi in ospedale ferito. Il terzo trova rifugio in una casa a dieci metri da dove avverrà il massacro di inizio anno. Si chiama Paulo Batista Nascimento, ha precedenti per furto, ricettazione e falsificazione di documenti, è ferito anche lui ed è disarmato quando lo arrestano. C’è un video amatoriale che riprende proprio questo momento. Mostra cinque agenti che conduco brutalmente l’uomo verso la macchina della polizia, poi l’immagine si muove e fuori campo si sentono due spari. Pare che Paulo Batista Nascimento avesse provato a scappare. “Atto di resistenza seguito da morte”, e il gioco è fatto. Ma l’uomo non è ancora morto. Entra in macchina con le sue gambe e l’auto lascia velocemente il quartiere. Il canale nazionale TV Globo trasmette altrettanto velocemente le immagini, che porteranno all’arresto degli agenti Marcelo de Oliveira Silva, Francisco Anderson Henrique, Jailson Pimentel de Almeida e Diógenes Marcelino de Melo guidati dal tenente Halstons Kay Yin Chen. L’uomo è morto. Si dice che l’autore del video fosse DJ Lah.
Il grupo de exterminio sembra abbia gridato «Polizia», prima di sparare cinquanta pallottole. Poco dopo, qualcuno ha visto una delle automobili nere ripassare sul luogo del crimine per recuperare i bossoli. Ma ne dimenticano due sull’asfalto: i proiettili sono dello stesso tipo in dotazione alla polizia militare.
Per Samuel Ferreira da Silva, DJ San Mix, produttore dei Conexão do Morro, DJ Lah non aveva ripreso un bel niente, era solo uno scherzo quello di dire di aver fatto lui il video, girato invece probabilmente da un residente di Campo Limbo. Ma a San Paolo si può morire anche per uno scherzo. O per una canzone. I Conexão do Morro, come Sabotage, denunciavano nei loro testi le violenze e gli abusi della polizia. Il video di “Click, Clack, Bang” fa vedere dei giovani che scappano, soldati della polícia militar entrare nella favela con gli elmetti, i passamontagna, mimetiche e giubbotti antiproiettile, visi dipinti, uomini con le mani al muro e le gambe aperte, un misero funerale, la bara di metallo di scarto sotterrata nel campo santo della baraccopoli, la terra la copre ma non sotterra l’odio, una parete piena di piccole lapidi con le foto. Il testo parla di uniformi grigie omicide, dice di tenerti fuori dalla vista dei poliziotti, sono loro che sparano, tu prega per sopravvivere. Il suono delle sirene. “Non voglio morire […] Li vedo uccidere […] E un altro corpo è caduto […] È la legge della favela”.
Nei tre anni precedenti, altri musicisti critici nei confronti della polizia sono stati giustiziati in strada dagli squadroni della morte. L’11 aprile del 2010 Felipe Silva Gomes, DJ Felipe, e Felipe Wellington da Silva Cruz, o MC Felipe Boladão, sono stati uccisi prima di un loro concerto da due uomini scesi da una moto. Il 12 aprile 2011 toccherà a Duda do Marapé, MC Duda. 20 aprile 2012, Jadielson da Silva Almeida, MC Primo, sarò fatto fuori sul litorale paulista davanti ai suoi due figli. Il 28 successivo sarà la volta di Cristiano Carlos Martins, conosciuto come MC Careca. In varie zone di San Paolo e sempre nel “mese della polizia”. Che bella festa.
Nell’inchiesta contro i cinque agenti responsabili della morte di Paulo Batista Nascimento, viene fuori un terzo colpo. È stato sparato sull’uomo dentro l’automobile. Un’esecuzione. Anche se la difesa dei poliziotti parla del tentativo di Nascimento di impossessarsi della pistola dell’agente al suo fianco. “Atto di resistenza seguito da morte”.
[1] Pubblicato su “Verde” del 20 febbraio 2017.
 Marco Cabras, Rock Criminal
Marco Cabras, Rock Criminal
Rock Criminal è la rubrica di Sergio Gilles Lacavalla dedicata alle storie nere del rock e dintorni. Mauro Mateus dos Santos era un povero illuso, un eroe e un martire del rap brasiliano, noto con il nome d’arte di Sabotage: “la memoria lo colpì con quattro colpi di automatica la mattina del 24 gennaio del 2003”, alla vigilia del Forum di Porto Alegre.
Illustrazione di Marco Cabras.
View original post 2.242 altre parole
SIN CITY[1]
A Las Vegas ci vai per morire. Che tu lo voglia o no. Che tu lo sappia o no. Anche se sopravvivi, sei morto. Las Vegas è per chi ormai è perduto. Banditi, ex politici, cantanti col parrucchino o con il viso tirato dal lifting e playboy abbronzati fuori tempo massimo. Pensionati e turisti illusi che quella sia la vera vita. Che sia ancora un po’ di vita. La più lunga possibile, quasi fino all’eternità dei miti in 70 millimetri. Come le coppie, più o meno giovani, che si sposano nelle cappelle dalle insegne colorate al neon con il coupon dell’agenzia di viaggi tutto compreso, anche Elvis e Marilyn a fare da testimoni. Entrambi vestiti di bianco, come la sposa col mazzetto di fiori in mano offerto dal finto prete. Durano un attimo i matrimoni a Las Vegas: il tempo di riprendersi dalla sbornia. Sono unioni che celebrano gli errori e la fine dell’amore. Il divorzio altrettanto rapido messo a pietra tombale e prezzi vantaggiosissimi. L’ossigeno diffuso dai condizionatori d’aria nei casinò ti tiene su e perennemente sveglio in una replica di esistenza che ti dice che puoi vincere una mano su quel che ti rimane della tua inutile e disperata vita. Un’altra ancora. E ancora una. Ma non è che accanimento terapeutico. Il banco vince sempre. L’ossigeno è per i malati terminali. Sulle pareti delle case da gioco non ci sono orologi. Niente finestre. La morte è l’assenza di tempo. È la luce sempre accesa. Negli interni sfarzosi che riproducono la Roma imperiale o altri fantastici sogni esotici all’americana, roba per cowboy che sanno di stalla e profumi costosi quanto gli Stetson che non si tolgono mai, per giapponesi ed europei che non sanno nulla del loro paese né degli Stati Uniti. Luce di notte nelle grandi vie a troppe corsie; luci cittadine che spente di giorno mostrano il loro inganno di insegne di plexiglass. Luci morte. Gli alcolici gratuiti e disponibili in ogni momento serviti dalla cameriera col culo scoperto e i seni chirurgici in bella mostra ti tolgono quel residuo di coscienza che ti rimane. Rilassati, tanto ormai se sei qui è perché il salto dal mondo dei vivi l’hai già fatto, no? Ti manca solo un breve pezzo di strada. Su, non fermarti adesso. Le portefinestre sui balconi dei piani alti degli hotel che danno sulla Strip sono sbarrate perché non è quello il modo. Meglio lanciarsi dalla diga di Hoover. Meglio il deserto intorno, pieno di carcasse di animali morti. Las Vegas ti fa a pezzi: pezzi di fiches lasciati sul tavolo da Black Jack, pezzi di sesso e sentimenti dimenticati in una stanza d’albergo, slip, calze di nylon, una cravatta da sera e smoking a noleggio sul letto vicino al frigobar e la slot-machine, pezzi del tuo corpo dilaniato seccati dal sole sul terreno roccioso e spaccato, conservati dal repentino freddo della notte.
C’era un uomo. Un cantante. Di lui, di Nathaniel “Buster” Wilson, voce basso dei Fabulous Coasters (Fabulous, proprio come il cartello che ti accoglie in città: “Welcome to Fabulous Las Vegas Nevada”), non restarono che pezzi per riconoscere il cadavere alla morgue dell’ufficio del coroner. Braccia e gambe furono ritrovate sparse in prossimità della grande diga a ventinove miglia dal centro. In seguito il resto del corpo, gettato in fondo al Del Puerto Canyon di Modesto nella confinante California, soffiato dal vento radioattivo del deserto. La testa, mezza staccata dal collo, presentava alcuni fori di proiettile. Le impronte digitali cancellate con l’acido. Il tutto in avanzato stato di decomposizione. Provarono a ricomporre il corpo. Ne mancava ancora qualche parte. A Las Vegas le cose non coincidono mai. L’identificazione avvenne attraverso l’arcata dentale. Sembrava che quello smembramento sintetizzasse lo stato in cui erano caduti i Coasters nel corso del tempo: si erano frammentati in varie formazioni, alcune false; pezzi di un corpo morto con abiti in lamé di cui ormai era impossibile trovare la forma originale. Sì, quel Fabulous puzzava di morte e cause legali per dividersi anche il nome, un marchio. Las Vegas era il luogo giusto per loro, che si esibivano come zombie tutto sorrisi, balletti e grandi voci. Ognuno voleva un pezzo dei Coasters.
Ma i Coasters non rendevano più come un tempo, quando erano il gruppo doo-wop di maggior successo dell’America degli anni Cinquanta e Sessanta con hit come “Poison Ivy” e “Charlie Brown”. Ci si chiedeva sempre, a ogni loro esibizione, davanti a ogni locandina, ma saranno davvero loro? Nessuno ci capiva più niente. Così, il manager dei Fabulous Coasters, Patrick Cavanaugh, ex agente di Marvin Gaye, a suo dire, pensò bene di arrotondare i guadagni mettendo su un giro di assegni falsi, rubati e a vuoto per circa 450.000 dollari, tra Arizona, Colorado, Nevada e California, in cui voleva coinvolgere anche “Buster” Wilson.
«No, non se ne parla», disse Wilson, nervoso, deciso. «Ti denuncerò alla polizia. Sei finito come nostro agente».
«Sei uno stupido, “Buster”. Proprio uno stupido, Non ti conviene», rispose Cavanaugh, con aria di sufficienza, col tono di un sinistro avvertimento.
Forse non stupido. Di certo imprudente. Nathaniel “Buster” Wilson avrebbe dovuto fingere di stare al gioco. Bluffare. Non svelare le carte. E poi, sorpresa: manette e tutto il resto. Ma a Las Vegas si va per perdere. Come dicevamo, per morire. Le pallottole della pistola di Cavanaugh gli perforarono il cranio il 7 aprile del 1980.
Nel 1984 Patrick Cavanaugh fu condannato alla pena di morte per omicidio di primo grado, poi commutata in ergastolo. Con lui vennero ritenuti colpevoli di favoreggiamento, falso, truffa, furto, furto con scasso, la sua quarta moglie, l’ex spogliarellista di Las Vegas Diana Lea, e il suo socio Joseph Cioffe. Furono tutti inchiodati dalla testimonianza della terza moglie di Cavanaugh, Pamela, che disse in tribunale di essere stata minacciata dall’ex marito di fare la stessa fine di Wilson se non avesse partecipato a quel traffico.
«Per spaventarmi mi mostrò un braccio di Wilson dentro un secchio», disse al giudice.
Patrick Cavanaugh morirà il 12 aprile del 2006 nel carcere di massima sicurezza al 4569 della North State Route di Ely, nel Nevada, per la cancrena alle gambe provocata dal diabete. Prima che gliele amputassero.
Las Vegas si beffa dei suoi animatori. Ne butta i resti sulle strade del suo divertimento. Solo chi è morto cerca il divertimento. Solo i morti ti fanno divertire.
Cornell Gunter però non voleva essere un’altra vittima dei Coasters e di Las Vegas. Lui era uno della formazione classica, quella del 1958, quella entrata nel 1987 nella Rock ‘n’ Roll Hall of Fame. Non scordatevelo. Era, nonostante tutto, pur sempre “la Regina dei Coasters”. Non sembrava neanche invecchiato. Il più divertente e glamour del gruppo, con i suoi abiti sgargianti sul corpo da peso massimo di pugilato o wrestling (come lottatore al Caesars Palace avrebbe fatto faville) che facevano invidia al miglior Liberace (per non parlare dell’acconciatura dei capelli), voleva vivere come non mai e rilanciare la propria carriera, mettendo in ombra con una nuova luce accecante tutti quei pezzi dei Coasters in giro per gli States. Aveva da poco finito di registrare un disco ai Paramount Studios di Los Angeles e voleva ripartire proprio da quella Las Vegas che, malgrado le tante serate fatte nei suoi hotel casinò, guardava ancora a bocca aperta come un bambino e attraversava al passo instancabile dei suoi deliziosi atteggiamenti effeminati che avevano così tanta presa sul pubblico – per la comunità gay era quella che si dice un’icona. Jerry Lewis, negli anni Ottanta, lo chiamò, con i suoi Coasters, per ben quattro edizioni consecutive del “Jerry Lewis Telethon”. Una trasmissione televisiva di enorme popolarità in onda dal 1966. Il comico e Cornell erano irresistibili quando cantavano e ballavano il successo del 1958 ”Yakety Yak”: Jerry Lewis con la sua voce e i movimenti da ragazzino sciocco e Cornell Gunter con i modi da boy di prima fila del più grande spettacolo di Las Vegas e l’inimitabile voce da tenore nero. Sorriso bianchissimo a sessantaquattro denti e giacche celeste confetto, bianco neve, nero glitter e rosso aragosta, gilet abbinati con raffinato gusto, candide camicie merlettate. Il Lady Luck Hotel aveva ingaggiato Cornell Gunter & The Coasters per un week end di concerti. Era lunedì 26 febbraio del 1990, meno di una settimana alle date annunciate dai manifesti sulle porte e i muri delle lussuose torri del centro alberghiero al 206 N 3rd Street di Downtown. La Signora della Fortuna tiene il sorriso e il cuore aperti per lui e i suoi elegantissimi ragazzi. Sono le undici del mattino e Gunter è fermo nella sua Camaro azzurra del 78 in un parcheggio all’incrocio tra la Berg Street e Bourboun Way a North Las Vegas. Sta parlando con un giovane uomo di colore di circa vent’anni. Il ragazzo indossa una giacca argentata con tre strisce nere sulle maniche e sul davanti ha lo stemma del Las Vegas Players Club. È fuori dalla vettura al lato del guidatore. Non si sa cosa si stanno dicendo, ma un testimone dice che all’improvviso il tale ha tirato fuori una pistola da una tasca e ha esploso sei colpi verso il cantante. Sembrano colpi sparati in maniera confusa. Solo due vanno a bersaglio. Cornell Gunter riesce a mettere in moto, ma fa pochi metri. Le pallottole entrate nel petto lo hanno ucciso. La macchina si è andata a schiantare contro un muro, mentre il ragazzo si è dileguato nelle strade e nessuno riuscirà mai a scoprirne l’identità. “A Las Vegas puoi fare qualunque cosa, nessuno verrà mai a saperlo”, dice un famoso slogan cittadino. La polizia esclude ogni collegamento con l’omicidio Wilson – i colpevoli sono tutti in prigione. E poi sono passati dieci anni. Anche la pista della droga è presto accantonata. Cornell Gunter non era un tossico. Forse qualche debito con la mafia locale (La Las Vegas del divertimento non dimentichiamoci che fu edificata intorno al Flamingo Hotel del gangster Bugsy Siegel fatto fuori da Cosa Nostra proprio per debiti). Ma anche questa pista sarà presto messa da parte, nonostante le difficoltà finanziarie in cui versava Gunter, al punto che i suoi funerali saranno pagati dagli amici Sammy Davis Jr. e Bill Cosby. La rivalità con le altre formazioni dei Coasters? Ma andiamo. Con Carl Gardner, il leader della line-up originale, colui che deteneva i diritti del nome, era in buoni rapporti. Forse un tentativo di rapina. Forse è stato solo un approccio finito male tra un prostituto e il suo cliente. Forse avevano già avuto un incontro la notte precedente e c’era stato un litigio, non lo aveva pagato, pratiche sgradite, rancore. Un nuovo giovane amante che voleva sempre di più. Chissà. Anche comprarsi l’amore è un modo per morire a Las Vegas. In ogni caso, la Signora della Fortuna cambiò espressione: ora non rideva più. Sembrava avesse gli occhi lucidi. Forse erano solo irritati, per via del sole atomico che gli sbatteva contro. Prima di essere sostituita con un’altra insegna di plastica.
All’uscita della città, lo stesso cartello sulla Las Vegas Strip che dà il benvenuto, sulla facciata opposta dice: “Drive Carefully. Come Back Soon”.
[1] Pubblicato su “Verde” del 23 gennaio 2017.
 Joydidì, Insomnia
Joydidì, Insomnia
Rock Criminal è la rubrica di Sergio Gilles Lacavalla dedicata alle storie nere del rock e dintorni.C’erano un uomo, un cantante, un giro di assegni falsi, un corpo fatto a pezzi, una città dove si va per morire e un braccio dentro un secchio; e poi c’erano The Coasters, “il gruppo doo-wop di maggior successo dell’America degli anni Cinquanta e Sessanta.”
Illustrazione di Joydidì (Insomnia, ink on paper, digital painting).
View original post 1.854 altre parole
Canto di Natale[1]
C’è una strada che unisce due automobili. Una è abbandonata nel parcheggio di un aeroporto. È una Lincoln nera. L’altra, una Cadillac Seville bianca, è finita in fondo a un fosso lungo un argine. Sono distanti due mesi e alcune miglia. La strada è una strada di pioggia, ghiaccio e sangue. Per oltre tre anni quasi nessuno aveva notato tutto quel sangue che strabordava dai finestrini dei veicoli. Rendeva il percorso estremamente scivoloso. L’asfalto ne era inzuppato come i rivestimenti in pelle dell’abitacolo. Quasi nessuno aveva tracciato una linea tra quelle due vetture. Eppure era così evidente. Ovvio. Banale. Terribilmente banale. Bastava guardare in un punto preciso e segnare le coordinate. Seguire la strada da quel punto. Le auto della polizia facevano avanti e indietro senza mai notare niente. Gli agenti si fermavano in uno di quei bar che ti servono un panino, patatine con la salsa e una Cola in macchina, a parlare delle loro famiglie e della star scomparsa. Era su tutti i giornali. Via via in notizie sempre più piccole. Sempre più locali. Ripartivano per una segnalazione dalla centrale. Un eccesso di velocità. Una rapina. Un sorpasso azzardato. Spesso sbandavano e andavano a sbattere sul guardrail delle indagini. Niente. Anche se qualcuno individuò subito quel punto che aveva in sé la soluzione. Era la soluzione. Ma non c’era il corpo. C’è un video amatoriale dove il punto è inquadrato più volte. È dentro una casa. Pare ci sia una festa. Natale è da poco passato. L’albero illuminato e tutto il resto. Forse è il Capodanno. Probabilmente qualche giorno prima. Dovrebbe essere il giorno successivo alla sparizione. Il 28 dicembre 1983. Sessantanove giorni dopo l’incidente. L’incidente era stato mortale. La sparizione non fa presagire niente di grave. Almeno così dice la moglie dello scomparso. Non i genitori: «Abbiamo capito subito che era accaduto qualcosa di brutto a nostro figlio», dichiararono. La camera inquadra quel punto e lui sorride imbarazzato. Lei fa la svampita. Allegra. C’è qualche amico. Tutti si chiedono dove sia finito il padrone di casa. Ma lei continua a ridere e a mostrarsi spiritosa. Esageratamente brillante. Non sembra essere preoccupata della sua assenza. Lui ci prova. Ci prova a ridere. Ma il sorriso è contratto. Appena nervoso. Più falso di quello di Babbo Natale. Con il vestito rosso e la barba bianca di ovatta potrebbe essere un buon Babbo Natale da centro commerciale: i bambini paralizzati dalla paura o dalla vergogna sulle ginocchia robuste e i genitori con i sorrisi inconsapevoli e stupidi delle festività a scattare ridicole foto da cinque dollari. Indossa, invece, un maglione con il collo a V, simile al cardigan che il proprietario dell’abitazione portava in “American Bandstand”. Ma non ha lo stesso fisico. Nessuno ballerebbe davanti a lui come facevano i ragazzi del programma della ABC presentato dal mitico Dick Clark. La casa però è ben riscaldata e non c’è bisogno di muoversi. Il Super 8 si avvicina di più: c’è inequivocabilmente scritto lì cosa sia successo. In quella faccia grossolana e colpevole che il sergente Steve Roach e il capitano Wes Simcox dell’ufficio dello sceriffo della contea di St. Charles avrebbero preso volentieri a schiaffi. Dopo averlo ammanettato e portato via. Lei con lui. Ma la macchina è al Lambert St. Louis Airport, il fiume Missouri nelle vicinanze è ghiacciato in più tratti: nessun cadavere vi può scorrere senza intralci. Anche il lago vicino alla residenza della famiglia Notheis su Pershing Lake Drive è coperto da una lastra di ghiaccio: impossibile caderci dentro. Buono tutt’al più per pattinarci sopra come in una striscia di Charlie Brown. E poi chi ha detto che uno scomparso sia automaticamente morto? Anche se lo scomparso è un cantante un tempo famoso, Walter Notheis Jr., conosciuto come Walter Scott, e sua moglie, JoAnn Calcaterra in Notheis, sposata da quattordici anni, è una donna gelosa. Anche se l’uomo che si trova nella loro casa e prova a sorridere è il suo amante. Lui si chiama James H. Williams Sr., è il titolare di una ditta di impianti elettrici e un farabutto. Sapete come vanno certe faccende: il marito non c’è mai, sempre in giro per concerti, l’elettricista fa i lavori nella sua abitazione e non ci vuole molto a colmare la solitudine. La gelosia, beh quella è un’altra storia.
«È stata la cosa giusta da fare».
«Io non volevo questo».
«Tu lo volevi quanto me».
«Non è vero».
«Sì che è vero».
«Non così».
«Ora smettila di fare l’isterica, tra un po’ arrivano gli ospiti. E tu devi sorridere. Lo volevi quanto me… Ti amo».
«Anch’io ti amo… Sharon, è stato un incidente, non è così? Solo un incidente».
Lui non risponde. Dice soltanto: «Dai, lasciala stare, e vatti a preparare».
Walter Scott faceva il cascamorto con tutte – per questo Doris, la prima moglie, sposata nel 1963, nel 1969 aveva divorziato. Malgrado fosse ormai una star del rock’n’roll sul viale del tramonto, le donne ancora gli cadevano ai piedi. Il bel cantante di Bob Kuban and The In-Men non aveva resistito al successo di “The Cheater” – il singolo al dodicesimo posto nella hot 100 di “Billboard” nel marzo del 1966 che aveva portato nelle chart anche l’album “Look Out for the Cheater” e la cover di “Drive my Car” dei Beatles. E la sua fama si era spenta, dopo l’abbandono del gruppo proprio nell’agosto di quell’anno di euforia, in una mediocre carriera come bandleader dei Guise e poi da solista con la Musicland. A neanche quarant’anni girava con il suo gruppo per locali di terza categoria come una cover band dei bei tempi andati. Il ciuffo cotonato, la voce profonda e lo sguardo seducente da cantante confidenziale che si accendeva paraculo quando intonava il ballabile “The Cheater”. Il pubblico non aspettava che quel momento. “Il baro” prendeva di mira una fan, di quelle un po’ fuori moda che seguono la band fuori moda in un club fuori moda, e dopo averla scaldata con il suo miglior repertorio romantico, non la lasciava fino a quando non se l’era sbattuta nella sua stanza d’hotel. JoAnn lo sapeva, come poteva non sapere delle scappatelle del marito? Andiamo. Ma le tollerava perché, appunto, erano delle scappatelle. I soliti piccoli tradimenti di letto da una notte e via della rockstar con la groupie. Faceva parte del gioco. Ci devi stare. Altrimenti sposati un impiegato di banca e buonanotte.
Ora però c’era la sua nuova corista e ballerina dall’avvenenza che JoAnn se la sognava. Adesso era una cosa seria. “L’imbroglione”, “Il traditore” dei cuori altrui faceva sul serio con lei. Basta con quei locali squallidi e le fan di seconda mano. Per lei voleva qualcosa di più dignitoso. Quei localetti puzzavano di fallimento e fine carriera. E lui invece era tornato a desiderare il profumo inebriante dei giorni di gloria. Per lei. Per lei e lui insieme. Come le grandi coppie del rock. Quanta ammirazione. Quanta invidia. Ecco, di nuovo il successo riunendo la band per il ventennale della fondazione. Ne avevano già parlato. L’avevano annunciato alla televisione. Con Bob Kuban avevano fatto anche una prova per il concerto al Fox Theatre di Saint Louis. Mica l’ultimo dei teatri. Al 527 N di Grand Blvd avrebbero registrato il tutto esaurito. Il cartello di sold out su ogni porta. I fan in delirio. Il grande ritorno, previsto per il 23 giugno 1984, dei favolosi Bob Kuban and The In-Men nel “Fabulous Fox” appena restaurato, con i suoi quattromilacinquecento posti di poltrone di velluto rosso e i lampadari di cristallo. Avevano parlato, suonato e si erano fatti gli auguri di Natale. Promettendosi un tour e un disco per il nuovo anno. Magari li avrebbe ripresentati Dick Clark. Ma ci pensate? Dick Clark in persona. «Ladies and Gentlemen, Bob Kuban and The In-Men!» Applausi fragorosi. Urla. Qualche svenimento. «… For now, Dick Clark – so long!» E il consueto saluto militare del re dei conduttori. C’era da avere i brividi.
E poi sì, basta anche con sua moglie. Walter Scott aveva preso un appartamento in affitto in un elegante palazzo in centro. Si sarebbe trasferito lì con il suo giovane e bellissimo amore dai capelli biondissimi e le gambe lunghissime. Probabilmente sapeva del tradimento di JoAnn, ma non gliene importava un fico secco. «Meglio così», si diceva: niente alimenti. JoAnn l’avida. «Non devi darglielo per nessun motivo», disse Scott al tecnico del suono che aveva registrato, di fretta, in cinque notti, il suo nuovo disco. «Per nessun motivo mia moglie deve avere questi master-tape. Siamo intesi?» Walter Scott era pronto a una nuova vita. Ma poteva mai JoAnn sopportare la sua nuova esistenza? Walter Scott aveva un brutto presentimento.
«E adesso?»
«Stai tranquilla, ho già sistemato tutto».
«Ho paura».
«Ma non sei contenta?»
«Non lo so… sì».
Pioveva che Dio la mandava, quel 20 ottobre in cui la macchina di Sharon Williams uscì di strada. Lo schianto. La testa deve aver sbattuto. Lei va in coma irreversibile. Tredici ore dopo il marito autorizza l’espianto degli organi. Il caso viene archiviato come incidente.
La scomparsa di Walter Scott è un fascicolo aperto.
Ma rimangono le due automobili. In quella accidentata ci sono odore e tracce di benzina, però il serbatoio non è rotto. La pioggia ha spento l’incendio. Sharon viene trovata dai soccorsi con le gambe verso lo sportello del passeggero, il corpo è scivolato dal sedile. La testa è sotto il volante. Questo perché il sedile del guidatore era stato spostato indietro. Come per dare spazio a qualcuno molto più alto della minuta Sharon. La caduta della macchina non è stata veloce. La botta non è stata violenta. L’auto non ha riportato grossi danni. Ed è precipitata con la parte anteriore in giù. Le ferite sul capo della vittima sono due. E non sono sul viso, ma sulla nuca. La donna è stata colpita con grande forza da un corpo contundente. A questa conclusione arriverà nell’aprile del 1987 la neuropatologa dottoressa Mary Case che darà una svolta al caso di Walter Scott ritenendolo collegato alla morte di Sharon Williams. Il punto.
Nella macchina di Walter Scott non c’è niente. Alla reception dell’aeroporto nessuna prenotazione di un volo a nome del cantante. L’automobile è stata portata lì da qualcuno che voleva far pensare a un viaggio in chissà quale lontana località. Senza alcun motivo. Una fuga inspiegabile per chiunque. Un improvviso abbandono del tetto coniugale. JoAnn, a due giorni dalla scomparsa, annullerà ogni impegno del marito.
Tre anni dopo va dicendo a tutti che il suo nuovo cognome è Williams.
Gli uomini dell’ufficio dello sceriffo non ci mettono niente a ricollegare le due autovetture. Le due morti. Walter Scott è stato ucciso il 27 dicembre da James H. Williams Sr. Quasi sicuramente in casa. A sorpresa. Mentre si alzava dal divano per prendersi qualcosa da mangiare davanti a una trasmissione tv. Su segnalazione del figlio del sospettato, interrogato in un carcere della Florida dove è rinchiuso per un piccolo reato di droga, la polizia di St. Charles il 10 aprile del 1987, dieci giorni dopo la riesumazione della salma di Sharon Williams, scoperchia una cisterna mascherata da aiuola nel giardino della casa di James H. Williams Sr. su Gutermuth Road, a cinque miglia dalla residenza degli ex coniugi Notheis. Lì c’è il corpo semidecomposto di Walter Scott: indossa una tuta da jogging blu con righe laterali bianche e rosse regalatagli per Natale dai suoi genitori. Ai piedi ha i calzini ma non le scarpe. I polsi, le ginocchia e le caviglie sono legati da corde gialle. Ha un buco di arma da fuoco che dalla schiena trapassa il petto. Sembra di una pallottola sparata da un fucile ad alta potenza. Forse un’arma da guerra. Quando gli agenti della scientifica e i vigili del fuoco tirano fuori il cadavere che galleggia nell’acqua, la testa si stacca dalla spina dorsale.
James H. Williams Sr., il 9 novembre 1992 verrà riconosciuto colpevole di duplice omicidio e condannato dal tribunale di St. Louis a due ergastoli, senza possibilità di richiedere la libertà condizionale. Morirà nel carcere di massima sicurezza Potosi Correctional Center nella contea di Washington, Missouri, alle 7 e 50 del mattino di domenica 11 settembre 2011, a causa di un infarto mentre era ricoverato in infermeria. Senza aver mai confessato i suoi delitti. Per JoAnn, accusata di favoreggiamento, la condanna sarà a cinque anni. Entrerà in prigione nell’aprile del 1993.
Le immagini televisive del loro arresto mostrano un uomo e una donna dall’aspetto comune. Insignificante. Gli amanti diabolici erano brutti.
[1] Pubblicato su “Verde” del 19 dicembre 2016.
L’ultima puntata del 2016 diRock Criminal, la rubrica di Sergio Gilles Lacavalla dedicata alle storie nere del rock e dintorni, non poteva che essere un racconto oscuro ma – dunque – natalizio: Walter Scott, The Cheater, era pronto a una nuova vita. Walter Scott, l’imbroglione, aveva un brutto presentimento. Walter Scott, il baro, è stato ucciso il 27 dicembre 1983.
L’illustrazione è diValentina Maini (Le fil).
View original post 2.072 altre parole
Mater Memoriae[1]
Atto unico
In un appartamento. Spoglio. A parte un piccolo tavolo con delle bottiglie di liquori e due bicchieri. Una finestra che dà sulla strada. La luce di un lampione illumina la stanza. È sera.
Lui e Lei.
LUI No, non ti conosco.
LEI Guardami bene.
LUI No. Non ti conosco… Somigli a mia madre, gli stessi occhi truccati di nero… ma non ti conosco.
LEI Ne sei sicuro?
LUI Sì.
LEI Diciamo che non ti ricordi.
LUI E va bene, se proprio vuoi: diciamo che non mi ricordo. Mi ricordo i suoi occhi truccati di nero, quando doveva uscire la sera. Il rossetto rosso, come il tuo. Luminoso. Gli abiti eleganti. E sexy. Ricordo che erano eleganti e sexy, sì, ma non ricordo mai come fossero. Dei vestitini scollati. Suppongo. Corti. Lunghi. Una gonna e camicetta. Tre bottoni aperti. Si vedeva il reggiseno. Scarpe con il tacco a spillo, immagino. No, proprio non ricordo. Il profumo era dolce. Ricordo che sapeva di frutti e fiori, questo lo ricordo bene perché mi baciava sulla guancia e lei era tutta in quel profumo. Probabilmente per questo non ricordo i suoi vestiti. Mi guardava, con quegli occhi così neri. Era davvero tutta in quel profumo e in quegli occhi. Nerissimi. Bui. Lei, al contrario, era solare, seppur con qualche ombra, ma cercava di non darla mai a vedere. Mi lanciava un ultimo bacio prima di lasciare la stanza. Ero ancora in salone e la televisione era accesa. Non ricordo cosa trasmettesse. Di certo non il notiziario. I bambini non si lasciano davanti a un notiziario. Non c’erano neanche i cartoni animati: la sera non trasmettono mai i cartoni animati. Neppure un gioco a premi o un reality, un talent show: lei non sopportava certi programmi. Diceva che rincretiniscono. A questo punto non restava che un film. Inutile provare a ricordare. Ricordo solo quel bacio lanciato dalla bocca con le dita e lo sguardo nero. A volte ci soffiava, sulle dita. E io il bacio lo sentivo arrivare davvero. Sorrideva. Lasciava la stanza. La sentivo attraversare il corridoio. Sì, i tacchi dovevano essere a spillo. Apriva la porta e parlava con qualcuno sul pianerottolo. Non capivo cosa dicessero le due donne. Erano due voci femminili. Ne sono certo. Ma non sono sicuro che fossero due. A volte mi sembrava che mia madre parlasse da sola. La stessa voce. Si faceva delle domande e si rispondeva. O comunque si diceva delle cose. La corrente fredda giungeva fino a me. Anche d’estate era fredda. Portava ancora una scia del suo profumo. Guardavo la tv ma, niente da fare, non riesco a ricordare cosa stessi vedendo. Che film fossero. Di certo film d’avventura o fantastici. Cose adatte ai bambini. Non li ricordo perché ero distratto dal profumo e da quelle parole che sentivo fuori la porta. Non le capivo perché si confondevano con quelle della televisione. Passavano solo pochi minuti, a volte erano secondi, poi la porta di casa veniva chiusa. Ricordo anche il rumore dell’ascensore. Il rumore attutito della porta a molla dell’ascensore che si chiude. Una di quelle porte di metallo che danno l’idea di chiudersi sbattendo e invece negli ultimi centimetri rallentano frenate dalla molla. O da un meccanismo del genere. Le corde portavano la cabina giù. Abitavamo all’attico. Non era possibile sentire l’ascensore aprirsi al piano terra. Mentre l’ascensore scendeva, lei tornava da me. Non era andata via. Aveva salutato quell’altra persona, o aveva smesso di parlare con se stessa, ed era rientrata. Pochi minuti di assenza, sì. A volte soltanto alcuni secondi. Ma quando tornava sembravano passati vent’anni. Era diventata d’un colpo più vecchia. No, non più vecchia: vecchia non è la parola giusta. Più grande, ecco: più grande. Mia madre era molto giovane, avrà avuto ventiquattro o venticinque anni, e quando rientrava era una donna adulta. Sembrava sempre una ragazzina, mi ha messo al mondo che aveva appena diciassette anni, me lo raccontava spesso, senza rimpianti però, con gioia e soddisfazione, con orgoglio. Poi chiudeva la porta ed era adulta. Ma era lei. Non posso sbagliarmi. C’erano momenti in cui ne dubitavo. Ma era lei: gli occhi truccati di nero e il profumo. Il rossetto. Ho sempre pensato che il rossetto avesse un sapore di ciliegia. Un giorno l’ho cercato in un suo cassetto per assaggiarlo. Non l’ho trovato. Penso lo tenesse nella borsa. Non avevo il coraggio di frugare nella sua borsa. Era senza dubbio lei, solo sembrava più grande. Tutto qui. Restavamo seduti sul divano a guardare i programmi televisivi. Io in realtà non li guardavo. Guardavo lei. Di sbieco. Senza farmi notare, anche se credo che si accorgesse che la osservavo. Faceva però finta di niente. Dopo un’ora o due mi metteva a letto. Non parlava mai. Non parlavamo mai. Mi dava soltanto il bacio della buonanotte. Profumato e rosso. La mattina dopo mi faceva trovare una bellissima colazione. Ogni volta che doveva uscire, ogni volta che si truccava in quel modo, tutte le volte che si metteva i suoi vestitini sexy, dico vestitini perché era molto minuta, esile, e quegli abiti sensuali erano anche graziosi, poi sulla tavola c’era una colazione ricchissima: ciambelle glassate al cioccolato, bombe alla crema, biscotti al miele e all’arancia ricoperti di cacao, tortine alla fragola e ai mirtilli, pasta di mandorle e latte e caffè.
«Dai, ogni tanto puoi berlo il caffè», mi diceva.
C’era pure la cioccolata, con tanta panna. Tutta roba fresca. Come appena sfornata.
Lei mi diceva «Mangia».
E io mangiavo, contentissimo per tanta bontà e perché quei dolci me li aveva portati lei. Erano più buoni perché me li aveva portati lei, capisci? Erano un suo dono. Mi guardava soddisfatta.
«Sono buoni, vero?» mi diceva indicando i dolci. Io annuivo con la testa.
«Mangia tutto quello che vuoi. È per te».
Sembrava felice. Anch’io ogni tanto la guardavo, sollevavo lo sguardo da tutto quel ben di Dio per incrociare, con la bocca piena, i suoi occhi. Non erano più truccati di nero. Il rossetto sulle labbra non c’era più. Certe mattine le labbra ce le aveva leggermente screpolate. Non usava il burro di cacao. Diceva che se cominci a metterlo, poi le labbra si abituano e non puoi più farne a meno. Alcune volte c’erano ancora tracce di rossetto. Sbiadite. La bocca era rosa pallido. Sembrava più piccola di quando portava il rossetto. Ancora un po’ di matita e mascara sugli occhi. Solo i residui di chi non si è struccata bene. Del profumo era rimasto solamente un vago aroma tra il dolciastro e l’amaro. Era tornata giovane, come prima di uscire, o meglio, con l’intenzione di uscire. Solo più stanca rispetto alla sera prima. Come se non avesse dormito per niente, o comunque poco. Nella felicità di quel momento c’era una malinconia che non capivo. Lei non mangiava. Non mangiava mai. Era magrissima.
«Su Mamma, prendine un po’ anche tu, dai. È troppa», le dicevo.
«No, grazie amore. Li ho comprati per te. Io non ho fame. Un po’ di caffè per farti compagnia, ok?».
(Lui si ferma nel suo racconto. Resta a pensare, in silenzio, assorto).
LEI A cosa pensi?
LUI A niente. Ti va di bere qualcosa? (Indica il tavolinetto con gli alcolici. Poche bottiglie. Alcune vuote).
LEI Sì, grazie.
LUI (Si avvicina al tavolo) Non c’è granché. Cosa vuoi? Il brandy e il whisky sono finiti.
LEI Un amaretto va bene. (Lui le serve da bere, non versa niente per sé) E tu non prendi niente?
LUI No, no non mi va niente. Non ho il ghiaccio, mi dispiace.
LEI Fa niente. Non preoccuparti. E poi l’amaretto non va con il ghiaccio.
LUI Ne sei sicura?
LEI Beh sì, non credo. (Beve un sorso). Vai avanti.
LUI Non c’è più molto da dire. Ricordo solo che un giorno mi disse che non sarebbe più uscita la sera. Ma lei in realtà non usciva. Te l’ho detto. Faceva finta. Eppure mi disse proprio così: «Non uscirò più la sera, contento?»
Era sera. Io la guardavo e non sapevo cosa risponderle. Lei allora aggiunse, con un gran sorriso: «Tranquillo amore, ti farò ugualmente la colazione che a te piace tanto. Giuro». Giurò incrociando le dita sulle labbra.
Ricordo che quando mi disse queste cose non aveva gli occhi truccati di nero né il rossetto. Nemmeno il profumo. Ovviamente. Odorava di bagnoschiuma. Spuma di Sciampagna alla rosa e vaniglia. Mi piaceva lo stesso il suo odore. Leggero. Anzi, mi piaceva di più di quando metteva il profumo ai frutti e ai fiori. Tra i fiori di quel profumo la rosa si sentiva appena. Coperta dall’aroma di qualcosa tipo orchidea e fiori d’arancio. Pera e zenzero. C’era un che di triste in quella fragranza. Soprattutto la mattina dopo. Con quel dolce un po’ amaro nei residui di ambra e muschio misti a sudore.
LEI Ne sai di profumi.
LUI Mah, insomma. Quando vado alla COIN o alla Rinascente mi spruzzo sempre sui polsi un po’ di profumo dai tester. Se le commesse non mi guardano, pure dietro le orecchie. Ne metto anche su quelle strisce di cartoncino bianco che servono come promemoria. Leggo gli ingredienti sulle confezioni e annuso i cartoncini. (Pausa).
LEI Dai, continua a raccontarmi di lei. Di quel giorno. Di quella sera.
LUI Non ricordo ancora cosa indossasse. È strano. Dovrei ricordarlo, per via dell’assenza del profumo e del trucco sugli occhi che mi distraevano dal resto. Eppure non lo ricordo. Forse aveva addosso un grande maglione. Per casa portava spesso un maglione che le arrivava a metà delle cosce. Con dei calzini di lana. Lunghi fino alle ginocchia. D’inverno. D’estate invece una camicia. Bianca o a righine blu. C’era anche una maglietta che le piaceva molto. Era di una band rock, Spiritual Front, così si chiamavano. Li conosci?
LEI (Con un sorriso) Sì, certo. (Pausa). Non c’è musica in questa casa.
LUI No.
LEI Perché?
LUI (Alza le spalle). Se è per questo non c’è neanche altro.
LEI Già, vedo. (Si guarda intorno. Lui rimane in silenzio).
LUI Comunque a volte la musica arriva da fuori. E mi basta… C’è il lampione. La sua luce fa arredamento (sorride). Non trovi?
LEI (Sorridendo) Oh sì. (Ancora una pausa di silenzio). Mi dicevi della maglietta.
LUI Era nera, con il disegno, in stile locandina di un film noir anni quaranta, di un uomo e una donna che si stanno baciando. Lei, nell’abbraccio, tiene un coltello verso la nuca di lui, l’uomo fa lo stesso sulla schiena della donna. Sono incorniciati in un teschio. Sopra il teschio c’era il nome del gruppo. Dietro, la scritta “Open Wounds Nihilist Suicide Love”. Ascoltava spesso un disco di quella band. Non ricordo il titolo né come facessero le canzoni. Non ho mai dimenticato però la copertina: c’era un gatto disegnato da C. C. Askew che piangeva immalinconito davanti a S. Pietro. Il sole tramontava dietro la cupola della basilica e il gatto cercava consolazione nel fumo di una sigaretta e suonando una dolente ballata alla fisarmonica. Quando portava quella maglietta, o la camicia, i piedi erano nudi. Tutt’al più metteva delle infradito. A volte danzava su quella musica. Altre su un disco di Nick Cave. Scalza. Se aveva le infradito, le toglieva. Era leggera. Morbida. Sognante. Ma quando si accorgeva che la guardavo, smetteva. Sembrava vergognarsi.
Non ricordo in che stagione fosse quel giorno. Quella sera. Forse aveva ancora l’accappatoio. Anzi no, lei non si asciugava mai con un accappatoio dopo il bagno. Non ho mai visto un accappatoio in casa mia. Preferiva annodarsi un asciugamano intorno al seno. Devo aver sorriso. Lei deve avermi abbracciato. A lungo e forte.
Poi mi ha regalato un albo a fumetti. Rimasi sorpreso, perché non era il mio compleanno. A ogni mio compleanno mi regalava un albo a fumetti e questa volta non era il mio compleanno. Era il numero 280 di Dylan Dog, dicembre 2009, intitolato “Mater Morbi”. Lo ricordo benissimo: il numero, gli autori, Roberto Recchioni e Massimo Carnevale, la copertina disegnata da Angelo Stano, inquietante, raffigurava Dylan Dog nel giardino della consunsione davanti all’albero degli impiccati, l’albero delle pene – beh in realtà tutte le copertine di Dylan Dog erano inquietanti, mica solo quella. Quella però mi mise addosso un certo senso di angoscia. Come tutto l’albo. Un’angoscia acerba per quell’età, ripensandoci oggi. Ma era pur sempre angoscia. Anche se ancora non sapevo darle un nome. Non paura. Angoscia. Mater Morbi era bellissima. Lunghi capelli neri, la frangetta. E voleva portare via con sé Dylan Dog, imprigionato sul letto di un tetro ospedale.
Mi disse: «Prendi, è per te, un piccolo regalo».
Non capivo perché mi avesse regalato proprio quel numero, che non era neanche quello in edicola ma era uscito già da qualche mese – probabilmente l’aveva trovato in un negozio dell’usato o in qualche fumetteria, di quelle che vendono anche gli arretrati.
«Leggilo», mi disse. Me lo disse con un sorriso triste. Gli occhi forse erano lucidi. Forse le era andato lo shampoo negli occhi. Forse i capelli erano ancora umidi. Forse aveva pianto. Non l’ho mai vista piangere. «Leggilo, amore».
LEI (Manda giù ancora un sorso del liquore, esita, poggia il bicchiere a terra, vicino alla sua borsa, dalla quale tira fuori un altro albo a fumetti. Lo porge a Lui, con delicatezza, accennando un sorriso triste). «Prendi, è per te, un piccolo regalo». (Da lontano, da fuori, arriva una canzone degli Spiritual Front o di Nick Cave & The Bad Seeds).
LUI (Sorpreso) Cos’è? (Prende l’albo, lo guarda, lo sfoglia, legge i nomi degli autori, la data di pubblicazione) Un altro fumetto di Dylan Dog. Questo è uscito da alcuni anni: numero 361, settembre 2016. L’autore della storia è lo stesso di “Mater Morbi”. Sono diversi i disegni, li ha fatti Gigi Cavenago, lui non lo conosco, deve essere nuovo, è bravo, molto bravo. Le tavole, le vignette, sembrano quadri espressionisti. È a colori. La copertina è sempre di Stano. Bello. (Solleva lo sguardo dal fumetto e guarda Lei). Non pensi però che sia un po’ grande per i fumetti?
LEI (Con ancora più dolcezza, con ancora più tristezza) «Leggilo». (Pausa, mentre fissa Lui). «Leggilo, amore».
LUI (Anche Lui la fissa, negli occhi truccati di nero. Quell’ultima frase gli ha come aperto un abisso di malinconia. E ancora un mare di ricordi. Il mare è in tempesta. Poi la bonaccia. Dopo un po’ riprende a sfogliare l’albo. Ne legge qualche pagina, dentro di sé. Lo richiude e legge ad alta voce il titolo in copertina). “Mater Dolorosa”, credo sia il seguito di “Mater Morbi”. Il ritorno della Madre della Malattia. (Solleva lo sguardo mischiandolo a quello nero di Lei). Già, ho capito: neanche tu ti truccherai più gli occhi di nero, vero?
[1] Pubblicato originariamente su “Verde” del 12 dicembre 2016.
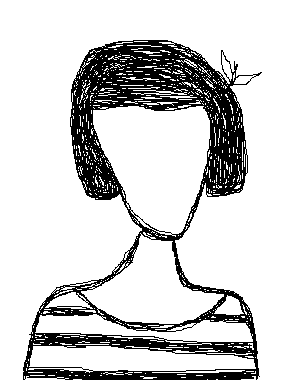 Valentina Maini, Senza titolo
Valentina Maini, Senza titolo
Sergio Gilles Lacavalla ci ha chiesto di non anticipare nulla di Mater Memoriae, per non rovinare la lettura di questo atto unico uscito da una quasi improvvisazione durante un workshop teatrale dal significativo titolo Rabbia+Stupore. Ed è una bella sorpresa ritrovare su Verde Valentina Maini, ma alle matite: ebbene sì, i suoi disegni faranno più bello il nostro dicembre.
View original post 2.436 altre parole




